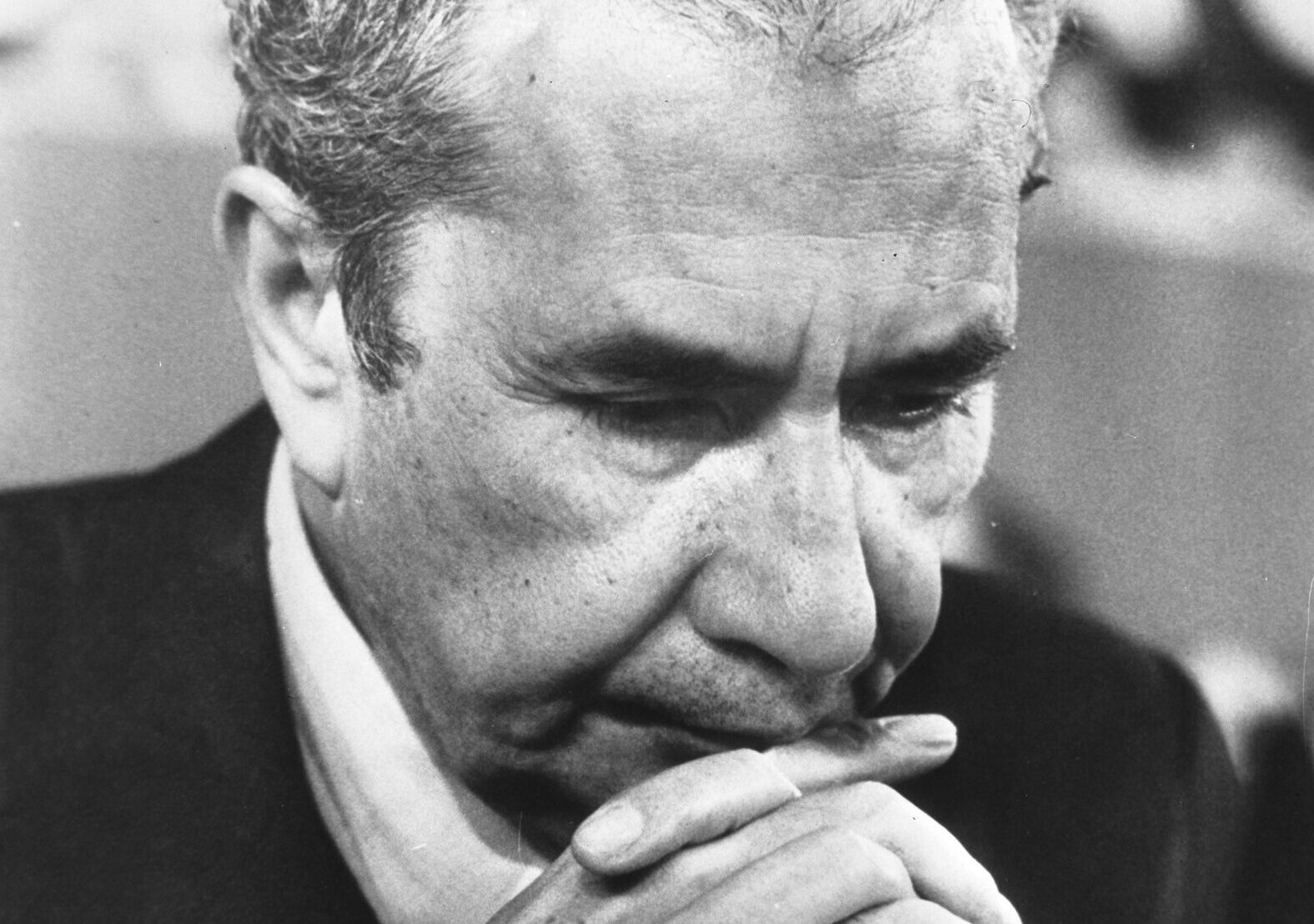Alla celebrazione dei 43 anni dalla morte di Aldo Moro, ucciso dalle brigate rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di prigionia, ha voluto partecipare anche Walter Veltroni, che allora aveva solo 23 anni e già si prenotava inconsapevolmente alla carica di sindaco d Roma nei panni di consigliere comunale. Lo ha fatto raccogliendo in un libro le interviste raccolte per il Corriere della Sera sul sequestro appunto di Moro in questo suo ritorno al giornalismo propedeutico -secondo i soliti, maliziosi retroscenisti- ad una partecipazione alla prossima edizione della corsa al Quirinale. A introdurre le interviste sono riflessioni molto amare su quel tragico passaggio della storia della Repubblica.
”Troppi silenzi e troppi morti in questa, ahimè, classica storia italiana della tanto ingiustamente rimpianta prima Repubblica. Tutto strano, tutto sporco”, ha scritto Veltroni, ma senza autocritiche, o non abbastanza avvertibili, per il contributo, quanto meno, fornito dal suo partito all’epilogo di quella tragedia, con tutti i misteri nei quali è ancora avvolto dopo tante inchieste giudiziarie e parlamentari. Alla cui parzialità non certo Veltroni personalmente, per il ruolo che aveva allora, ma di sicuro il suo partito -il Pci- ha contribuito avendo omesso di rilevare, chiarire e quant’altro cose che i suoi dirigenti non potevano ignorare per il peso che avevano dentro l’allora maggioranza di governo. E non certamente dietro le quinte, per quanto Andreotti avesse appena formato il suo quarto governo deludendo le attese che aveva alimentato alle Botteghe Oscure. Dove si aspettavano quanto meno l’esclusione dal monocolore democristiano di due ministri di cui erano state reclamate le teste salvate invece all’ultimo momento proprio da Moro: Antonio Bisaglia e Carlo Donat-Cattin, in ordine rigorosamente alfabetico. Probabilmente Enrico Berlinguer avrebbe disposto non più la fiducia concordata in lunghe trattative ma il ritorno all’astensione se il sequestro del presidente della Dc la mattina del 16 marzo non avesse creato quella condizioni di eccezionalità in cui la fiducia di entrambe le Camere, non di una sola, fu concessa in 24 ore, come in una sfida ai terroristi mossisi anche per far tornare il Pci all’opposizione e all’obiettivo “tradito” della rivoluzione.
Ricordo ancora nitidamente quella sera in cui il comune amico Enzo Bettiza mi raccontò a cena -e avrebbe poi ripetuto in uno dei suoi libri- di essere andato a trovare in mattinata il ministro dell’Interno Francesco Cossiga, al Viminale, e di averlo visto e sentito deferente e quasi intimidito al telefono con Ugo Pecchioli. Che seguiva la gestione del sequestro Moro e delle ricerche per conto del Pci reclamando informazioni sempre più precise. Lo stesso Cossiga, imbarazzato, avrebbe invitato l’ospite e amico a rendersi conto di quanto difficile fosse diventato il suo ruolo.
In prossimità del 43.mo anniversario della morte e del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro nel bagagliaio dell’auto in cui era stato assassinato, e poi posteggiata a metà strada fra le sedi della Dc e del Pci -con quella “lingua metà intrisa di sangue, indice di un’agonia non breve”, avendo “sofferto dai 15 minuti prima di spirare”, secondo chi ne avrebbe poi eseguito l’autopsia- sentite che cosa ha raccontato al Tempo il 4 maggio scorso il generale in pensione Antonio Cornacchia, allora colonnello a capo del nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma: “Al Viminale sapevano dov’era la prigione, l’aveva scoperta il generale dalla Chiesa. Lui aveva allestito Unis, un contingente di 30 paracadutisti che aspettavano in via Aurelia, in attesa di avere l’ok per entrare in azione e liberare Moro” nella non lontana, peraltro, via Montalcini. Caspita. Perché l’operazione non fu eseguita?
“Fu un’attesa vana. Andreotti -ha raccontato il generale- non diede mai via libera e cercò di occultare la documentazione relativa. Ma gli incartamenti sono stati trovati dal tribunale dei ministri nel 1996, solamente che il Senato”, dove Andreotti era approdato nel 1991 col laticlavio concessogli al Quirinale da Cossiga, “non concesse l’autorizzazione a procedere”.
Sorge a questo punto il sospetto che fossero proprio le carte su quell’operazione così ben preparata ma non eseguita che la mattina del 4 settembre 1982 agenti dei servizi segreti cercarono e portarono via dalla cassaforte dell’alloggio siciliano assegnato al generale dalla Chiesa, ucciso la sera prima dalla mafia nelle sue nuove funzioni di prefetto di Palermo. Dove si sperava che riuscisse a replicare contro la mafia, appunto, i successi conseguiti nella lotta al terrorismo, a parte -ripeto- le mani legategli per l’assalto al covo dove Moro viveva i suoi ultimi giorni, promosso addirittura a “prigione del popolo” dai suoi sequestratori.
Neppure se fosse vera la leggenda sentita con le mie orecchie una volta alla Camera di un’operazione ritardata, e poi vanificata dalla morte dell’ostaggio, per la paura dei familiari di Moro di vederlo soccombere nell’assalto, preferendo quindi una liberazione negoziata, quella avrebbe potuto essere una ragione per rinunciarvi. Che razza di linea della fermezza era allora quella gridata ai quattro venti dal governo e giustamente liquidata da Cornacchia, pur partecipe della sua applicazione, come “un’assurdità”, anche perché “decisa e proclamata quando ancora le brigate rosse non avevano rivendicato l’agguato di via Fani”?
Non parliamo infine di quel pacco di 10 miliardi di lire che il 6 maggio del 1978 Cornacchia andò a ritirare a Castel Gandolfo, con l’ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane, don Cesare Curione, e padre Enrico Zucca, dalle mani del segretario di Papa Paolo VI, monsignor Pasquale Macchi, destinati a pagare il riscatto di Moro. Ma alle 19,35 -ha raccontato il generale- il segretario del Pontefice ricevette una telefonata che gli impedì, pallido in volto, di completare la consegna.
Pubblicato sul Dubbio