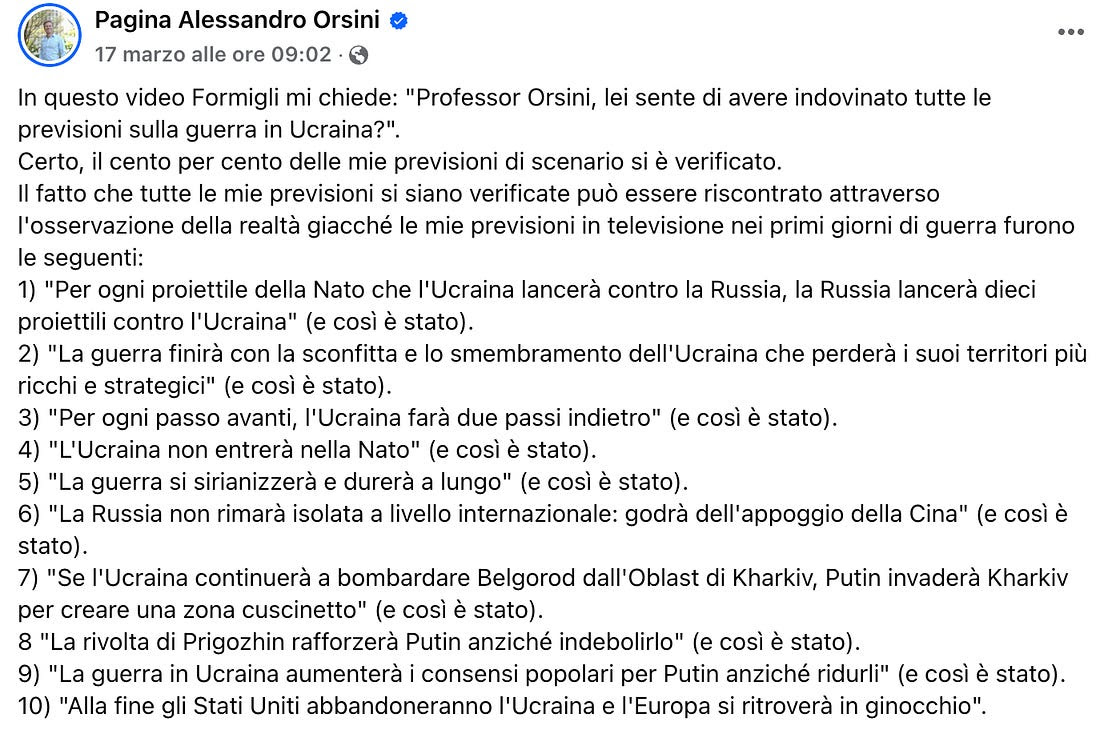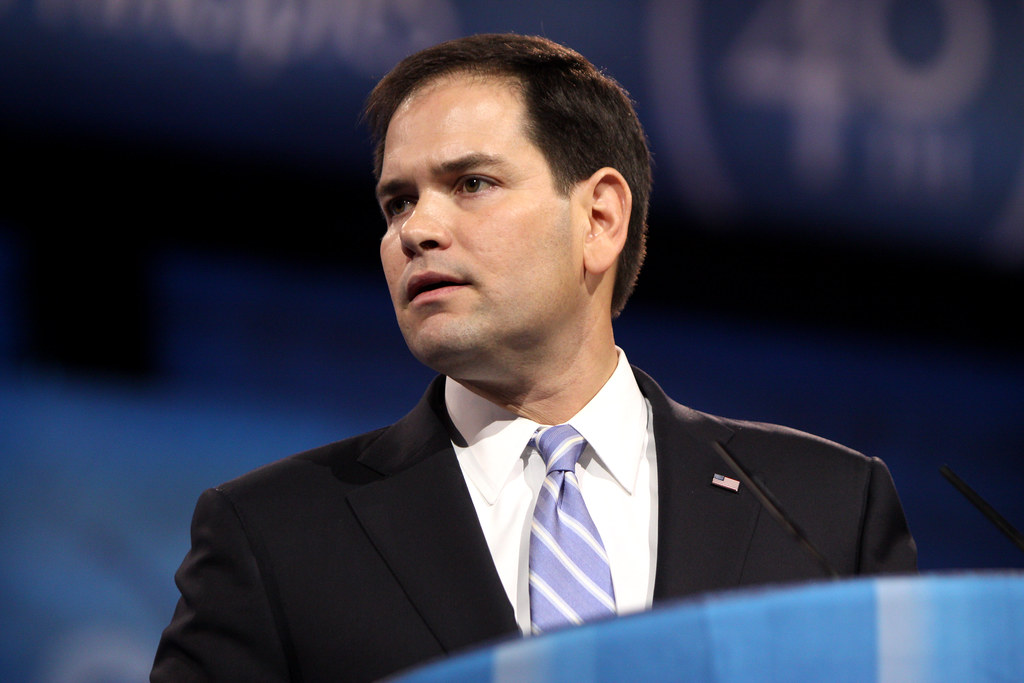Durante una puntata del talk show PiazzaPulita di qualche settimana fa, il giornalista e conduttore Corrado Formigli ha mandato in onda una sua intervista ad Alessandro Orsini. Orsini è professore associato di Sociologia del terrorismo all’università Luiss, e da circa tre anni è diventato un volto piuttosto celebre della televisione italiana.
La sua notorietà presso il grande pubblico è dovuta alle sue partecipazioni a programmi televisivi di approfondimento, tra cui proprio PiazzaPulita su LA7 e #Cartabianca su Rai 3, dove negli anni ha espresso opinioni molto dibattute sulla guerra in Ucraina.
Nell’intervista, Formigli chiede al professore se pensa di aver azzeccato tutte le sue previsioni sulla guerra in Ucraina. Orsini non ha esitazioni: “Certo, tutte le previsioni che ho fatto si sono verificate”.
Ma di quali previsioni stanno parlando i due interlocutori, esattamente?
Nell’intervista rilasciata a Formigli non viene mai specificato; tuttavia, è lo stesso Alessandro Orsini a dircelo in uno dei suoi (tanti) post sui social.
Il post di Orsini fa un elenco di dieci affermazioni, o ‘previsioni’, che il professore avrebbe pronunciato “nei primi giorni di guerra” del 2022, e che poi si sarebbero rivelate tutte esatte. Per la verità alcune di queste affermazioni non risalgono ai primi giorni di guerra, per la semplice ragione che non possono.
La rivolta di Prigozhin, ad esempio, è avvenuta a giugno 2023, quindi Orsini non può aver espresso un parere sulla ribellione del gruppo Wagner già nel 2022.
Si dirà, con ragione, che questo dettaglio non è poi così importante: se negli anni Orsini ha davvero formulato dieci previsioni esatte sulla guerra in Ucraina, gliene va riconosciuto il merito, senza troppe esitazioni. Ci sono però alcune cose che non tornano.
In particolare, l’elenco delle dieci affermazioni fatte da Orsini ha tre grossi limiti:
1. Alcune previsioni di Orsini sono speculative.
Si prenda ad esempio la seconda affermazione, quella che dice che “la guerra finirà con la sconfitta e lo smembramento dell’Ucraina” (2). Come pure altre della lista, si tratta di una previsione ancora aperta, dal momento che l’esito finale del conflitto è tutt’altro che definito.
Non si capisce quindi perché Orsini la annovera già tra le previsioni azzeccate.
Ma anche ammesso che l’Ucraina a fine guerra perda dei territori (cosa probabile), non è detto che si tratti di una sconfitta.
Il termine “sconfitta” infatti ha un valore relativo, e quando lo si inserisce in una previsione bisognerebbe prima spiegare cosa si intende con esso.
Cosa vuol dire infatti per l’Ucraina perdere o vincere la guerra? La risposta non è scontata. Se per vincere l’Ucraina deve cacciare l’esercito russo da tutto il territorio e riprendersi Donbass e Crimea, è probabile che l’Ucraina *perderà*.
Se invece le basta ottenere uno stallo prolungato e un negoziato favorevole per dirsi vincente, allora è tutta un’altra storia.
Stando a un articolo del The Atlantic, nel corso del 2024 la Russia avrebbe perso centinaia di migliaia di soldati, tra uccisi e feriti, in cambio di un territorio ucraino leggermente più grande dello stato del Rhode Island. Se continua di questo passo, la Russia prenderà possesso di tutta l’Ucraina tra circa 118 anni. È una vittoria o una sconfitta per l’Ucraina? Senza prima dire cosa intende per “sconfitta”, Orsini costruisce una previsione speculativa che può adattare in base al risultato sul campo.
2. Alcune affermazioni di Orsini non sono previsioni, perché non sono verificabili.
Nella lista di Orsini compaiono anche affermazioni che hanno solo l’apparenza di autentiche previsioni. Prendiamo la prima, quella che dice che “Per ogni proiettile della Nato che l’Ucraina lancerà contro la Russia, la Russia lancerà dieci proiettili contro l’Ucraina”.
Orsini è molto affezionato a questa proposizione, e la ripresenta continuamente sui propri social e nelle interviste.
Ora, ci sono due modi di interpretare un’affermazione del genere. In un primo senso, Orsini starebbe dicendo che letteralmente il rapporto fra i proiettili lanciati dall’Ucraina e quelli lanciati dalla Russia è di 1 a 10.
In un confronto televisivo con la giornalista Tonia Mastrobuoni, ad esempio, Orsini sembra confermare questa interpretazione:
Lo sa che cosa dicono i generali ucraini al fronte? Parole testuali: “Il rapporto tra i colpi di artiglieria pesante nostra e quelli russi è di 1 a 10, a volte di 1 a 12”. Ma se questa interpretazione letterale è quella corretta, allora Orsini si sbaglia.
Se è vero che nelle prime fasi del conflitto il rapporto tra i colpi di artiglieria era effettivamente di 10 a 1, la situazione sembra essersi modificata di molto nel tempo, e alcune fonti dicono che la Russia ora ha una capacità di artiglieria solo 1.5 volte superiore a quella ucraina. È una previsione sbagliata nel lungo periodo, oppure una vera solo per un certo segmento della guerra.
Un secondo modo, meno rigido, di interpretare questa affermazione è quello di intenderla come una metafora della superiorità dell’armamentario russo.
Dire che per ogni proiettile ucraino ce ne saranno dieci russi sarebbe solo un altro modo, più enfatico, per dire che tra Russia e Ucraina c’è sproporzione negli armamenti e nella produzione industriale militare. Ma se ha solo valore di metafora allora questa proposizione non può essere verificata, poiché non intende descrivere un fatto preciso o misurabile.
Quindi non è neanche una previsione, perché le previsioni devono sempre essere verificabili.
Conosce una sorte analoga anche la terza affermazione della lista di Orsini: “Per ogni passo avanti, l’Ucraina farà due passi indietro”. Qui è molto più chiaro il sapore metaforico, ed è improbabile che Orsini intendesse qualcosa di letterale.
Ma allora si ripropone lo stesso problema: non siamo davanti a un’affermazione verificabile. A fortiori, non siamo nemmeno davanti a una previsione.
3. Orsini sembra suggerire che azzeccare una previsione significhi semplicemente ‘indovinare’ cosa accadrà in futuro.
Si tratta forse del limite più grosso. Questo modo di concepire le previsioni – l’idea di compilare un ‘listone’ con tutte le affermazioni che si sarebbero dimostrate vere – restituisce un’idea fuorviante di cosa vuol dire fare una buona analisi predittiva.
Lascia passare il messaggio che per fare una buona previsione è sufficiente ‘azzeccarci’ o indovinare il futuro; mentre in realtà è altrettanto importante azzeccarci per buone ragioni.
Una previsione corretta, per essere davvero significativa, deve poggiare su buone ragioni, ovvero su dati affidabili, inferenze valide e un impianto teorico coerente.
Altrimenti, si ricade nella sfera del colpo di fortuna, che ha più a che fare con l’intuizione fortuita o con il caso che con una vera capacità analitica. Il verbo stesso ‘indovinare’, che Orsini usa nel post, ha questa sfumatura di casualità. Ma le previsioni degli analisti non vengono fatte per indovinare il futuro; quello è il mestiere dei cartomanti.
Anzi, le buone previsioni spesso rimangono tali anche quando quello che viene previsto non si realizza al 100%, perché retrospettivamente si riconosce che, al tempo in cui la previsione era stata formulata, c’erano buone ragioni per pensarla così.
Per capire perché l’idea del listone è problematica, può essere utile fare un parallelo con una questione che viene discussa da molto tempo in filosofia: che cosa significa davvero conoscere qualcosa?
In filosofia, in particolare nell’ambito chiamato epistemologia (cioè lo studio della conoscenza), si è a lungo sostenuto che per poter dire di conoscere qualcosa non basta crederci, e non basta nemmeno che quella cosa sia vera.
Se io credo che domani pioverà, e domani effettivamente piove, non si può dire automaticamente che io “sapessi” che avrebbe piovuto. Per poter parlare davvero di conoscenza serve anche un altro elemento: la giustificazione. In altre parole, la mia convinzione deve basarsi su buone ragioni, su elementi solidi che rendano ragionevole credere a ciò che credo (es. ho visto il bollettino meteorologico di domani).
Tornando al tema delle previsioni, il ragionamento è simile.
Indovinare che qualcosa succederà non è la stessa cosa che prevederlo in senso pieno. Se una persona fa una previsione basata su argomenti deboli, dati mal interpretati o assunti sbagliati, e quella previsione si avvera, non possiamo dire che quella persona avesse davvero ‘previsto’ il futuro. Ha semplicemente avuto fortuna.
E affidarsi alla fortuna, specie in ambiti delicati come l’analisi politica o economica, è una strategia poco raccomandabile. Una previsione che abbia valore – e che non sia solo un’ipotesi fortunata – deve poggiare su un ragionamento fondato, su dati attendibili, su una comprensione approfondita del contesto. È questo che distingue l’analisi dalla congettura, la competenza dall’intuizione casuale.
Con questo non si vuole ovviamente suggerire che Orsini, nelle sue analisi, proceda a colpi di intuito: sarebbe scorretto attribuirgli una pratica di questo tipo.
Ma Orsini, come chiunque si presenti come esperto, dovrebbe preoccuparsi meno di elencare le previsioni azzeccate – ammesso che lo siano – e concentrarsi di più sulle ragioni e sui criteri che rendevano quelle previsioni valide, indipendentemente dal risultato.
Perché il compito primario di un esperto non dovrebbe essere quello di rivendicare i propri successi, ma di mettere a disposizione le proprie competenze per aiutare a comprendere la complessità.
Allo stesso tempo, è utile depotenziare un mito che spesso circola tra quelle tifoserie social che si agglutinano attorno a un personaggio pubblico. Nessun analista è un indovino.
Nessun analista le ha azzeccate tutte sull’Ucraina. E per quanto possa sembrare incredibile a qualcuno, talvolta anche il grande Orsini sonnecchia (semicit.).
(Estratto dalla newsletter Appunti di Stefano Feltri)