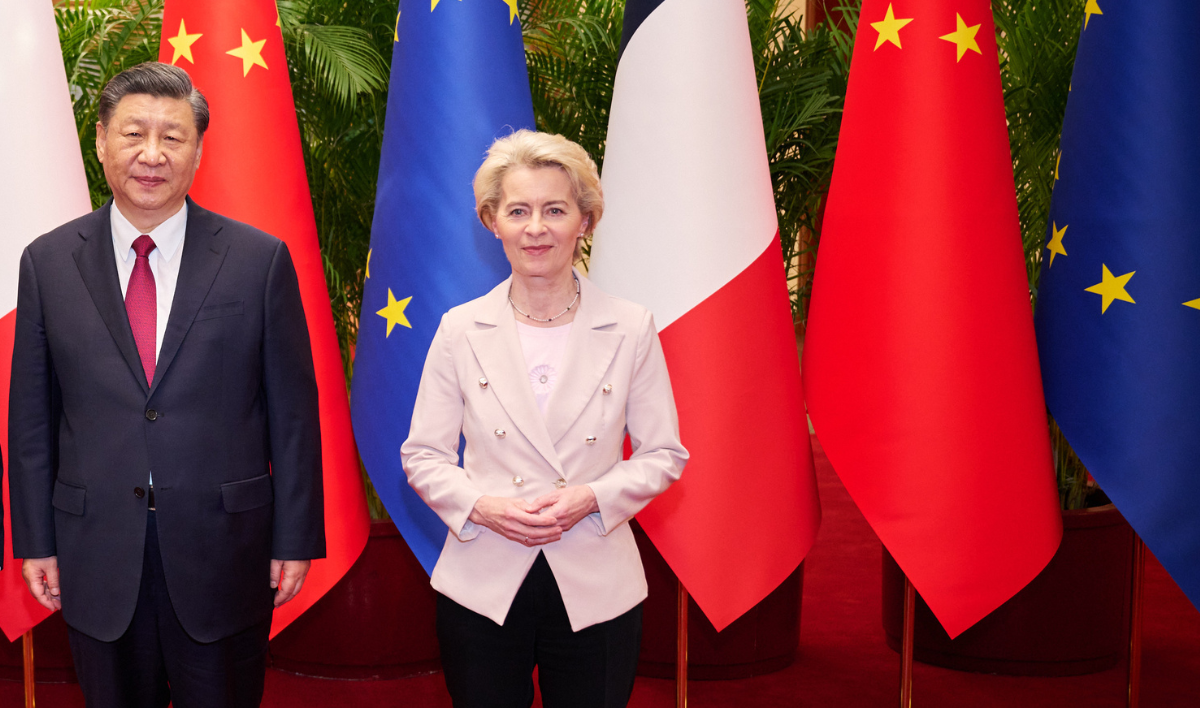I rapporti dell’Argentina e dell’intera America Latina con il Fondo Monetario Internazionale sono stati storicamente da problematici a incandescenti. Sostanzialmente, la sinistra e il movimentismo nazionalista in tutte le sue numerose declinazioni vedono l’FMI come il braccio finanziario della dominazione imperialista. Il ruolo determinante che vi esercitano gli Stati Uniti in quanto fin dalla fondazione nel secondo dopo-guerra soci principali del maggiore istituto di credito multinazionale del mondo, costituisce ai loro occhi una evidente conferma. Sebbene nei decenni trascorsi ma soprattutto negli ultimissimi tempi immagine e prassi reale del Fondo siano evolute, l’immaginario popolare ma anche quello politico latinoamericano non gli hanno cancellato lo stigma dell’usura. In Argentina non lo ha fatto neppure l’odierno scampato pericolo di un nuovo default.
Questa breve memoria, è opportuna al fine di comprendere il duplice scossone politico, finanziario e d’opinione prodotto in sequenza attorno allo scorso fine-settimana in Argentina, dall’improvvisa notizia dell’intesa raggiunta dall’attuale governo del presidente Alberto Fernandez (peronista) e dall’FMI, sul pagamento del debito straordinario contratto nel secondo semestre del 2018 dall’allora governo di Mauricio Macri (neo-liberista). Si tratta del credito più grande mai concesso dal Fondo (55mila milioni di dollari nella formula Stand-by), che ne ha erogati 44mila milioni in tempi rapidissimi, del tutto inusuali. Le condizioni dell’ indebitamento, fin da subito ritenuto impagabile da quasi tutti gli economisti più autorevoli negli Stati Uniti e in Argentina, suscitò enorme scandalo. Inasprito dalla voce ritenuta comunemente attendibile che a renderlo possibile era stato l’intervento di Donald Trump, amico di famiglia ed ex socio in affari della famiglia del presidente argentino Macri. Ma soprattutto a sua volta pressato dai grandi fondi di Wall Street che stavano perdendo milioni nella crisi argentina e cercavano una via di ritirata.
Non senza qualche buon argomento anche giuridico, il debito venne dichiarato illegittimo dall’allora opposizione peronista, che ne fece una bandiera elettorale per la campagna vittoriosa che ha portato Alberto Fernandez e la sua vicaria, l’ex presidentessa Cristina Kirchner, e loro coalizione Frente de Todos alla Casa Rosada. Ben si capisce quindi l’assenza di qualsiasi tono trionfalista nell’annuncio del capo dello Stato dell’intesa giunta dopo un estenuante negoziato, in cui l’Argentina ha ottenuto innegabili miglioramenti dei numeri e nei tempi di pagamento. Essenzialmente evitando la ricetta tradizionale del Fondo: l’immediata e drastica riduzione del deficit di bilancio (oggi poco al di sopra al 5%), che avrebbe implicato un drammatico taglio della spesa sociale e degli investimenti necessari al recupero della produzione e dell’occupazione dopo la devastazione dei 23 mesi di COVID.
La ristrutturazione del debito, però, passa ovviamente per il suo riconoscimento, che risulterebbe perfino ridotto proporzionalmente al prolungamento dei tempi (del totale rimasto insoluto, la prima rata scivolerebbe al 2024, così come verrebbe scaglionata anche la riduzione del deficit di bilancio). Comunque l’Argentina s’impegna a pagare. E uno sgarro al Fondo può comportare l’ostracismo del banking internazionale pubblico e privato, quantomeno di quello occidentale di cui bene o male il grande paese sudamericano è parte, tanto da essere socio dell’FMI. Un’economia esportatrice non se lo può permettere. Né il viaggio che il presidente Alberto si appresta a fare in Cina e in Russia, pur quando aprisse ulteriori fonti di credito aggiuntive, non potrà offrire soluzioni alternative tanto immediate quanto per un futuro prossimo. I suoi obiettivi sono essenzialmente di natura commerciale.
Per prassi oltre che per norma, una volta che l’accordo con l’FMI sarà definito formalmente, dovrà essere ratificato dal Congresso di Buenos Aires. È per questo che la rinuncia da capogruppo della coalizione di governo alla Camera dei deputati annunciata da Maximo Kirchner, il figlio maggiore del defunto presidente Nestor e dell’ex presidentessa e attuale Vice Cristina, ha provocato al capo dello Stato un certo imbarazzo. Potrebbe darsi il paradosso che l’opposizione lo approvi e parte dei governativi lo respinga. Nella lettera ufficiale di dimissioni, Maximo ricorda di aver dissentito apertamente dall’apertura di una trattativa con il Fondo, che adesso definisce per di più priva della determinazione e del coraggio necessari. Per non coinvolgere la madre (a sua volta notoriamente contraria), Maximo scrive che lei ha tentato di dissuaderlo, come del resto lo stesso Presidente. Sta di fatto che la borsa e la parità della moneta nazionale, il peso, ne hanno immediatamente subito un contraccolpo.
Come in ogni governo di coalizione, il capo deve esercitare una sintesi che non si discosti eccessivamente dalle posizioni di tutte le sue componenti. In questo caso, il partito di Maximo e di Cristina, la Campora, è con ogni probabilità il fattore numero uno, sia per l’intensità della militanza, sia per l’apporto elettorale. Se l’espressa contrarietà di Maximo e quella tacita ma nota della vicepresidentessa non celano nessun disegno occulto, finiranno per alimentare la consueta e non di rado turbolenta dialettica interna. Dev’essere questo il convincimento o quanto meno la speranza di Alberto Fernandez. Poiché diversamente si aprirebbe per il paese e per lui un periodo di particolare difficoltà e incalcolabili rischi. Né Cristina, né suo figlio hanno infatti indicato alternative compiute e ragionevolmente percorribili all’accordo siglato con il Fondo, che indubbiamente comporta i suoi oneri.