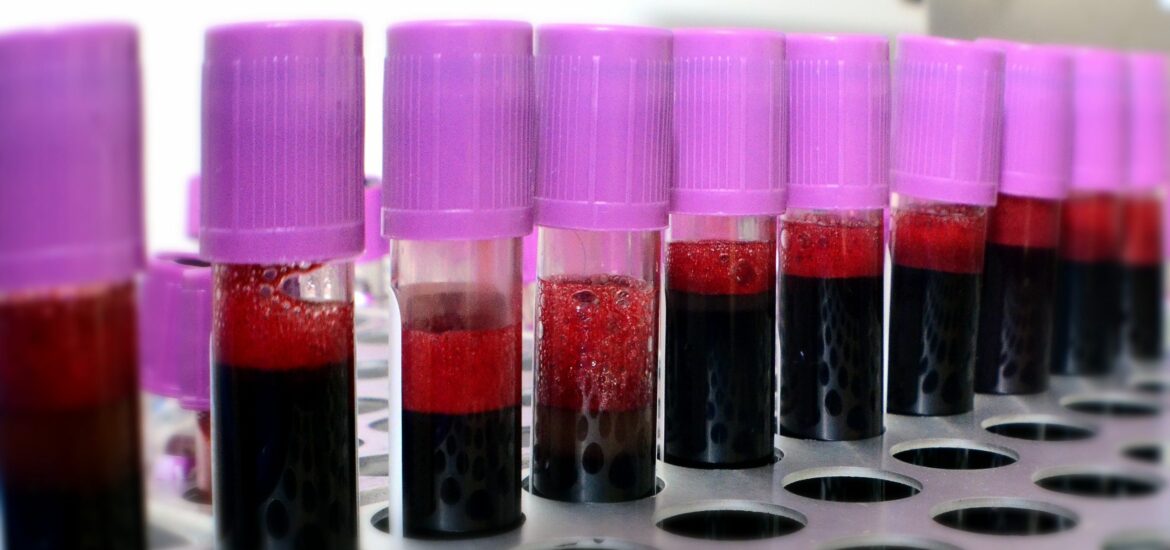CONFUSIONE ED INCERTEZZA
Si stanno sempre più diffondendo anche in Italia i test sierologici per il virus Covid-19. In particolare, quelli cosiddetti “rapidi” sono test che tramite analisi del sangue identificano velocemente e con buona accuratezza la presenza di anticorpi specifici al virus (le immunoglobuline IgM e IgG). Diverse regioni, come la Toscana e l’Emilia Romagna, li stanno applicando sui propri medici o in analisi campionarie per avere una migliore idea della diffusione del coronavirus nella popolazione (un utilizzo, quest’ultimo, sanzionato favorevolmente anche dall’Organizzazione mondiale della sanità). Ma ci sono anche molte società e cliniche private che li vendono sul mercato. Per esempio una società fiorentina, prima di essere bloccata da un’ordinanza della regione, offriva privatamente un test (nello specifico il test “qSars-CoV-2 IgG/IgM”, su cui ritorniamo più avanti) al modico prezzo di 25 euro; il sito di prenotazione è andato in tilt dopo poche ore dall’attivazione per eccesso di domande. In molte altre regioni test di questo tipo possono invece ancora essere acquistati privatamente, seppure a prezzi più alti, ed è notizia di questi giorni che nove comuni lombardi abbiano deciso autonomamente, nonostante il parere contrario della regione, di promuovere l’uso di test sierologici tra i propri cittadini.
Di fronte all’incertezza e alla confusione che regna sulla diffusione del virus, anche per l’incomprensibile carenza di analisi campionarie accurate più volte denunciate su questo sito, è del tutto comprensibile che i cittadini cerchino di orientarsi con soluzioni “fai da te”, alla ricerca di una qualche “patente di immunità” che li protegga – soprattutto per il futuro – in vista della famosa “fase 2”. Ma è una scelta pericolosa. Per più ragioni.
Primo, mentre i test sul Covid già disponibili sono numerosi e molti altri ancora vengono studiati, i loro meccanismi di certificazione appaiono carenti. Per esempio, la certificazione Ce (Comunità europea) che in maggior parte li accompagna è in realtà – sulla base di una vecchia direttiva della Commissione – un’auto-certificazione dei produttori (come si discute qui e qui). E negli Stati Uniti i test sul Covid-19 vengono per ora accreditati dalla Fda (Food and Drug Administration) sulla base di una Emergency Use Authorization che ne consente la commercializzazione immediata pur rimandando al futuro un’analisi più seria della loro efficacia (qui un esempio). Non è un caso dunque che in Italia l’Istituto superiore di sanità appaia molto cauto nel promuovere questi test. Inoltre non è ancora chiaro sul piano scientifico se avere gli anticorpi protegga davvero dal virus nel lungo periodo. Ma c’è anche una terza ragione, più sottile, che merita di essere spiegata.
UN ESERCIZIO
Immaginate di avere a disposizione un test che con probabilità pari al 97 per cento identifica con correttezza coloro che sono stati contagiati dal virus e che invece con probabilità pari al 4 per cento produce “falsi positivi”, cioè suggerisce che una persona sia stata contagiata dal virus quando così non è. Questi numeri sono di fantasia e volutamente ottimistici rispetto a quello che anche i migliori test al momento disponibili riescono a fare, ma non sono totalmente irrealistici. Per esempio i numeri veri per il test menzionato in precedenza, il “qSars-CoV-2 IgG/IgM”, autorizzato dalla Fda sulla base della procedura di emergenza prima ricordata, sono rispettivamente del 93,8 per cento e del 4,4 per cento. Supponete ora che una persona si sottoponga al test e che questo risulti positivo: quanto questa persona può essere sicura di aver effettivamente contratto il virus e dunque di essere immune, almeno nel breve periodo?
Un comune errore di percezione è confondere la probabilità di avere un risultato positivo al test se si è stati contagiati, con la probabilità di essere stati contagiati se il test risulta positivo. Sfortunatamente si tratta di due misure completamente diverse e, mentre la prima è per ipotesi pari al 97 per cento, la seconda dipende dalla percentuale di contagiati nella popolazione. Nessuno lo sa con precisione ma, per esempio, per le regioni del centro-sud potrebbe essere ragionevole ipotizzare una percentuale di contagiati pari o inferiore all’1%, mentre in Lombardia ci sono stime che suggeriscono fino a un milione di persone, il 10% della popolazione. Ebbene, un’applicazione della regola di Bayes mostra che, se i contagiati sono l’1 per cento della popolazione, la probabilità di essere davvero stati contagiati dal virus se il test è positivo è in realtà inferiore al 20 per cento. E, anche se i contagiati fossero il 10 per cento della popolazione, circa il 30 per cento di quelli risultati positivi al test in realtà non avrebbe mai incontrato il virus. La ragione del risultato è semplice. Anche se il test ipotizzato è un ottimo test, produce inevitabilmente falsi positivi; e siccome per ipotesi (ragionevole) molti non sono stati contagiati nella popolazione, questi fanno sì che risultare positivi al test non dica molto sul fatto di essere stati davvero contagiati dal virus.
Il rischio dunque della soluzione “fai da te” è che questa stimoli una falsa sicurezza nei cittadini, l’illusione di essere immuni perché risultati positivi al test. Gli effetti possono essere devastanti. La speranza è che, se ne dovessero consentire la commercializzazione, le autorità spieghino bene ai cittadini e ai medici di base il significato di questi test. Nel frattempo, meglio stare accorti e continuare ad adottare le protezioni del caso.
(Estratto di un articolo pubblicato su Lavoce.info, qui la versione integrale)