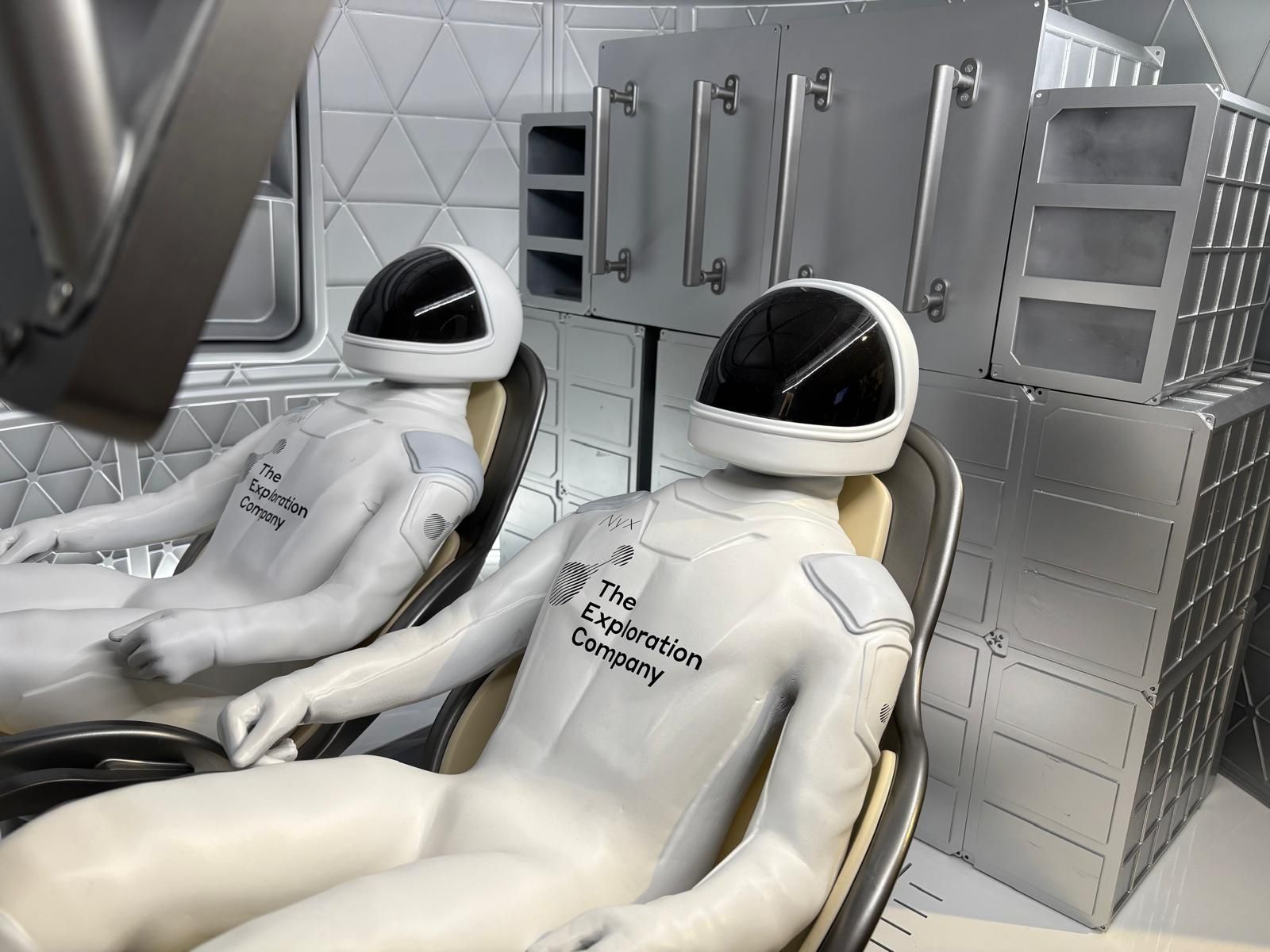Il capo di stato maggiore dell’esercito al tempo della prima guerra mondiale, Luigi Cadorna, viene dipinto, forse in maniera un po’ caricaturale, come alacre produttore di circolari, insieme con gli altri vertici militari. La guerra, si narra, si pensava si sarebbe vinta a forza di assalti sanguinosi e, soprattutto, ampie, forbite e dettagliate “circolari”.
Diciamo che l’Impero austro-ungarico riuscì egregiamente a scansare gli assalti e bombardamenti di circolari, e se perse la guerra fu perché l’esercito italiano combatté con le armi vere e con l’organizzazione concreta.
Tuttavia, la tentazione a scrivere la “circolare” in Italia non la si perde mai, in nessuna circostanza e, soprattutto, in situazioni d’emergenza come quella attuale legata al coronavirus.
Visto che occorre contenere quanto più possibile i contatti tra persone, per limitare occasioni di contagio, il Governo nei vari provvedimenti fin qui adottati, ha spinto verso il lavoro agile (o smart working per i pixel che sanno di lingue straniere), semplificando anche le modalità di utilizzo, fino a considerare non necessario l’accordo col lavoratore.
E per il lavoro pubblico? Ecco, il tasto dolente. Il lavoro pubblico si sta caratterizzando in questi giorni per essere praticamente rimasto fuori dal mondo, intendendo per “mondo” la connessione, il cloud, l’utilizzo di strumenti di lavoro remotizzati che non richiedono necessariamente la postazione fissa in un luogo preciso.
Ecco il perché dell’evergreen: la “circolare”. Nel caso di specie, si tratta della circolare 1/2020 del Ministero per la pubblica amministrazione (più confidenzialmente, “Funzione Pubblica”), intitolata “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Sì, siamo ancora alle misure per incentivare l’utilizzo di un sistema di regolazione della prestazione lavorativa che dovrebbe essere da tempo di largo uso.
Il bello che è l’incentivazione giunge, come dire, a scoppio ritardato. Infatti, la circolare giunge nel marzo 2020, a quasi 5 anni di distanza cioè da quell’agosto del 2015, quando venne approvato il decreto legislativo dal quale avrebbero dovuto prendere forma le varie riforme Madia del lavoro pubblico (molte delle quali naufragate davanti alla Consulta). Si tratta della legge 124/2015, che, quindi, da oltre 4 anni dispone per le amministrazioni pubbliche non la facoltà, nemmeno l’opportunità, ma addirittura l’obbligo di adottare misure organizzative che permettessero entro un triennio (quindi entro il 2018) di passare al lavoro agile per almeno il 10% dei dipendenti, su loro richiesta. Obbligo, per altro, corroborato dal dovere di elaborare piani organizzativi di introduzione dello smart working, da considerare ai fini della valutazione della produttività degli enti.
Ecco, il bello dell’ipernormazione è questo: si passa, senza colpo ferire, da disposizioni di legge (ovviamente vincolanti) enuncianti obblighi operativi, a circolari, emanate quasi 5 anni dopo, che trasformano quell’obbligo in “misure di incentivazione”.
Perché tutto questo? Per la semplicissima ragione che in questo lasso di tempo le amministrazioni che davvero abbiano attivato il lavoro agile come strumento organizzativo del lavoro si contano sulle dita di una mano.
Ma, questo, non solo per la pigrizia elefantiaca. Vi sono altre ragioni. Tra queste, la clausola che da sempre rende irrealizzabili tutte le riforme pur enunciate in pompa magna: l’articolo 14 della legge 124/2015, infatti, ha previsto l’estensione dello smart working ma
[…] nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.E come Ella sa bene, Titolare, la presenza di questa giaculatoria nelle norme ne certifica ed anticipa la totale inefficacia. Pensare di attuare riforme senza affrontarne i costi è, ovviamente, velleitario.
La vicenda dello smart working nella PA ne è la palmare conferma. Ulteriormente certificata dalla circolare 1/2020 e dal fenomenale articolo 18 del decreto legge 9/2020, che consente alla Consip di aumentare del 50% le forniture di personal computer da assegnare a dipendenti pubblici. Insomma, c’è voluto il coronavirus per accorgersi che attivare forme di lavoro remotizzate senza pc adeguati risulta abbastanza difficile.
Un’altra ragione di sostanziale fallimento, sin qui, del tentativo di introdurre il lavoro agile nella PA è l’eterna “sperimentazione”. Quando si ha un’idea, anche buona ma che richiede uno sforzo anche minimo di innovazione organizzativa, senza risorse da immettere, allora si “sperimenta”. Il che significa elaborare mega progetti finanziati con risorse comunitarie, più complessi da gestire e rendicontare che da attuare, limitati a pochissime amministrazioni e ad ancor più ridotti casi concreti.
Infatti, la circolare 1/2020 si rende perfettamente conto della deleteria sperimentazione continua ed enuncia, finalmente:
[…] è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.Basterà? Non lo sappiamo. La circolare 1/2020 nelle sue 4 pagine a ben vedere è una sorta di attestazione che per quasi 5 anni in sostanza nulla si è fatto per lo smart working nella PA, se non qualche piccola sperimentazione, senza nemmeno andare a guardare e verificare se i piani finalizzati alla performance siano mai stati adottati (e realizzati) da qualcuno.
Tra queste 4 pagine, poche righe, al punto 3, contengono davvero alcune misure che si avvicinano all’incentivazione all’utilizzo dello smart working. Tra queste, Titolare, ve n’è una che è fantastica, eccola:
[…] ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni.Come dire, insomma, “sappiamo che del lavoro agile abbiamo una percezione molto lata, siamo consapevoli che nemmeno sono stati mai comprati sufficienti pc, cellulari, cavi di rete, router ed applicativi di sicurezza per attivarlo, ma, comunque, per piacere, cari dipendenti, metteteci il vostro hardware, in qualche modo, faremo”. Meraviglioso, no?
Nel frattempo, nessuno si sta ricordando di una delle molte dannosissime idee della stagione “brunettiana”, quella di far risparmiare soldi limitando missioni ed uscite di servizio. Una serie di norme di ben 10 anni fa, dunque, misero freni molto stretti a missioni e trasferte. Così stretti, però, da impedire praticamente ai dipendenti pubblici di poter utilizzare il mezzo proprio per esigenze di servizio, visto che vennero sostanzialmente vietati i connessi rimborsi.
E così, proprio mentre si sconsiglia di stare vicini più di un metro dalle persone o di utilizzare mezzi pubblici, se un dipendente deve andare in missione, si trova costretto a non poter utilizzare il proprio mezzo, perché non verrebbe rimborsato, e di conseguenza ad utilizzare i mezzi pubblici.
Aspettiamoci una circolare che intervenga sul tema, complicando ulteriormente le cose? Aspettiamo. Fiduciosi.
P.S. in ogni caso, finché la PA non sarà capace di intendersi di metriche del lavoro e di prodotti delle proprie attività, anche disponendo di pc, connessioni sicure e smartphone, qualsiasi lavoro da remoto sarà molto difficile. Infatti, per scongiurare il pericolo che il lavoro agile divenga un “liberi tutti” per i “furbetti” è necessario poter misurare i risultati dell’attività svolta. Ma, a questo scopo, occorre sapere cosa si fa, cosa si produce, in che modo, in che tempi.
Si rischia in effetti una caduta della produttività? Certo. Il problema è, però, che nessuno ha la più pallida idea nemmeno di come misurare la produttività del lavoro pubblico. Memorabile è quanto ha scritto la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, nel Rapporto sul lavoro pubblico del 2011 (capitolo 6, paragrafo 5):
È notorio quanto la valutazione della produttività del settore pubblico sia oggetto di continui studi ed approfondimenti, allo scopo di individuarne una o più chiavi di lettura che rendano, quanto più possibile, oggettivi e condivisi i relativi indicatori. Appare tuttavia opportuno rilevare, visti i numerosi rapporti che intercorrono tra settore pubblico e privato, come sia più che plausibile ipotizzare un’influenza reciproca sul livello di produttività e, in ultima analisi, di entrambe sulla competitività del sistema (…) Da simili informazioni tuttavia non si evince il peso che il livello di produttività del settore pubblico possa avere nell’influenzare l’andamento di tali indicatori. Rimane tuttavia l’ipotesi che un forte impulso positivo al sistema Italia possa essere dato proprio dalla produttività del settore pubblico, una volta noti gli elementi cardine per la sua, non solo misurazione, ma soprattutto valorizzazione e promozione.