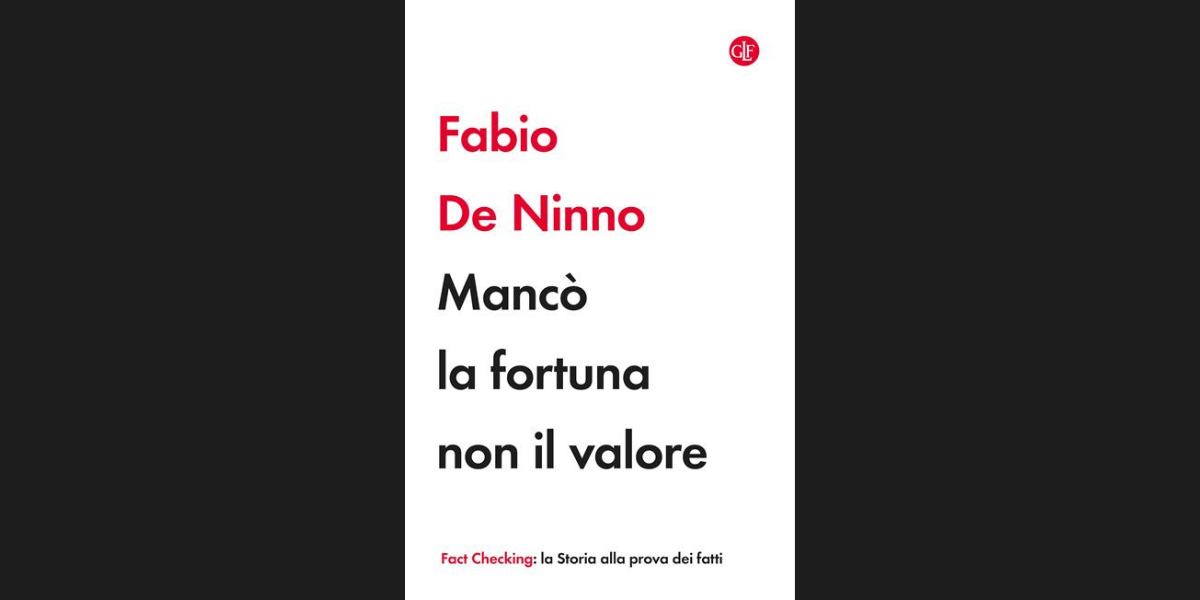La Commissione europea ha raccomandato ai suoi funzionari in partenza per gli Stati Uniti per gli incontri di primavera alla Banca mondiale e Fondo monetario internazionale di viaggiare con i cosiddetti “burner phones”, vecchi cellulari non smart, di quelli usa e getta, da buttare al rientro.
Una precauzione che fino a poco tempo fa veniva presa giusto per i viaggi in Cina, per timore di tornare con qualche sorpresa nel telefono, qualche trojan che lo trasforma in una microcamera con microfono sempre accceso a beneficio di spioni stranieri. L’altro rischio è quello di vedersi succhiare informazioni.
Gli Stati Uniti erano, da questo punto di vista, un Paese amico e sicuro, ma non è più così. Adesso l’America è pericolosa, anche e soprattutto per l’intreccio tra l’amministrazione Trump e le aziende di Big Tech.
Sono appena stato anche io negli Stati Uniti, a Chicago, e il clima è decisamente cambiato rispetto a qualche mese fa, prima dell’arrivo di Trump.
Non ricordo, nei viaggi degli anni scorsi, i dettagliati video mostrati già a bordo dell’aereo sulla necessità che tutti – ma proprio tutti – si sottopongano ai controlli dell’immigrazione. E quel monito ripetuto in ogni comunicazione ufficiale che un visto o il permesso per viaggiare senza – l’Esta, con cui molti italiani entrano negli Stati Uniti – non diano alcuna garanzia di entrare davvero: l’ultima parola spetta ai funzionari dell’immigrazione.
E da settimane le cronache raccontano di stranieri che finiscono in guai un tempo impensabili: addirittura ammanettati e portati via in catene dall’aeroporto, detenuti per sei settimane nei centri per immigrati irregolari, senza processo, senza garanzie.
Chi ha un visto di lavoro trema al pensiero di quando dovrà rinnovarlo, chi sta negli Stati Uniti da anni con la green card, il permesso permanente per vivere e lavorare, si affretta a chiedere la cittadinanza, perché i non-cittadini possono essere deportati su richiesta del segretario di Stato se interferiscono con la politica estera americana.
Una possibilità fino a poco fa del tutto teorica, ma che ora il segretario di Stato Marco Rubio ha iniziato a esercitare sul serio.
A uno sguardo di insieme, la democrazia americana sembra vicina al collasso: tutti hanno paura, l’amministrazione Trump congela i fondi delle università per condizionare la loro agenda di ricerca, i dipendenti ricevono pre-allerte di possibili licenziamenti di massa, i professori consigli su come eliminare i propri account social, gli studenti stranieri che nei mesi scorsi hanno partecipato a proteste pro-Palestina sanno che potrebbero essere deportati anche soltanto per un post di sostegno alle manifestazioni.
Manifestazioni che, nel frattempo, sono svanite nel nulla: va bene la solidarietà con i palestinesi, ma la battaglia che al tempo dell’amministrazione Biden sembrava cruciale per gli studenti di Columbia e di altri atenei ora è considerata troppo pericolosa.
Eppure l’amministrazione Trump non è così compatta come sembra, le due anime, quella populista e quella tecnocratica, sono in continua tensione, e gli esiti sono imprevedibili. E questo si vede proprio sul terreno cruciale, quello del rapporto con le grandi aziende tecnologiche.
Nel mondo di Trump c’è Elon Musk, che incarna la saldatura tra il trumpismo e le piattaforme digitali, che passa per il sostegno del governo al mondo delle criptovalute e si declina nelle pressioni su TikTok per cedere le sue attività americane e sull’Unione europea per ammorbidire il suo approccio alle Big Tech americane. 3.41
Però nel mondo di Trump c’è anche un’altra ala, quella populista, che alle Big Tech invece ha dichiarato guerra, e che sta di fatto portando avanti le battaglie dell’amministrazione Biden ispirate alle idee di Louis Brandeis: usare gli strumenti dell’antitrust contro le grandi concentrazioni di potere economico, e politico, a beneficio del popolo.
L’antitrust populista
A Chicago ho partecipato a una conferenza organizzata dallo Stigler Center della Booth School of Business dell’Università di Chicago, dove ho lavorato per un periodo, diretto dal professor Luigi Zingales.
Tra i relatori più attesi c’era Andrew Ferguson, un avvocato di 38 anni, Repubblicano, che Trump ha messo a capo della FTC, la Federal Trade Commission, uno degli enti che nel sistema americano ha le maggiori responsabilità antitrust, assieme al Dipartimento di Giustizia.
Ferguson ha parlato a un pubblico che più prevenuto di così non poteva essere: la critica al potere di Big Tech americano è partita proprio da una conferenza e da un rapporto dello Stigler Center nel 2019, l’amministrazione Biden ha fatto proprie molte delle idee discusse ogni anno alle conferenze dello Stigler Center e ha nominato alla FTC la campionessa di quell’approccio, Lina Kahn, famosa per aver denunciato per prima lo strapotere di Amazon.
Il discorso di Andrew Ferguson è stato per certi aspetti una sorpresa. Come tutti i Repubblicani che parlano in pubblico, anche Ferguson ha parlato soprattutto al suo pubblico di riferimento più rilevante: cioè Donald Trump.
Dunque, abbiamo ascoltato la prevedibile lista di lamentele per la censura delle piattaforme digitali alle idee non allineate e la necessità di un dibattito libero e aperto come quello che avviene su X di Elon Musk.
Il presidente della FTC ha dovuto omaggiare tutte le parole d’ordine del trumpismo versione Musk che prevedono la denuncia della connivenza passata tra Democratici e Silicon Valley per giustificare lo spostamento a destra attuale, a sostegno di Trump, di tutte le Big Tech.
Però poi Ferguson ha detto anche qualcos’altro, di molto rilevante: ha spiegato che secondo lui e secondo la FTC che guida, ogni concentrazione di potere è di per sé un problema, se c’è un mercato nel quale c’è un solo soggetto dominante, o ce ne sono pochi, questa è già una buona ragione per dare un’occhiata a cosa succede e farsi qualche domanda.
L’ossessione della destra trumpiana per il “free speech”, per la libertà di espressione, è usata di solito per legittimare ogni proclama di estrema destra, razzista, violento, ma può essere anche un argomento valido per limitare il potere delle piattaforme digitali: un settore troppo concentrato, con pochi soggetti che determinano tutto, è un settore dove è più facile coordinarsi. Il coordinamento distrugge il “mercato delle idee” e determina una censura, e questo non va bene ai trumpiani.
“Se c’è fumo, bisogna guardare che succede”, dice Andrew Ferguson.
Può sembrare poco, ma è tantissimo: quella dichiarazione di principio, assieme alla scelta di partecipare a un evento così connotato come la conferenza dello Stigler Center di Luigi Zingales, indica una scelta di campo precisa.
L’amministrazione Trump continuerà a usare l’antitrust come l’amministrazione Biden, e questa è una sorpresa. C’è un’anima populista, nell’amministrazione Trump, che si contrappone a quella tecnocratica, anti-democratica di estrema destra.
Il capotribù della fazione populista è il reduce della prima stagione trumpiana, Steve Bannon, mentre il capofila dei tecnocrati antidemocratici che si riconoscono nel movimento Make America Great Again è Elon Musk.
Processo a Facebook
Quelle di Andrew Ferguson non sono soltanto dichiarazioni di principio. Nella giornata di lunedì 14 aprile si è aperto un processo cruciale contro Facebook in una corte federale di Washington, DC.
A portare in giudizio Facebook è proprio la FTC: il processo avrebbe potuto saltare facilmente, Trump ha licenziato in modo forse illegale due commissari in quota Democratici, i due superstiti, tra cui il presidente Ferguson, avrebbero potuto fare un accordo stragiudiziale con Mark Zuckerberg e chiudere la faccenda.
Non l’hanno fatto, anzi, si preparano ad affrontare molto battaglieri un processo che potrebbe portare allo smembramento di Facebook.
Nel 2012 Facebook ha comprato Instagram per un miliardo, nel 2014 WhatsApp per 19 miliardi. La FTC proverà a dimostrare che Facebook ha fatto quelle due acquisizioni per mantenere il proprio potere di monopolio nel mercato e soffocare ogni concorrenza.
Ci sono perfino mail interne di Mark Zuckerberg che spiega l’acquisto di Instagram così, cioè con la necessità di neutralizzare un potenziale concorrente.
Ma non sarà una battaglia facile. Facebook proverà a sostenere che non è affatto un monopolista, che il mercato dei social network è grande e ci sono tanti concorrenti che se lo contendono, da LinkedIn a X a Snapchat.
Secondo la FTC, invece, Facebook agisce in un mercato nel quale è il protagonista assoluto, quello del “servizi di social network personali”: su LinkedIn o su X non si celebrano compleanni e non si postano ricordi delle vacanze, su TikTok non si hanno amici, e così via.
Matt Stoller, brillante polemista che denuncia da anni i nuovi monopoli americani, nella sua newsletter Substack Big spiega:
“La FTC può dimostrare il potere di monopolio con prove dirette, come la capacità di aumentare i prezzi in modo redditizio o di ridurre la qualità. Tuttavia, poiché Meta non fa pagare gli utenti per i propri servizi, è difficile presentare la classica prova diretta di un aumento dei prezzi.
Ciò nonostante, la FTC ha introdotto prove secondo cui Meta può praticare discriminazioni di prezzo, un segnale di potere di mercato, aumentando il numero di annunci mostrati agli utenti che hanno una maggiore domanda di social networking.
In ogni caso, è probabile che la FTC faccia affidamento su prove indirette del potere di mercato di Meta: l’elevata quota di mercato combinata all’esistenza di barriere all’ingresso che impediscono ad altri di erodere la quota detenuta da Meta”.
Meta rischia di essere condannata a uno smembramento dell’azienda, cioè a separare WhatsApp o Instagram, sarebbe un colpo quasi esistenziale per la galassia Facebook.
Anche Google, che ha perso un processo analogo per quanto riguarda il monopolio nella ricerca, potrebbe finire smembrata: il giudice deve ancora indicare i rimedi allo strapotere riscontrato. E anche in quel caso l’amministrazione Trump avrebbe potuto cercare una chiusura amichevole della controversia, ma non l’ha fatto.
Trump, o almeno alcuni segmenti del trumpismo, sanno che in questo momento colpire Big Tech è una mossa molto popolare, e populista, anche e soprattutto nel mondo conservatore.
Mark Zuckerberg non è riuscito ad arginare l’ennesima fuga di notizie interna, con l’ex dipendente Sarah Wynn-Williams che ha denunciato in Senato le pratiche interne a Facebook che prevedevano di prendere di mira gli adolescenti più fragili, identificare i loro momenti di disagio e condividere questa informazione preziosa con gli inserzionisti pubblicitari, senza curarsi delle possibili conseguenze negative.
Se una ragazzina di 13 anni cancella un selfie, forse è un buon momento per provare a venderle un prodotto di bellezza, perché è un segnale di insicurezza sul proprio aspetto.
Zuckerberg, come gli altri capi di Big Tech, ha poi un problema europeo: le piattaforme rischiano sanzioni per l’applicazione delle regole sulla concorrenza e sulla protezione degli utenti, Il Digital Services Act e il Digital Markets Act, ma adesso rischiano anche una tassazione sui ricavi da pubblicità digitale che la Commissione europea potrebbe imporre in risposta ai dazi di Trump.
Per questo Zuckerberg, come Jeff Bezos di Amazon, gli investitori Marc Andreessen e Peter Thiel, oltre che ovviamente a Elon Musk provano a esercitare la loro massima influenza sulla Casa Bianca, per difendere i propri interessi.
Ma proprio nel mondo trumpiano potrebbero trovare una resistenza. L’uso popolare e populista dell’antitrust potrebbe essere l’unica sorpresa positiva dell’amministrazione Trump fin qui. Oppure potrebbe essere una fugace illusione che Big Tech neutralizzerà presto, vedremo.
(Estratto da Appunti di Stefano Feltri)