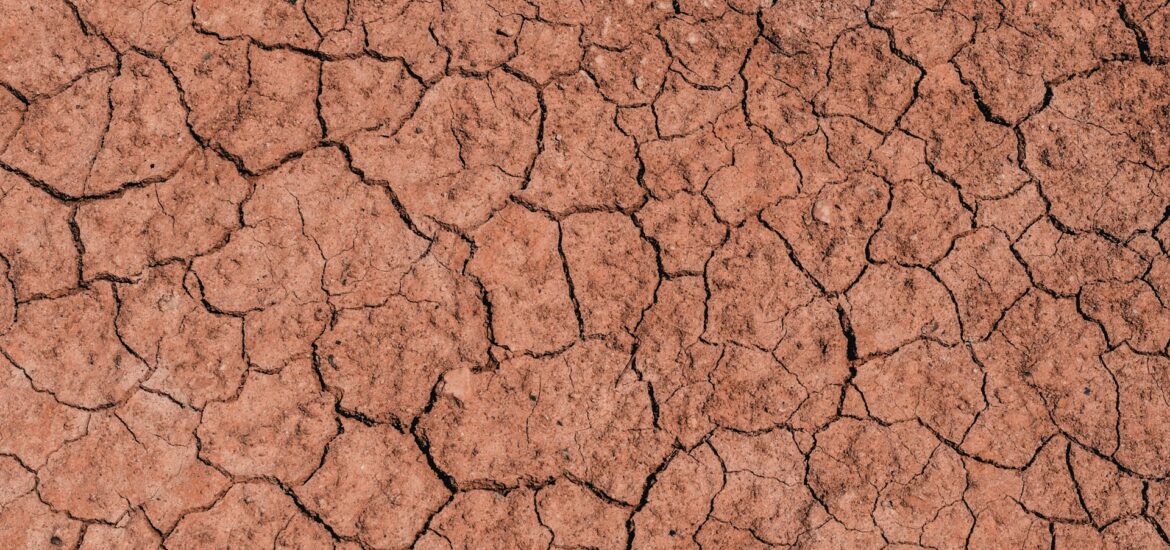Il puzzle della siccità si compone di tanti tasselli: distribuzione dell’acqua inefficiente, sprechi, domanda superiore alla disponibilità effettiva e nuove tecnologie. Prima di tutto, però, servono scelte politiche più tradizionali e cosa vogliamo fare in fatto di gestione dell’acqua. Tutte le altre sono condizioni necessarie ma non sufficienti a gestire in modo efficiente le risorse. È il messaggio di Edoardo Borgomeo, professore associato di ingegneria dell’acqua all’Università di Cambridge.
L’inadeguatezza delle infrastrutture idriche italiane si manifesta chiaramente nella quantità di acqua che si perde passando nelle tubature: il 25 per cento, una cifra da capogiro se paragonata a città come Tokyo, dove si disperde meno del 5 per cento.
“Con il cambiamento climatico le condizioni ambientali diventano più severe. Ci sono periodi più prolungati senza precipitazione che possono portare alla siccità. In un pianeta più caldo le piante hanno bisogno di più acqua per l’evapo-traspirazione. Questi sono i fattori esogeni: precipitazioni più intense e meno frequenti, aumento della temperatura. Poi si aggiunge ovviamente anche il fattore umano. Dobbiamo fare un ragionamento serio su come usiamo l’acqua in Italia. A livello di pianificazione questo non aiuta ad adattarci. Sprechiamo l’acqua nelle tubature. In Italia un quarto della risorsa immessa in media non raggiunge l’utente, si perde nelle falle dei tubi. In alcuni comuni la percentuale arriva alla metà”, spiega Borgomeo.
Ridurre gli sprechi è importante, ma concentrarsi su questo obiettivo vuol dire non accorgersi dell’elefante nella stanza, sottolinea il professore. “Il vero problema è guardare al grande utilizzo delle risorse idriche che si fa in agricoltura. Dobbiamo migliorarne la gestione, perché nel nostro Paese si usa il 50-60 per cento dell’acqua disponibile. Una delle risposte è adattare le coltivazioni al tipo di clima, oppure potrebbe servire un diverso tipo di sistema di coltivazione. Lo stoccaggio dell’acqua nei bacini, da utilizzare quando c’è un periodo di siccità, potrebbe essere una parte della soluzione. Possiamo costruire altri bacini e togliere i sedimenti che li rendono inefficienti, ma è comunque necessaria una visione di lungo periodo”.
L’acqua disponibile sulla Terra non può finire, poiché è una risorsa rinnovabile e il suo livello si mantiene stabile a quota 1.386.000.000 chilometri cubici. L’unica eccezione è rappresentata da alcuni Paesi mediorientali come l’Arabia Saudita, che utilizzano l’acqua che proviene da falde acquifere molto profonde dove è stata depositata secoli fa. Tuttavia, la percentuale di acqua che possiamo utilizzare non raggiunge neanche il 10 per cento di quella disponibile sul pianeta. Negli ultimi anni la domanda è aumentata sempre più, tanto che in diverse aree della Terra supera la disponibilità idrica media. Un problema che contribuisce alla siccità che a intervalli stagionali colpisce il nostro Paese, dove negli ultimi 30 anni le risorse idriche sono diminuite del 19 per cento rispetto al 1950.
PIANIFICAZIONI DECENNALI
“Si parla dell’acqua solo quando il pozzo è a secco, in pochi Paesi c’è una gestione pro-attiva delle risorse idriche e delle questioni ambientali in generale. La res publica ha un orizzonte legato ai cicli elettorali e questi problemi richiedono lungimiranza e pianificazione decennale. Questo è un problema da considerare. Con il cambiamento climatico il volume d’acqua sarà maggiore, il problema sarà in quanto tempo scenderà: più velocemente e con grandi intervalli di siccità. Si immagini la disponibilità idrica come il conto in banca di un dipendente a tempo indeterminato: se si spende più velocemente di quanto si guadagna si va in rosso. Noi idrologi studiamo i dati storici per conoscere la disponibilità idrica media d’acqua. Se la paragono alla domanda, anche al netto della variabilità, posso notare un disequilibrio strutturale. Il conto corrente in banca sarà sempre in rosso, saremo sempre oltre la disponibilità idrica naturale. È una considerazione che in Italia è valida per zone molto aride come la Sicilia, ma è la regola per Paesi come gli Emirati Arabi, ad esempio, dove l’acqua naturale è già finita”, spiega Borgomeo.
È in situazioni come queste che la tecnologia corre in aiuto dell’uomo per superare gli ostacoli naturali. L’innovazione più promettente per aumentare la disponibilità idrica è la desalinizzazione, processo che trasforma l’acqua marina in acqua dolce per utilizzi agricoli, industriali e, in alcuni casi, alimentari.
“Quando la domanda è strutturalmente superiore rispetto alla risorsa disponibile c’è un deficit costante, quindi servono interventi tecnologici come la desalinizzazione, ma anche il riutilizzo dell’acqua e l’abbandono delle zone desertiche. Desalinizzazione e riutilizzo acque reflue sono due temi su cui l’Italia si sta muovendo. In alcuni Paesi sono già integrati nel sistema idrico per necessità, perché hanno una disponibilità idrica naturale molto bassa e quindi si sono dovuti rimboccare le maniche. La desalinizzazione rimane un’opzione costosa rispetto al prelievo da un pozzo, poiché si tratta di un processo energivoro. E in Italia l’energia costa di più rispetto ai Paesi che puntano molto su questa tecnologia. Tuttavia, i costi stanno scendendo. La cosa più importante sarà avere una visione strategica su questi impianti. Bisognerà mettersi d’accordo sugli standard per la qualità dell’acqua, per la gestione della salamoia”, sottolinea Borgomeo.
Tuttavia, dissalatori e riutilizzo dell’acqua rappresentano solo il Piano B contro la siccità. La prima opzione è migliorare “l’efficienza d’utilizzo. In Paesi come l’Italia, che vivono un deficit stagionale, invece, dobbiamo monitorare l’utilizzo dell’acqua per accorgerci se stiamo prelevando rispetto al ritmo naturale di rifornimento di questa risorsa. Dovremmo ridurre il nostro prelievo d’acqua dai sistemi naturali poiché è superiore rispetto a quello che l’ambiente riesce a sopportare. L’ambiente soffre perché gli esseri umani prelevano molta acqua dagli acquiferi. È importante costruire bacini e ottimizzare l’utilizzo dell’acqua. Inoltre, potrebbe essere necessario invitare gli agricoltori a cambiare le coltivazioni. A livello industriale, invece, sarà necessario incentivare le imprese a investire in tecnologia e rinnovamento delle infrastrutture. Integrare il il telerilevamento, ad esempio, permette di identificare se alcuni sprechi possono essere evitati migliorando il timing. La migliore gestione può avvenire attraverso sistemi tecnologici, ma sono fondamentali le scelte politiche”.
IL SUPPORTO DELL’IDROLOGIA
L’uomo può contare su un alleato importante nella sfida di gestire in modo efficiente le risorse idriche: l’idrologia, la scienza che predice quanta acqua sarà disponibile in un determinato luogo, ma anche i rischi idrogeologici e di inondazione.
“Utilizziamo modelli matematici per riprodurre la natura attraverso leggi chimiche e fisiche fondamentali”, riprende il professore: “Il processo standard che utilizziamo si basa sul fatto che quando piove parte dell’acqua penetra nel suolo e ci scorre sopra, mentre un’altra parte evapora. Il machine learning complementa la teoria basandosi sui dati. Ad esempio, prendiamo dati sulle portate dei fiumi nei prossimi 100 anni e li inseriamo in un algoritmo di machine learning per fare previsioni che spesso sono migliori di quelle che sviluppiamo attraverso modelli che si basano solo sulla teoria. Questi modelli permettono di ridurre i costi rispetto a quelli che si basano sulla fisica e sulla teoria. La predizione sta beneficiando molto del machine learning e dell’Intelligenza Artificiale, che stanno prendendo sempre più piede anche nella meteorologia. Le fonti principali dei dati sono satelliti e sensori on the ground, dati che possono essere combinati per fare previsioni elastiche. Il telerilevamento ci sta aiutando molto a migliorare la nostra disponibilità idrica”. Borgomeo sottolinea però ancora una volta che le tecnologie possono aiutare, ma la partita contro la siccità si giocherà principalmente nelle stanze della politica.
IL RUOLO DEI FONDI DEL PNRR PER L’ITALIA
Gli stessi investimenti avranno un ruolo importante, ma comunque secondario, nella strategia per contrastare la siccità. Parlando di fondi non si può non citare per l’Italia il Pnrr, la principale opportunità di finanziamento del settore idrico. Infatti, il Piano destina circa 4,3 miliardi di euro al sistema idrico e 2 miliardi per nuove infrastrutture idriche primarie. Inoltre, mette in campo 900 milioni per la riparazione, digitalizzazione e monitoraggio integrato delle reti idriche. L’obiettivo è realizzare almeno 25.000 chilometri di nuovi acquedotti per la distribuzione di acqua potabile. Opere che aiuteranno il sistema idrico italiano, ma non saranno sufficienti senza un piano generale nazionale di ampio respiro e di lungo termine.
“Sicuramente è importante che ci sia un investimento di questo tipo. La Banca mondiale sottolinea l’importanza di non concentrarsi troppo sul volume di finanziamento in sé, ma capire il tipo di obiettivo della policy: quale tipo di sistema idrico vogliamo avere tra 10 anni? Completamente digitale per ridurre le perdite al minimo, oppure più resiliente rispetto ai cambiamenti climatici? Forse negli ultimi anni è mancata la discussione su che tipo di acqua vogliamo nel 2050. Ci sono priorità immediate come tappare falle e mettere in sicurezza i bacini, e quindi ben vengano gli investimenti. I fondi sono sufficienti per affrontare i problemi nell’immediato, ma non so se lo saranno per realizzare la sicurezza idrica nel Paese”. Su questo, conclude Borgomeo, “dovremmo ampliare la discussione”.