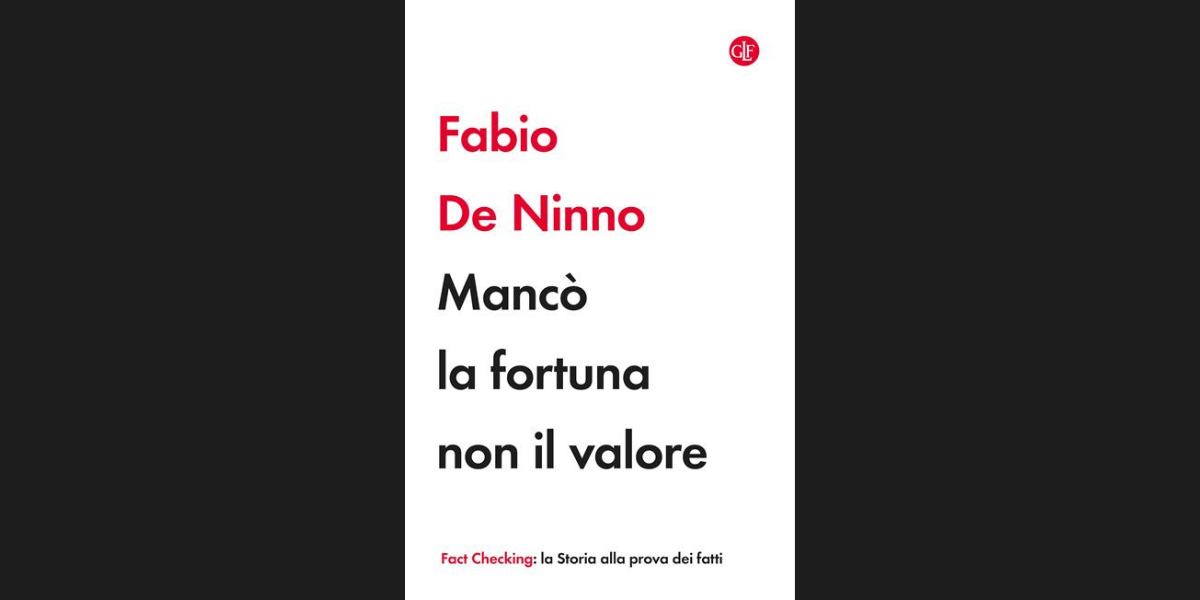L’acqua sta diventando una risorsa sempre più scarsa a livello globale, con conseguenze significative per l’agricoltura, l’industria e la vita quotidiana di miliardi di persone. Tanto che nel dibattito sulle risorse globali si è ormai affermata la concezione che l’acqua sia il nuovo petrolio. Se il petrolio ha dominato il Ventesimo secolo come risorsa strategica, l’acqua sembra destinata a diventare il nuovo petrolio del Ventunesimo secolo, con implicazioni economiche, politiche e sociali sempre più evidenti. Ma l’acqua è indispensabile alla vita e, al contrario del petrolio, non ha sostituti.
Le cause della scarsità idrica sono molteplici e interconnesse. Il cambiamento climatico, con l’aumento delle temperature e la modifica dei regimi pluviometrici, sta alterando il ciclo dell’acqua, provocando siccità più frequenti e intense in molte regioni del mondo. L’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, causato da attività industriali, agricole e domestiche, rende l’acqua non potabile e inutilizzabile per molti scopi. Infine, la crescita della popolazione e lo sviluppo economico stanno aumentando la domanda di acqua, mettendo sotto pressione le risorse idriche disponibili.
La scarsità idrica ha conseguenze gravi per l’economia, la società e l’ambiente. In ambito economico, la scarsità idrica può limitare la produzione agricola e industriale, con ripercussioni negative sulla crescita economica e sull’occupazione. A livello sociale, la scarsità idrica può generare conflitti per l’accesso all’acqua, migrazioni e instabilità politica. Infine, a livello ambientale, la riduzione della disponibilità di acqua dolce minaccia la biodiversità e gli ecosistemi acquatici.
A questo grande tema del nostro tempo e del nostro immediato futuro dedichiamo la sezione di copertina del nuovo numero del quadrimestrale di Start Magazine (la versione digitale gratuita è scaricabile qui). Abbiamo chiamato a collaborarvi, con articoli, interviste o colloqui più informali specialisti di vari campi, come necessario quando il tema spazia su più terreni. Analisti di geopolitica e relazioni internazionali si intersecano con scienziati che all’acqua dedicano gli studi di una vita, meteorologi si incrociano con esperti di tecnologie, il cui sviluppo e la cui applicazione contribuiranno ad affrontare le molte sfide aperte.
Sul piano internazionale, per affrontare la scarsità idrica è necessario infatti un approccio multidisciplinare che coinvolga governi, imprese, esperti, società civile e singoli cittadini. Compito difficile, specie in una fase particolarmente conflittuale della storia mondiale come quella che stiamo attraversando. Tuttavia, ognuno è chiamato a fare la sua parte per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Servono pianificazione e regolamentazione dell’uso dell’acqua, tecnologie efficienti per l’irrigazione, la depurazione e la riutilizzazione delle acque reflue, costruzione di infrastrutture idriche resilienti, sviluppo di sistemi di allarme precoce per le siccità e la promozione di pratiche agricole sostenibili, educazione e sensibilizzazione per incoraggiare comportamenti virtuosi nell’uso dell’acqua e promuovere una cultura della sostenibilità. Sono richiesti sforzo collettivo e visione politica a lungo termine. Solo agendo in modo coordinato e deciso sarà possibile garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta e per le generazioni future.
Ma l’acqua non esaurisce il sommario di questo numero. Il significato delle elezioni americane e le prospettive dal rapporto Stati Uniti-Europa dopo la presidenza di “riavvicinamento” di Joe Biden vengono analizzate da un ambasciatore di lungo corso come Giovanni Castellaneta, che a Washington ha trascorso un periodo importante della sua carriera diplomatica. Altri approfondimenti riguardano lo sviluppo della strategia Nato di fronte alle sfide di Mosca e Pechino, un’analisi della controversa presidenza argentina di Javier Milei e la crisi dell’automotive in Italia.
Una seconda ampia sezione affronta invece il grande tema dell’Africa, le speranze legate ai progressi in alcune aree del continente e le ataviche debolezze che ne frenano uno sviluppo complessivo.
Con articoli e interviste hanno contribuito a questo numero: Lorella Basile, Facundo Bey, Charles H. Blake, Edoardo Borgomeo, Stefano Caliciuri, Giovanni Castellaneta, Stefano Da Empoli, Francesco D’Arrigo, Francesco De Felice, Marco Dell’Aguzzo, Clelia Di Consiglio, Ivo Stefano Germano, Mauro Giansante, Stefano Grazioli, Edoardo Lisi, Samuele Lodi, Pierluigi Mennitti, Pepe Moder, Antonino Neri, Abeer Odeh, Stefano Orlandini, Cristina Orlando, Paolo Passaro, Gilberto Pichetto Fratin, Pierluigi Randi, Alec Ross, Chiara Rossi, Niccolò Russo, Maria Scopece, Maurizio Stefanini, Carlo Terzano, Nathalie Tocci, Jean-Léonard Touadi, Ferdinando Uliano, Francesco Valente.