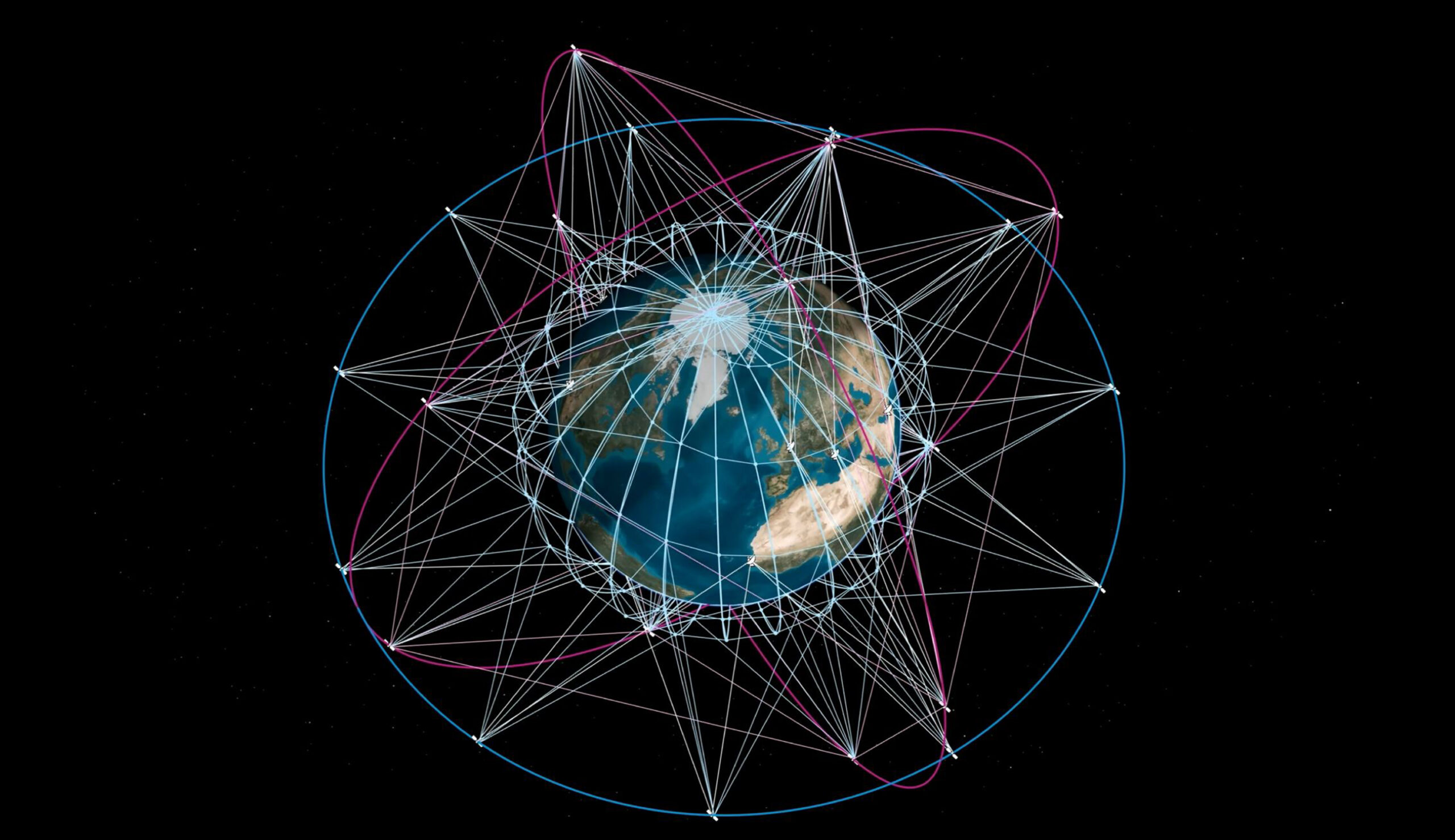IL GAS NELLA TASSONOMIA SOSTENIBILE
La proposta di Bruxelles sulla tassonomia ha scatenato polemiche dai toni particolarmente accesi. Per uno dei due pomi della discordia – il greening del gas – quasi tutti gli interventi hanno tardato a rendersi conto dei vincoli contenuti nella proposta della Commissione europea, che limita le agevolazioni finanziarie quasi esclusivamente a cicli combinati realizzati per sostituire centrali a carbone, accelerandone la chiusura. Una casistica che riguarda soprattutto Germania e Polonia.
Nessuno può nutrire dubbi su quale dei due paesi abbia influenzato maggiormente questa impostazione, che oltre tutto consente alla Germania di prendere due piccioni con una fava.
A seguito di una sentenza della Corte costituzionale, che aveva giudicato il taglio del 55% delle emissioni insufficiente per garantire il tempestivo raggiungimento della neutralità climatica, il Parlamento tedesco ha infatti emendato la legge nazionale sul clima, portando il taglio al 65% entro il 2030, obiettivo irraggiungibile senza il phase out per questa scadenza delle centrali a carbone e a lignite, che nel 2021 hanno contribuito per quasi il 30% alla produzione elettrica.
Inoltre, questo obiettivo è stato incluso, pur con qualche caveat, nell’accordo di governo della coalizione semaforo, in tal modo recependo una delle pressanti richieste dei Verdi.
COSTI ECONOMICI E IMPATTO AMBIENTALE
La seconda conferma riguarda indirettamente, con effetti negativi, le politiche energetico-climatiche europee.
Nel 2021 la Commissione europea ha prolungato per altri quattro anni la Consortia Block Exemption Regulation, che autorizza le imprese del trasporto marittimo a consorziarsi senza infrangere le norme comunitarie antitrust.
Secondo una recente interrogazione parlamentare presentata alla Camera, questo Regolamento ha creato «una situazione di oligopolio, in cui tre imprese detengono il 45,3% della flotta mercantile globale e appena dieci controllano l’80% del mercato».
Come denuncia un articolo uscito su “Il Sole 24 Ore” del 15 gennaio (“Il costo ambientale dell’oligopolio dei porti nordeuropei”), oltre ad aumentare i costi questa situazione anticoncorrenziale ha privilegiato, guarda caso, i porti nordeuropei anche per le merci destinate all’Europa meridionale, con una maggior percorrenza dei trasporti marittimi e terrestri, che comporta annualmente «lo spreco di almeno 750.000 tonnellate di petrolio equivalente e l’emissione di almeno 345.000 tonnellate di CO2».
La Commissione europea, che ama dipingersi come campione del libero mercato, continua pertanto a favorire pratiche anticoncorrenziali che non solo penalizzano le imprese e i consumatori di un numero rilevante di Stati membri, ma, a differenza degli altri esempi citati, oltre a non rispettare la par condicio hanno anche un’impronta ambientale e climatica negativa, cioè l’esatto contrario di quanto la Commissione afferma di voler perseguire.
LA PASSIVITÀ DEGLI ALTRI PAESI EUROPEI
Di questo stato di cose è però corresponsabile la passività dei governi degli altri paesi. L’articolo di 24 Ore si sofferma in particolare sulla cronica sottovalutazione italiana del fenomeno, cui non si è finora sottratto l’attuale governo, a partire dal mancato adeguamento tecnologico dei sistemi portuali dell’Alto Tirreno e dell’Alto Adriatico, che darebbe forza ad iniziative nei confronti di Bruxelles.
Identiche critiche si possono però avanzare per la tacita accettazione (con diritto di mugugno) di obiettivi di decarbonizzazione che andavano nel giusto verso, ma confezionati come abiti su misura per gli interessi tedeschi.
L’11 dicembre 2019, quando propose lo European Green Deal (EGD), la Commissione europea annunciò che entro giugno 2021 avrebbe presentato un Piano «per aumentare, rispetto al 1990, la riduzione delle emissioni di gas serra nel 2030 ad almeno il 50%, ma tendente al 55%», adottando le seguenti misure:
a) revisione dell’ETS, con l’ipotesi di estenderne l’applicazione al settore marittimo e di ridurre le quote gratuite per quello aereo;
b) revisione in chiave ambientale della direttiva sulla fiscalità energetica:
c) per ridurre il rischio di carbon leakage, introduzione in un numero selezionato di comparti industriali del carbon border adjustment mechanism.
Due anni fa erano dunque già esplicite le principali misure richieste per attuare l’EGD, che il pacchetto Fit for 55 si è limitato a mettere nero su bianco. A stupire è quindi il moltiplicarsi di critiche, spesso molto dure, avanzate solo quando i buoi erano già scappati dalla stalla.
Tutti i precedenti raccontano infatti che le proposte della Commissione, con un Parlamento europeo tradizionalmente incline ad approvare obiettivi al rialzo rispetto a quelli di Bruxelles, portano a un compromesso finale che non le stravolge.
Vale per l’Italia (ma anche per altri paesi): perché nessuno dei governi che si sono succeduti nell’ultimo trentennio ha avanzato proposte per la decarbonizzazione, che anticipassero quelle europee, invece di rincorrere poi queste ultime?
(Estratto di un articolo pubblicato su Rivista Energia; qui la versione integrale)