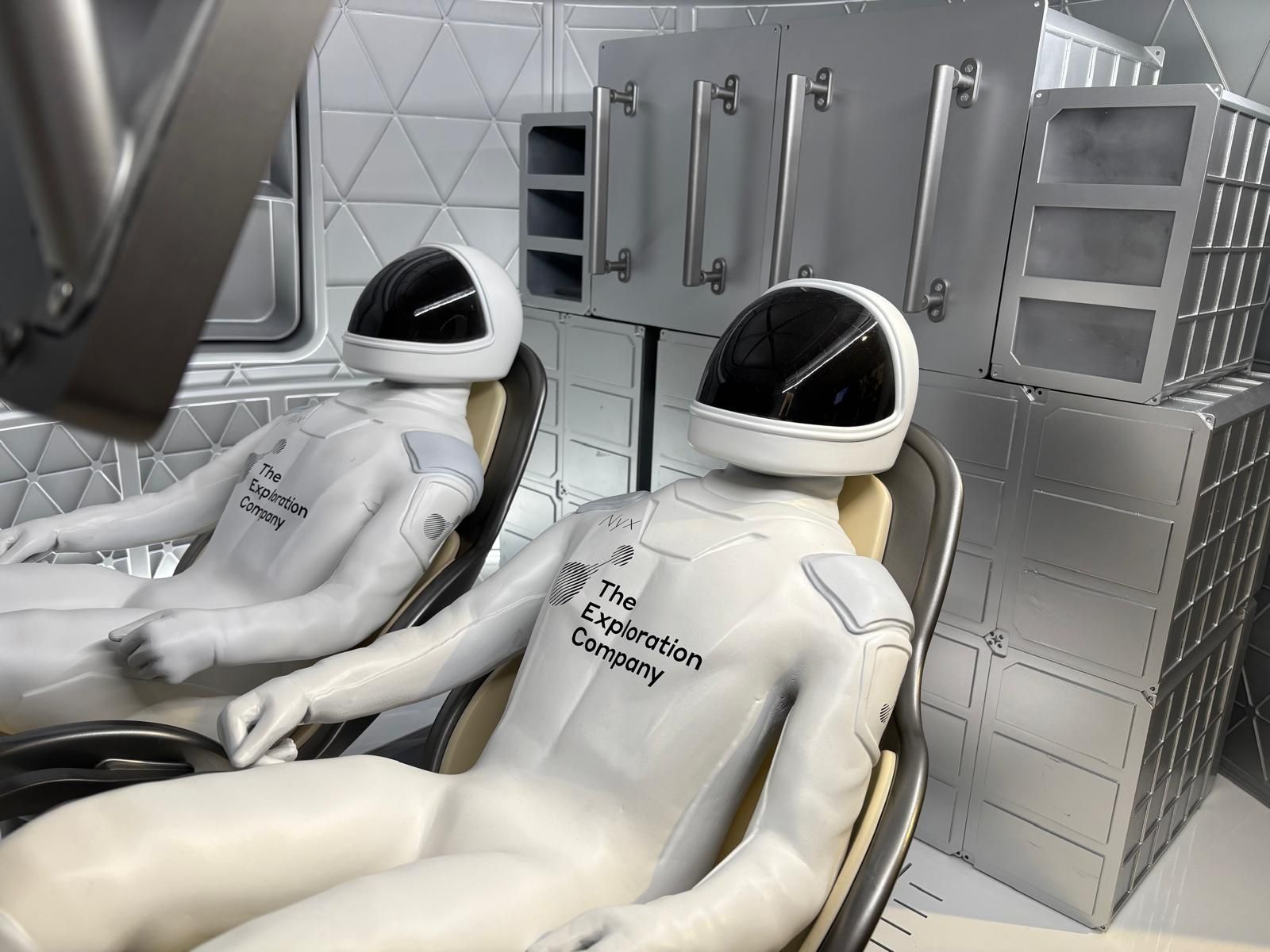L’industria del petrolio e del gas è determinata a rompere l’assedio in cui si sente intrappolata entrando con prepotenza nel mercato elettrico. Inevitabile il passaggio da cooperazione a scontro con le tradizionali utility elettriche. Confronto duro, ma che tuttavia potrebbe vederle avvantaggiate.
Responsabile di oltre la metà delle emissioni d’origine energetica, all’industria oil&gas viene richiesto di ridurre la propria impronta carbonica. Investitori, opinioni pubbliche, governi, corti di giustizia vorrebbero una maggior diversificazione verso le clean energy, una riduzione della presenza negli idrocarburi, che vengano resi più trasparenti i rischi di ‘affondamento’ delle riserve minerarie (gli stranded asset in gergo finanziario), che si rifondano i danni climatici che ha causato.
Proseguire nella politica del ‘business as usual’ mette a rischio il futuro dell’industria. D’altra parte, perché l’industria dovrebbe continuare ad investire se la domanda di petrolio è destinata a declinare a fronte di un’opinione pubblica sempre più ostile?
La risposta di molte imprese è quella di accogliere queste raccomandazioni, a partire dalle Big Oil europee da sempre molto più sensibili alle problematiche ambientali delle ‘sorelle’ americane. In che modo? Fissando precisi obiettivi di riduzione delle emissioni, avviando strategie di entrata nei settori altrimenti concorrenti (come le rinnovabili), tirando i remi in barca negli investimenti di lungo termine nei business tradizionali (ricerca e sviluppo di giacimenti) che pur restano centrali nelle loro attività.
Le iniziative si vanno moltiplicando nei settori più disparati: tra chi ha investito nel solare, come Bp con l’acquisto di Lightsource; chi nelle ricariche elettriche, come Shell; chi, è il caso Chevron, nel sequestro del carbonio da iniettare nei giacimenti per accrescerne la pressione e la produzione; chi in R&D, come Eni che nel triennio 2018-2021 ha stanziato 280 milioni di euro per sviluppare piattaforme tecnologiche di ricerca per la decarbonizzazione.
La maggior parte delle imprese punta tuttavia ad entrare nel mondo dell’elettricità. Secondo Bp, l’elettricità conterà per il 70% della maggior domanda di energia primaria da qui al 2040, trainata dalla pressione demografica e dall’elettrificazione dei consumi (domestici e trasporti), mentre l’Agenzia di Parigi ne stima una crescita del 62% contro il 15% di quella di petrolio.
I maggiori gruppi europei – Total, Shell, Equinor, Bp, Repsol – stanno entrando nella filiera elettrica o già vi operano – come Eni. Resta tuttavia il fatto che trovare, produrre, trasportare molecole di idrocarburi è business fondamentalmente diverso dal generare e trasmettere elettroni. Che le Big Oil vi riescano è possibile, ma nondimeno difficoltoso e costoso.
Per ora siamo all’inizio, ma il messaggio è chiaro: esse non intendono farsi scalzare dalla posizione di leadership che detengono da un secolo nello scacchiere energetico mondiale. In passato, altre fonti, come nucleare o carbone, parvero riuscirci, ma l’accettabilità sociale e il surriscaldamento climatico le hanno rispettivamente messe fuori gioco, per lo meno nel mondo occidentale.
La risposta delle Big Oil sta nella nuova “etichetta” che si sono date: Big Energy. Pur convinte che del petrolio e del metano non si potrà fare a meno per lungo tempo, vanno scommettendo sul nuovo che avanza. Se non altro come forma di copertura dei rischi.
Lo fanno in misura comunque contenuta rispetto al totale dei loro investimenti – 2 miliardi di dollari su 25 per Shell – e questo non le pone al riparo da accuse di greenwashing. Ma sono pronte ad accrescere il loro impegno secondo il procedere della transizione energetica.
Lo scontro col mondo delle utility sarà duro ma sulla carta le Big Oil appaiono in una posizione favorevole, per: la loro molto maggior dimensione, la più consistente capacità finanziaria, la molto maggior diversificazione geografica, l’uso ad operare in settori integrati, il maggior potere di mercato di cui dispongono.
Tanto per fare un esempio, NextEra Energy (NEE), il più grande produttore mondiale di rinnovabili elettriche con una potenza complessiva prossima ai 50 GW e circa 10 milioni di clienti, ha fatturato lo scorso anno sui 17 miliardi dollari: meno dei profitti conseguiti da Shell. NEE capitalizza 90 miliardi dollari contro i 270 di Shell: segno che il rendimento del capitale è per la società anglo-olandese molto maggiore.
Questo gli investitori lo sanno perfettamente, al punto da essere preoccupati di quel che avevano ipocritamente richiesto alle società di cui sono azionisti. I ritorni sugli investimenti per eolico e solare (pre-incentivi) si aggirano, secondo Wood MacKenzie, tra il 5 e il 9 per cento contro più del 20 per cento per quelli petroliferi.
È pur vero che le dissennate diversificazioni delle oil majors dopo il primo shock petrolifero del 1973-1974 si tradussero in altrettanti bagni di sangue tra chi entrò nel carbone, chi nei minerali d’ogni sorta, chi nella moda (come l’acquisto di Yves Saint Laurent da parte di Elf Aquitaine). Ma l’entrata nell’elettricità è molto meno discontinua delle passate diversificazioni, specie con l’accresciuto peso del metano destinato alle centrali elettriche similmente alle raffinerie per il petrolio.
Fusioni e acquisizioni saranno la chiave d’accesso delle Big Oil al mondo dell’elettrico
L’entrata nel mondo elettrico delle Big Oil avverrà poi soprattutto con l’acquisto di società, magari start-up, che già vi operano. Dopo l’acquisto di First Utility in Gran Bretagna, Shell a breve disporrà di circa 7 GWe. Ribattezzata Shell Energy, si ripromette di divenire la più grande imprese elettrica al mondo entro il 2030. A tal fine, dovrà vedersela però con la statale cinese State Gridche conta oltre un miliardo di clienti e un giro di affari non dissimile dal suo.
Due le conseguenze che si possono prevedere dall’entrata delle Big Oil nel mercato elettrico. La prima riguarda il passaggio da cooperazione a concorrenza tra queste e le tradizionali utility elettriche, con il rischio che le seconde risultino penalizzate rispetto alle prime. Se prima le Big Oil vendevano alle utility olio combustibile e metano incrociando business sostanzialmente complementari, d’ora in avanti si affronteranno sempre più direttamente sul mercato.
Indiscutibile lo svantaggio per le utility di dover dipendere dalle Big Oil per l’acquisto del metano, o comunque di non disporne direttamente. Il rischio è che queste ricorrano alla pratica del price squeeze: vendere il metano a un prezzo più caro alle utility, o applicare prezzi interni più convenienti, e contemporaneamente far loro concorrenza nell’elettricità vendendo a prezzi più bassi.
L’altra riguarda la più grande sfida della lotta ai cambiamenti climatici. L’entrata delle Big Oil nel mercato elettrico ne accrescerà la competizione e, con essa, la sua instabilità e la volatilità dei prezzi, peraltro già indotta dalla poderosa crescita delle rinnovabili. Una volatilità che mal si concilia con gli immani investimenti che dovrebbero essere realizzati per decarbonizzare i sistemi elettrici. Un effetto collaterale che i promotori del “fossil divestment” e del “tout électrique” non dovrebbero sottovalutare se non vogliono accontentarsi di mezze vittorie, che in questo ambito equivalgono a nessuna vittoria.
Articolo pubblicato su rivistaenergia.it