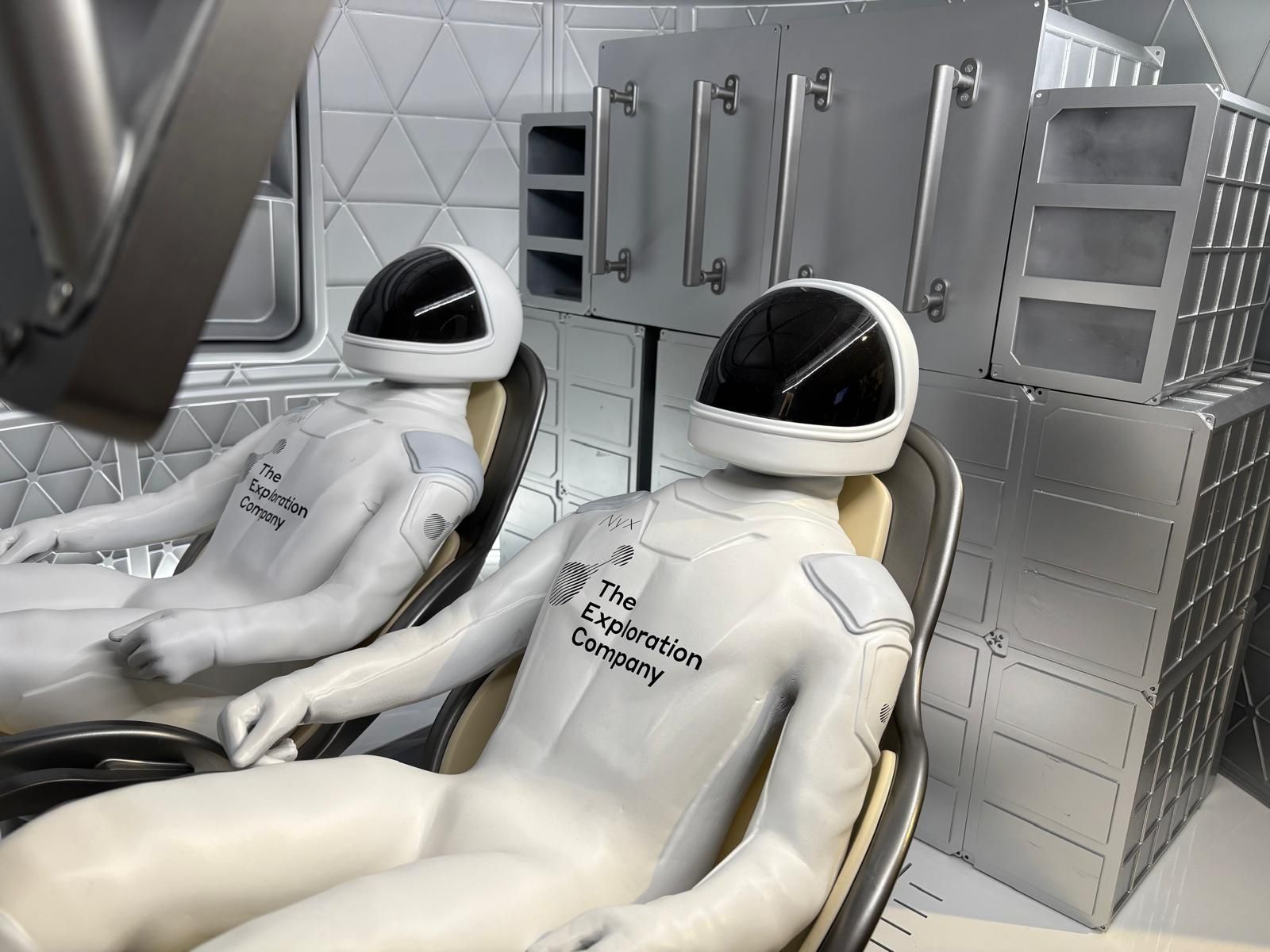La pandemia ha finito per funzionare da amplificatore dei pregiudizi che le preesistevano. Buona parte della classe politica vi ha cercato conferma della propria impostazione ideologica: è nella pubblica amministrazione, nel suo ruolo egemonico e nella sua stessa dimensione fisica, che deve risiedere il primum movens di ogni mutamento sociale. Così, anziché ragionare laicamente sui problemi rivelati o esacerbati da Covid-19, dal dilagare del virus è stata tratta un’unica, rassicurante lezione: ci vuole più Stato.
La reazione dell’Unione Europea ha messo a disposizione dei Paesi membri risorse straordinarie da impiegare tempestivamente per contrastare gli effetti della pandemia. Queste risorse sono “debito comune”, ma il debito è debito: si tratta di fondi che, in larga misura, andranno restituiti da parte degli Stati membri ovvero trasferendo a Bruxelles capacità impositiva.
In Italia “Next Generation EU” è diventata, come purtroppo accade spesso nella nostra pubblica opinione, una sorta di panacea. Abbiamo pensato che questi fondi risolvessero tutti i problemi del Paese, li abbiamo messi al centro del dibattito, vi abbiamo aggiunto altro debito.
A noi preme ricordare due cose. La prima è che avere quattrini è l’esito, non l’innesco del processo di crescita. Se c’è un Paese al mondo che dovrebbe avere un sano e diffuso scetticismo circa la capacità della spesa pubblica di generare di per sé sviluppo, questo è il Paese nel quale una storia centenaria di “aiuti” alla sua parte economicamente più debole non ha, purtroppo, prodotto crescita.
La seconda è che, in qualsiasi investimento, non conta solo il “quanto”: ma ben di più contano il “cosa” e il “come”. I fondi “Next Generation EU” sono stati allocati secondo il consueto carattere dirigista, seguendo grosso modo l’antico metodo sovietico di formulare “piani “, stavolta sessennali anziché quinquennali, di intervento su tutti i settori dell’economia e della società, prevedendo ex ante tappe e scadenze trimestrali, come se fosse l’evoluzione sociale a doversi adattare ai diagrammi di Gantt di Bruxelles e non il contrario. Il tutto scandito da alcune priorità trasversali calate dall’alto, perfettamente intonate con la melodia prevalente nelle classi colte europee, dalla transizione energetica alla parità di genere. Questioni che saranno sicuramente importantissime ma sono, almeno questo andrebbe riconosciuto, del tutto eccentriche rispetto ai problemi che la pandemia ha sollevato.
In Italia, la redazione del piano è stata per lo più curata da vecchi funzionari nel contesto del governo PD-5S secondo un criterio di rivalsa dello Stato dopo i lunghi anni di controllo della spesa a causa della crisi finanziaria avviatasi nel 2008. Nel momento in cui è cambiato il governo, secondo uno schema già visto in passato, la differenza fra i “peggiori” e i “migliori” è stata circoscritta all’attuazione del Piano, evitando accuratamente di discutere delle questioni di fondo. L’imperativo è diventato “la messa a terra” del Piano in nome della quale nessuno avrebbe potuto disturbare i manovratori. Molti non lo hanno letto e gli è piaciuto.
Il risultato è un programma che, sotto la foglia di fico dell’immancabile “dialogo con le forze sociali”, si è rivelato un esercizio fortemente autoreferenziale. Accanto ad alcuni investimenti infrastrutturali improntati a criteri dubbi e discutibili (il trasporto su rotaia sempre e comunque, la determinazione a non fare nuove strade), abbiamo incontrato “titoli” di riforme (dalla giustizia al fisco) sulla carta importantissime ma destinate a rimanere scatole vuote, in assenza di una chiara scelta di campo. In più, nel Piano sono state riversate come in un imbuto iniziative che giacevano nei cassetti dei ministeri da tempo immemore (e forse non è un caso se non ne erano mai usciti). In fin dei conti rappresentano l’unico modo con cui la pubblica amministrazione è in grado di progettare il futuro, se gliene si dà la possibilità: partendo da se stessa.
Non si spiega diversamente il peso finanziario che ha, nell’ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – la Componente 1 che riguarda, appunto, la digitalizzazione della PA stessa: quasi 10 miliardi su 40, a fronte dei 6,7 dedicati a turismo e cultura, dei quali quelli espressamente rivolti al turismo come settore economico sono poco più di 2. Un’impostazione che, malgrado la retorica sul cambio di passo impresso dall’ultimo governo, tradisce la sua concezione nella fase in cui turismo e cultura rientravano nello stesso dicastero. Intendiamoci, nessuno (men che meno noi) discute l’importanza delle tecnologie digitali e dei Big Data ma qui sono le proporzioni che non tornano. Al pari dell’ennesimo finanziamento alla digitalizzazione senza un credibile cambio di passo che consenta di conseguire la piena interoperabilità tra i sistemi.
L’approccio statalista si estende anche alle misure più strettamente rivolte all’innovazione tecnologica, fra i cui cardini c’è la creazione di “campioni nazionali” nell’ambito di tecnologie importanti – dalla salute, al digitale, all’energia – ma scelte dall’alto. Come se in questi settori non esistessero n mercato, degli investitori, delle aziende, perfino delle autorevoli grandi charities, dei lavoratori, e tutto dovesse dipendere da un bando del Ministero dell’Università e della Ricerca per la creazione di un consorzio con «il coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione e attuazione dei progetti di ricerca».
Come se l’innovazione tecnologica fosse qualcosa che si “ordina”, nei tempi e nei modi concordati, e non l’esito, spesso imprevisto, di iniziative che difficilmente, nel mondo di oggi, possono essere semplicemente l’esito di programmi di ricerca e bandi definiti allo scopo.
Quando leggiamo del compiacimento generale perché in un anno e mezzo siamo riusciti a distribuire al sistema delle università italiane 11 miliardi di euro, noi non possiamo che chiederci: per fare cosa? Il “cosa” non può essere un dettaglio trascurabile. E invece pare lo sia, soverchiato dal quanto.
È uno strabismo che affligge, in misura forse ancora maggiore, anche la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – nella quale la Componente 1 – Potenziamento dei servizi d’istruzione: dagli asili nido all’università – si risolve in un gigantesco piano di keynesismo edilizio che verte, ancora una volta, sulla pubblica amministrazione che progetta di ampliare se stessa per risolvere i problemi che essa stessa individua. Basti citare lo sforzo, anche finanziariamente consistente, per ampliare l’offerta di servizi di childcare, che si risolve tutto nel triangolo MIUR-PCM-Comuni, ignorando le molteplici esperienze sussidiarie esistenti, dai nidi convenzionati, alle forme di autorganizzazione dei genitori associati, alle forme individuali sul modello delle tagesmutter.
Quello di affrontare problemi sociali costituendo o rafforzando una struttura pubblica che se ne occupi – dai centri per l’impiego alle case di comunità – è in fondo il vero filo conduttore del PNRR, che trova la sua sublimazione nella proliferazione di strutture di supporto e monitoraggio, dalla cabina di regia alle strutture di missione centrali, alle assunzioni a tempo determinato nei Comuni, agli esperti a contratto nelle Regioni e nei grandi Comuni, ai tecnici per il Sud, con il contorno di enti e organismi tecnici, agenzie, società in house, tutte variamente incaricate di fornire assistenza tecnica all’arcipelago di soggetti attuatori, o svolgere una qualche forma di monitoraggio o controllo. Il trionfo dell’autoalimentazione burocratica, nominalmente intesa a “semplificare” come recita la quasi totalità delle riforme ordinamentali che costituiscono parte integrante del Piano.
In un altro capitolo, diamo uno sguardo alla parte relativa agli investimenti nelle strutture ospedaliere e nei servizi sociosanitari territoriali intesi come hardware (Case e Ospedali di Comunità) a prescindere dai contesti inefficienti di partenza nelle diverse Regioni e dalla esigenza di non amplificarli. Ritorna l’assenza di ogni impronta sussidiaria nel momento in cui si trascura la ridefinizione del rapporto tra lo Stato (le Regioni) e i medici di medicina generale arrivando a sottendere l’idea impraticabile di farli dipendenti per riempire le Case di Comunità.
Non meno emblematica di un approccio tutto pubblicisticoè la parte relativa alle politiche attive del lavoro che
comprende il potenziamento dei Centri per l’Impiego e il programma nazionale per la presa in carico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale. Anche qui manca la premessa di un’analisi sullo specifico contesto italiano in cui da un lato le strutture pubbliche sono state cronicamente rattrappite dalle funzioni burocratiche assegnate e, dall’altro, hanno trovato possibilità di sviluppo le agenzie private e le attività di collocamento gestite da sindacati, associazioni di categoria, enti bilaterali.
Inoltre la formazione per l’occupazione è risultata largamente autoreferenziale e come tale inefficace. L’unico modo per ampliare l’offerta di servizi di collocamento mirato e di formazione utile sarebbe una piena e perfetta competizione tra operatori privati, privato-sociali e pubblici, senza le rendite di posizione di questi ultimi come la burocratica “presa in carico” che spesso rallenta molte ricollocazioni di lavoratori. La formazione non può più essere a catalogo in funzione di una astratta occupabilità ma deve essere tarata su “quella” persona in funzione di “quella” impresa dalla quale il percorso è partito. L’inclusione dei soggetti svantaggiati dovrebbe essere affidata a una adeguata premialità per tutti gli erogatori di servizi, in proporzione al motivo di svantaggio e con segnalazione ai titolari delle politiche sociali di coloro che risultano, nell’immediato, inidonei al lavoro per dipendenze o altre ragioni.
Il premio, se adeguato, potrebbe anche sostituire il pagamento del datore di lavoro (per il servizio) che risulterebbe così incentivato. Si oppongono a questa impostazione l’ideologia di coloro che concepiscono il collocamento come una funzione solo pubblica e l’opportunismo di molti enti formativi che resistono a ogni ipotesi concorrenziale. In molte burocrazie regionali non sembra impedita la somma delle cariche.
Nel complesso il PNRR, come ha osservato sin dalle sue prime bozze la nota rete di associazioni cattoliche “Diciamolo sui Tetti” di fronte al Segretario di Stato della Santa Sede, non è affatto sussidiario. Molto spesso “quella” spesa può non essere solo inefficace ma può rivelarsi ulteriormente distorcente il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico. La revisione è consentita e auspicabile. Se lo Stato si fa “capacitatore” di soggetti sussidiari e di mercato, moltiplica la resa della spesa.