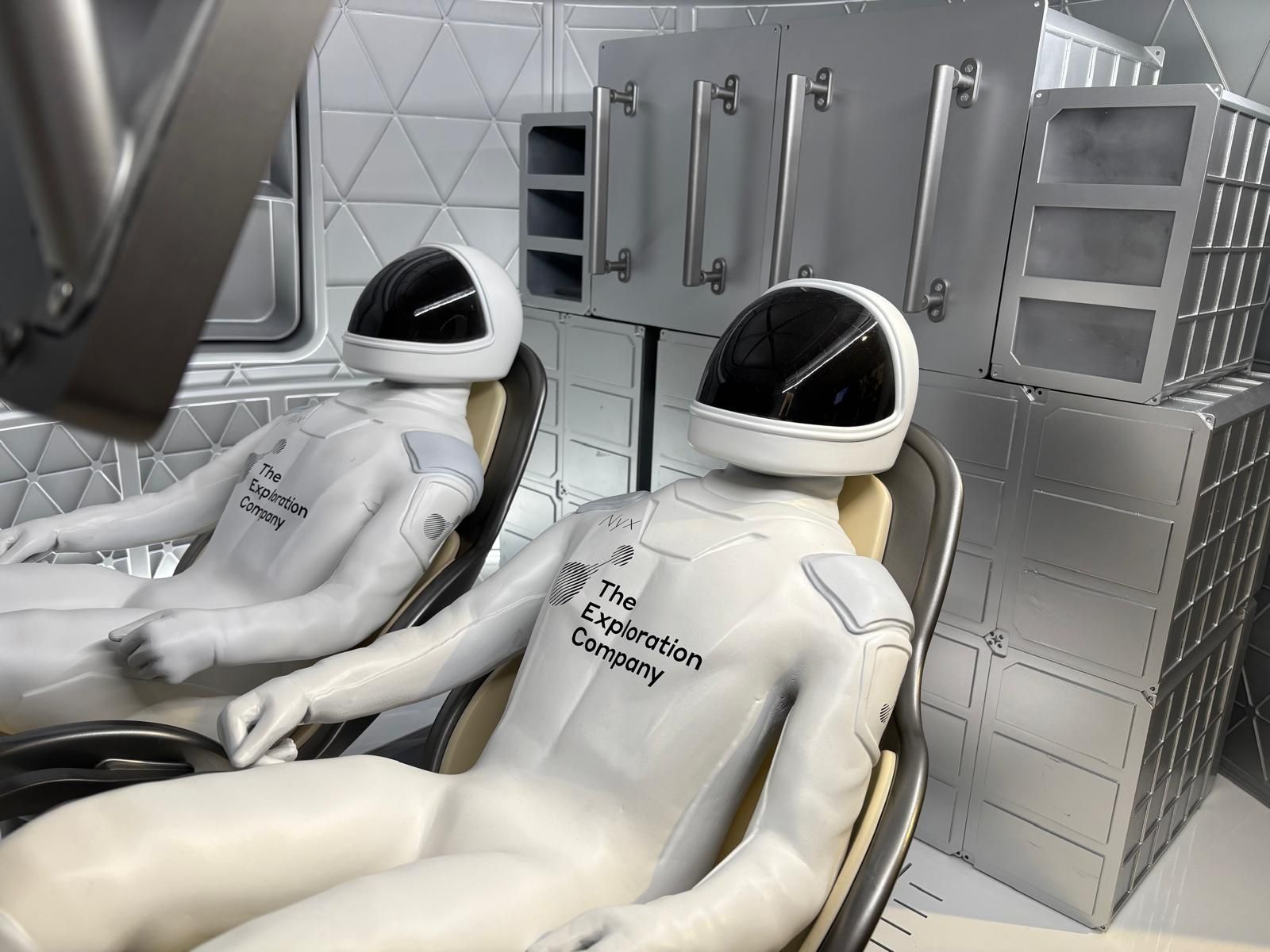“Evitare vane rincorse prezzi – salari”. Sono le parole con cui – martedì, in occasione delle Considerazioni Finali sulla relazione annuale 2021 dell’istituto – il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, ha riaperto un dibattito che ci riporta indietro di 30/40 anni nella storia economica del nostro Paese.
Proprio nello stesso giorno l’ISTAT ha comunicato che a maggio l’indice di prezzi è cresciuto del 6,9% (7,3% l’indice armonizzato) rispetto a maggio 2021 e siamo al nono mese consecutivo in cui l’inflazione supera il 2%, con gli ultimi tre mesi sempre oltre il 6%. Ormai la pressione sul potere di acquisto delle famiglie non è più un fenomeno transitorio, ma presenta caratteri permanenti che richiedono risposte efficaci e rapide. Ancor più se si considera che tale livello di inflazione – senza precedenti nella storia dell’eurozona – non è più solo l’effetto dell’aumento dell’energia, ma si riscontra un forte dinamismo nella cosiddetta “componente di fondo” (al netto di costi energetici ed alimentari freschi) che ha maggio ha fatto segnare una crescita del 3,3% (2,4% ad aprile).
Secondo il governatore Visco la pressione sui salari si riduce attraverso interventi mirati a carico del bilancio pubblico. Tuttavia, “va evitato il ricorso al debito”. Insomma, bisogna raschiare il fondo del barile, come sta facendo il governo Draghi dall’autunno 2021, bloccando altre spese e sperando che le tasse sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico portino gli 11 miliardi sperati. Ma le soluzioni possibili non si esauriscono affatto a quanto fatto finora, perché è possibile ragionare su altri interventi di ben più ampio respiro – come il taglio del cuneo fiscale – anche sotto la tagliola dei saldi di bilancio invariati. Il raggio d’azione della politica di bilancio per aumentare i salari, agendo sulla leva fiscale, non può esaurirsi ai 200€ una tantum visti finora.
Perché il problema della perdita di potere di acquisto dei salari non nasce oggi, ma ha origini lontane nel tempo. Ed è il recente documento delle previsioni economiche di primavera, pubblicato dalla Commissione UE a metà maggio, ad offrirci l’impressionante perdita di potere d’acquisto che attende i salariati in Italia. In termini reali (quindi al netto dell’inflazione), dopo il -2,5% del 2021, i salari reali sono attesi diminuire del 3,2% e 1%, rispettivamente per 2022 e 2023. L’inflazione morderà in modo feroce. Soprattutto considerando che, dal 2003, la loro crescita è stata sostanzialmente pari a zero, con i salari nominali che a stento hanno tenuto il passo dell’inflazione.
Di fronte a questo quadro, è francamente desolante il quadro delle soluzioni offerte dal fronte politico. Da un lato abbiamo l’arcaico “il problema è la produttività del lavoro”- che imputa alla bassa produttività la stagnazione dei salari – di cui si sono fatti alfieri l’onorevole Luigi Marattin e l’economista Carlo Cottarelli, e già questa insolita comunanza dovrebbe far riflettere. Dall’altro abbiamo il segretario del PD Enrico Letta che apre al salario minimo, seguito a ruota dal segretario della CGIL, Maurizio Landini, che si lamenta del basso livello dei salari, invoca l’adozione del salario minimo, si scaglia contro la precarietà e chiede più investimenti in innovazione e ricerca.
Tutto ed il contrario di tutto, da parte di chi dovrebbe avere la difesa del potere di acquisto dei salariati in cima ai propri obiettivi istituzionali.
Ma questa confusione non nasce oggi. La produttività del lavoro non è causa ma effetto delle variazioni salariali. Se si rende il lavoro precario e flessibile, cosa volete che accada alla produttività? Cala e si avvita in un circolo vizioso con il livello dei salari. Ma c’è ancora un altro aspetto: la produttività è effetto della domanda che è stata sempre compressa (soprattutto consumi ed investimenti pubblici), almeno dal 2012. Da ultimo, in un Paese in cui sono stati sistematicamente compressi consumi interni e investimenti, come volete che sia stato possibile conseguire quel minimo di crescita che abbiamo avuto dal 2012 al 2019? Attraverso una crescita delle esportazioni sostenute da un significativo deprezzamento del cambio reale. Cioè, fermo il cambio nominale perché aderiamo all’euro, una minore inflazione rispetto a quella dei nostri partner commerciali. E quando si parla, di minore inflazione, il costo del lavoro è al primo posto. Bastano poche cifre per fornire un’idea del fenomeno. Nei 5 anni dal 2013 al 2017 (ma anche 2018 e 2019 restituiscono la medesima dinamica) i salari nominali medi pro capite sono cresciuti, in media annua, del 0,6% (1,5% in eurozona), i salari reali sono rimasti stazionari (+0,7% in eurozona). La produttività del lavoro è cresciuta del 0,3% (0,7% in Eurozona). Il risultato finale sul Clup – costo del lavoro per unità di prodotto, che è il rapporto tra salari e produttività – è stato chiaro: è cresciuto solo del 0,3%, contro il 0,7% dell’eurozona. Ecco come abbiamo guadagnato competitività: con una straordinaria stagione di moderazione salariale, che ha più che compensato una modesta dinamica della produttività. Lo stesso dicasi a partire dal 2018 al 2021 e, in previsione, dal 2022 al 2023. Siamo riusciti a contenere la crescita del Clup al di sotto della media dell’eurozona, pur con una produttività che continua ad essere stagnante, contenendo la crescita dei salari.
Vien quindi da chiedersi dove fossero in quegli anni Letta e Landini, che ora si ritrovano, fulminati sulla via di Damasco, a chiedere quel salario minimo a difesa del lavoro precario, quando questo è stato invece il carburante di una effimera ripresa con numeri da prefisso telefonico e con costi sociali enormi.
È tutto da dimostrare che il salario minimo riesca a contenere la strutturale tendenza alla deflazione salariale dell’eurozona o invece provochi un ulteriore schiacciamento verso il basso dei salari. D’altro canto, è ampiamente dimostrato che la produttività arriva con i consumi e gli investimenti ed è bassa anche perché i salari sono bassi. Non il contrario.