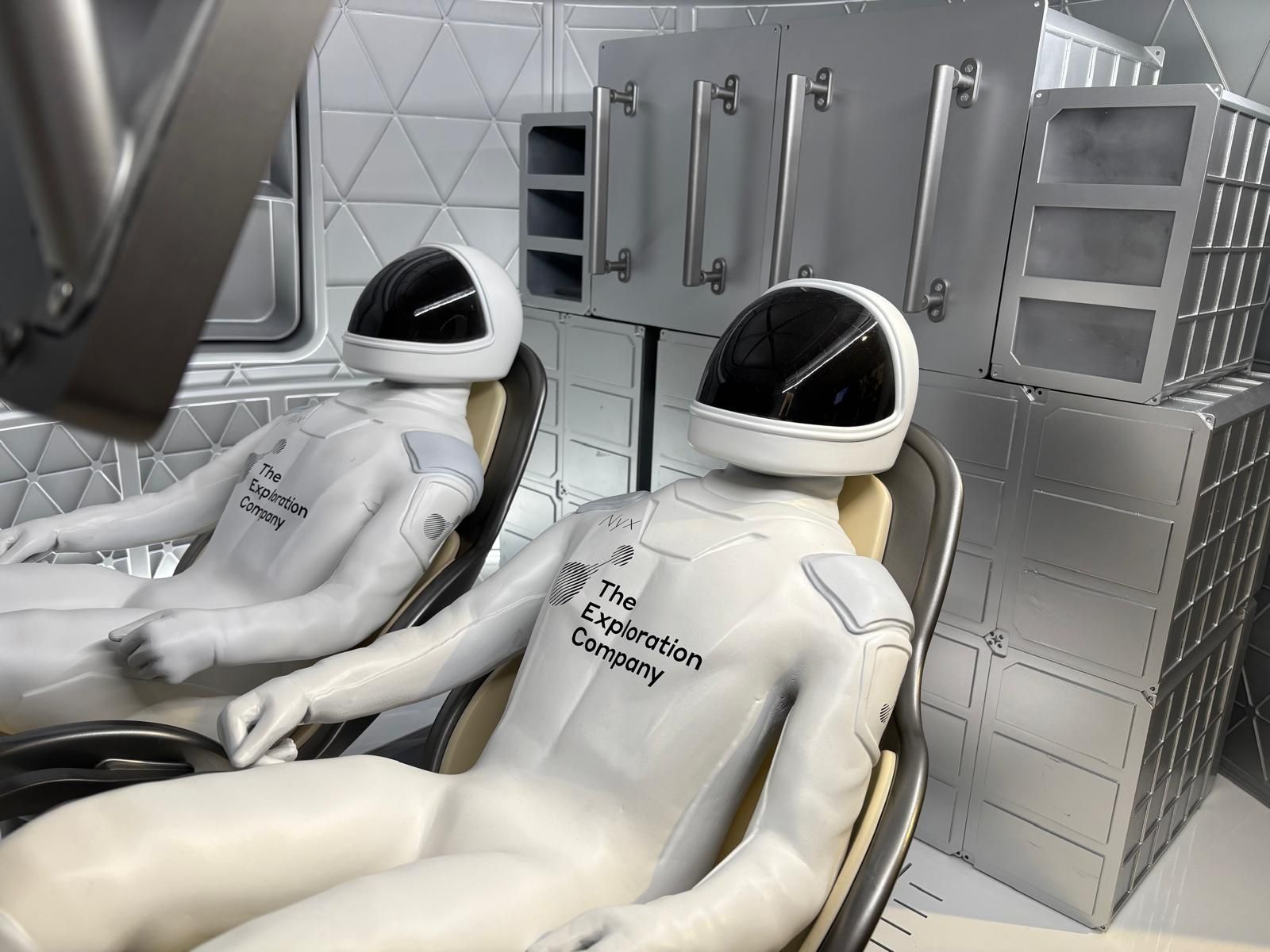L’invasione russa dell’Ucraina tira in ballo l’Unione Europea su più fronti.
Il più immediato è quello eurasiatico. Dopotutto, oggi come oggi è il fianco orientale dell’Unione e della NATO a essere esposto all’aggressività russa, e proprio su quel versante si registrano importanti svolte, come la decisione tedesca di procedere ad un massiccio riarmo e di sospendere le autorizzazioni al gasdotto Nord Stream 2. Sull’Ucraina, dopo qualche iniziale esitazione, anche l’Italia ha scelto di fare la sua parte, aderendo alle sanzioni e muovendosi all’unisono con USA e UE. Ciò comporterà inevitabili contraccolpi economici, che già mettiamo in conto: rincari drastici dei prezzi, commesse cancellate ed esposizioni del nostro sistema creditizio. Non va però sottovalutato l’impatto della guerra in Ucraina nemmeno sul Mediterraneo e sull’Africa. Ecco perché.
Il primo aspetto da esaminare è quello strategico-concettuale, in cui riesce difficile separare Cina e Russia. La sfida all’Occidente oggi non passa solo dall’Eurasia, ma anche dall’Africa. Oggi la Cina è l’incarnazione dell’incubo più nero degli strateghi anglo-americani: una potenza in grado di riunire l’Eurasia e saldare Eurasia e Africa, dando corpo al mega-blocco che Halford Mackinder chiamava ‘Isola-Mondo’.
Da soli, gli USA non sono in grado di arginare la Cina. Lo hanno capito anche i francesi, che puntano a rinsaldare i rapporti con gli USA assecondandone il principale vettore, cioè l’enfasi sull’Indo-Pacifico.
Ma gli USA stanno facendo capire che il ruolo della Francia, pur apprezzato, deve essere altrove. Nel Mediterraneo, dove i cinesi si sono ormai fatti largo, e ancora di più in Africa, dove Parigi ha già una forte presenza che, unendo le forze con l’Italia, aiuterebbe a presidiare meglio il Continente Nero. Con Francia e Italia nel ruolo di ‘proconsoli’ nel Mediterraneo e in Africa, gli americani potrebbero concentrarsi sull’Indo-Pacifico insieme ad australiani, giapponesi e indiani.
In quest’ottica si colora di sostanza anche il recente Trattato del Quirinale tra Italia e Francia che si è firmato anche perché gli USA non lo vivono con fastidio. Il testo contiene espliciti riferimenti alla NATO e all’articolo 5 dello Statuto NATO. Quanto alla Turchia, è da escludere che gli americani vedrebbero di buon occhio un arroventamento nei rapporti tra Roma, Parigi e Ankara. I turchi, infatti, sono a loro volta strumentali a contenere l’asse sino-russo in Medio Oriente, Asia Centrale e anche in Africa.
Il secondo fattore per cui l’Italia sarà letteralmente costretta a guardare a Sud è di ordine contingente e ha a che fare con la geoeconomia alimentare. Come conseguenza della guerra in Ucraina, sono da mettere in conto shock in Africa. La storia offre esempi recenti di cosa potrebbe accadere.
Diversi analisti hanno provato a ricostruire la sequenza di eventi da cui scaturirono la rivolta tunisina del pane e la primavera araba del 2011. Molte analisi, in particolare, sottolineano l’impatto di una anomalia meteoclimatica nell’anno precedente. Anche la reportistica per l’anno 2010 a cura del National Climatic Data Center del Dipartimento Americano del Commercio conferma l’esistenza di un’ondata di calore anomala su larga scala occorsa sulle regioni euroasiatiche durante l’estate. L’ondata di calore si è rivelata particolarmente intensa sull’area compresa tra la Federazione Russa, Ucraina e Kazakhstan, dove si verificarono numerosi incendi nei campi di grano, con un conseguente shock nella produzione complessiva della regione, in calo 32.74% per la Federazione Russa, 19.38% per l’Ucraina e 43.12% per il Kazakistan.
Come conseguenza il prezzo del grano aumentò sul mercato globale con un picco secondo soltanto al prezzo registratosi durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008. A farne le spese fu soprattutto il Maghreb, dove si trovano alcuni dei primi venti importatori di grano al mondo (Egitto, Algeria, Marocco, Tunisia, Libia) e dove vecchi gruppi dirigenti avevano mantenuto per decenni la presa sulle istituzioni pubbliche, con enormi accumuli di ricchezza e potere nelle tasche e nelle mani di pochi.
Situazioni difficilmente sostenibili, equilibri fragili su cui la geopolitica del cibo si è abbattuta con forza, e che potrebbero riproporsi se la guerra in Ucraina continuasse, funestando le raccolte del ‘granaio del mondo’. All’epoca l’Italia faticò non poco a governare le conseguenze degli shock nell’offerta alimentare, tra cui un robusto flusso di migranti economici.
Sapremo farci trovare preparati al prossimo shock?