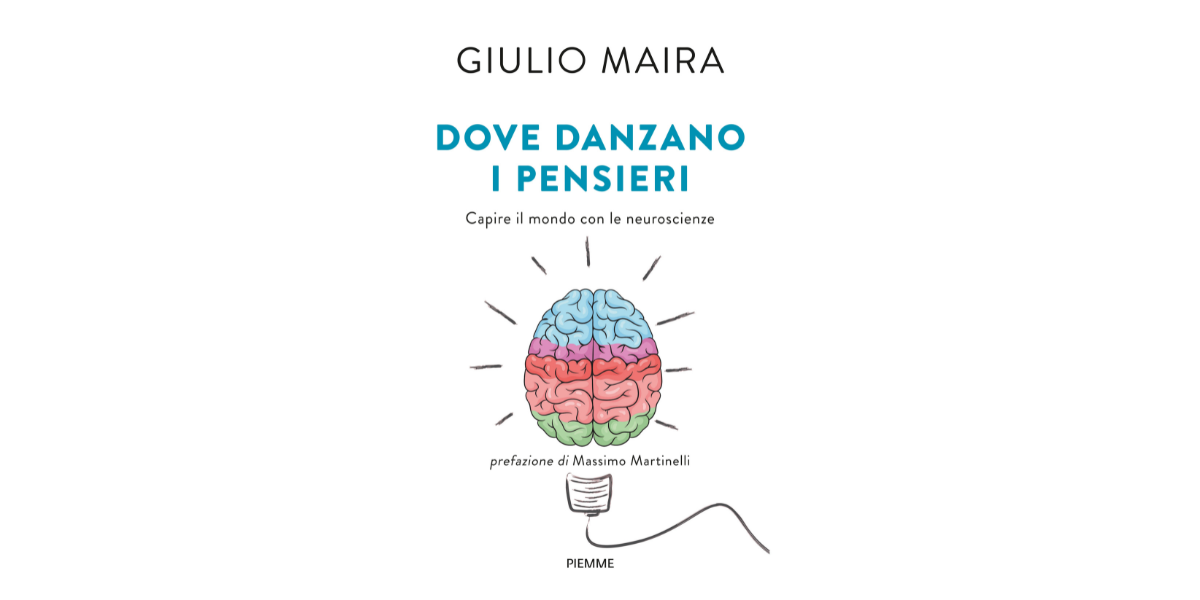In Europa abbiamo inevitabilmente perso presa e rispetto con l’autoesclusione di Meloni nella partita e i danni cominciano a sentirsi con l’irrigidimento delle sanzioni nei nostri confronti che sono già tante (ben 60) e alle quali si aggiunge in queste ore la questione dell’assegno unico, con una sentenza della Commissione che ci critica per le modalità di erogazione e l’esclusione degli immigrati, colpendo ancora una volta i nostri conti pubblici e la stringente adesione al nuovo Patto di stabilità.
E noi ci presentiamo all’appuntamento della ripresa post estiva con un governo indebolito da tensioni tra Forza Italia e Lega, il ministro Giorgetti che carica sul Ragioniere generale dello Stato responsabilità di ulteriore debito che si ritroverà comunque con il successore di Mazzotta di 2.933 miliardi di debito pubblico. La legge di bilancio che non potrà non tagliare la spesa pubblica cominciando dalle pensioni perché nonostante la presentazione del bilancio consuntivo di Inps 2023 presenti una stabilità del sistema c’è da tenerlo rigorosamente sotto controllo per le nuove sfide e i rischi già evidenti legati alle dinamiche demografiche e del mercato del lavoro che si impoverisce sempre di più.
La globalizzazione dopo essere stata a lungo esaltata come motore di sviluppo è considerata con i flussi migratori una delle più pesanti ragioni della crisi di fiducia che ha portato la Gran Bretagna a uscire dalla Ue tranne poi oggi con il nuovo premier rivedere atteggiamenti di isolamento su posti di lavoro perduti.
In Italia salari che non crescono, crescenti ineguaglianze di reddito, deficit commerciali, tutte forse cause della globalizzazione ma la verità è che la disuguaglianza può essere trattata in modi molto diversi, a seconda degli indicatori che si considerano: se si parla di disuguaglianza di ricchezza o di reddito, se si guarda ai super ricchi e agli ultra poveri, oppure se si guarda, alla terza società, quella degli esclusi.
Oltre il problema delle crescenti disuguaglianze, ha preso via via importanza la questione della divaricazione degli andamenti di occupazione e salari per le differenti fasce di qualificazione professionale, la cosiddetta polarizzazione delle skills per tantissime realtà europee: c’è un fenomeno di crescita degli occupati nei settori ‘alte qualifiche’, dove prevale un più alto salario e in quelli ‘basse qualifiche’ che corrispondono a professionalità di base, dove domina un più basso salario.
Vediamo poi una altalenante decrescita dell’occupazione e una stagnazione dei salari per la fascia media di qualificazione professionale.
La globalizzazione come la ragione principale della polarizzazione delle skills, anche se la causa immediata è rappresentata dalle macchine computerizzate e dai robot che sostituiscono i lavoratori a medio salario. È così che la globalizzazione, da fattore che doveva contribuire a favorire la crescita e il benessere, diviene elemento di freno e di disagio, da demonizzare.
La globalizzazione è un qualcosa difficilmente separabile dal mondo in cui viviamo, ne costituisce, oggi ma anche domani, la parte di cambiamento legata agli scambi e al confronto con realtà sempre nuove e diverse. È però chiaro che, accanto ai suoi effetti positivi, a cominciare dall’aumento di reddito e benessere realizzato dai Paesi emergenti, ci sono i perdenti della globalizzazione nei Paesi avanzati e, allo stesso tempo, le categorie che negli stessi Paesi sono riuscite a far aumentare a dismisura la loro ricchezza.
Vero è che il mancato governo della globalizzazione ha provocato questi risultati e, allo stesso tempo, ha messo in concorrenza occupati con basse qualifiche e immigrati con basse professionalità, ed è anche vero che la richiesta di lavoro a bassa qualificazione apre la strada a nuova immigrazione poco qualificata.
La rinnovata Unione europea deve attivare un ampio programma di politiche sociali che diano un messaggio rassicurante all’opinione pubblica e siano capaci di porre un argine a questi fenomeni, anche orientando opportunamente le politiche di coesione a livello territoriale.
Noi in Italia siamo assolutamente indietro nel recepire concretamente alcune direttive che, oltre che causarci sanzioni pecuniarie rilevanti, ci mettono in difficoltà nel fare pesare la situazione nazionale sui rapporti con le parti sciali e dunque nelle relazioni industriali. È il caso della questione riferita al salario minimo: 22 dei 27 membri dell’Unione europea hanno un salario minimo nazionale. Danimarca, Italia, Finlandia, Austria e Svezia no.
La direttiva dell’Ue mira a stabilire un quadro di riferimento per: l’adeguatezza dei salari minimi legali, la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari; il miglioramento dell’accesso effettivo dei lavoratori ai loro diritti di tutela del salario minimo. Noi, in Italia, dobbiamo irrobustire la contrattazione collettiva e dunque il rapporto con i sindacati e le associazioni datoriali, ancora timidamente e colpevolmente blando.