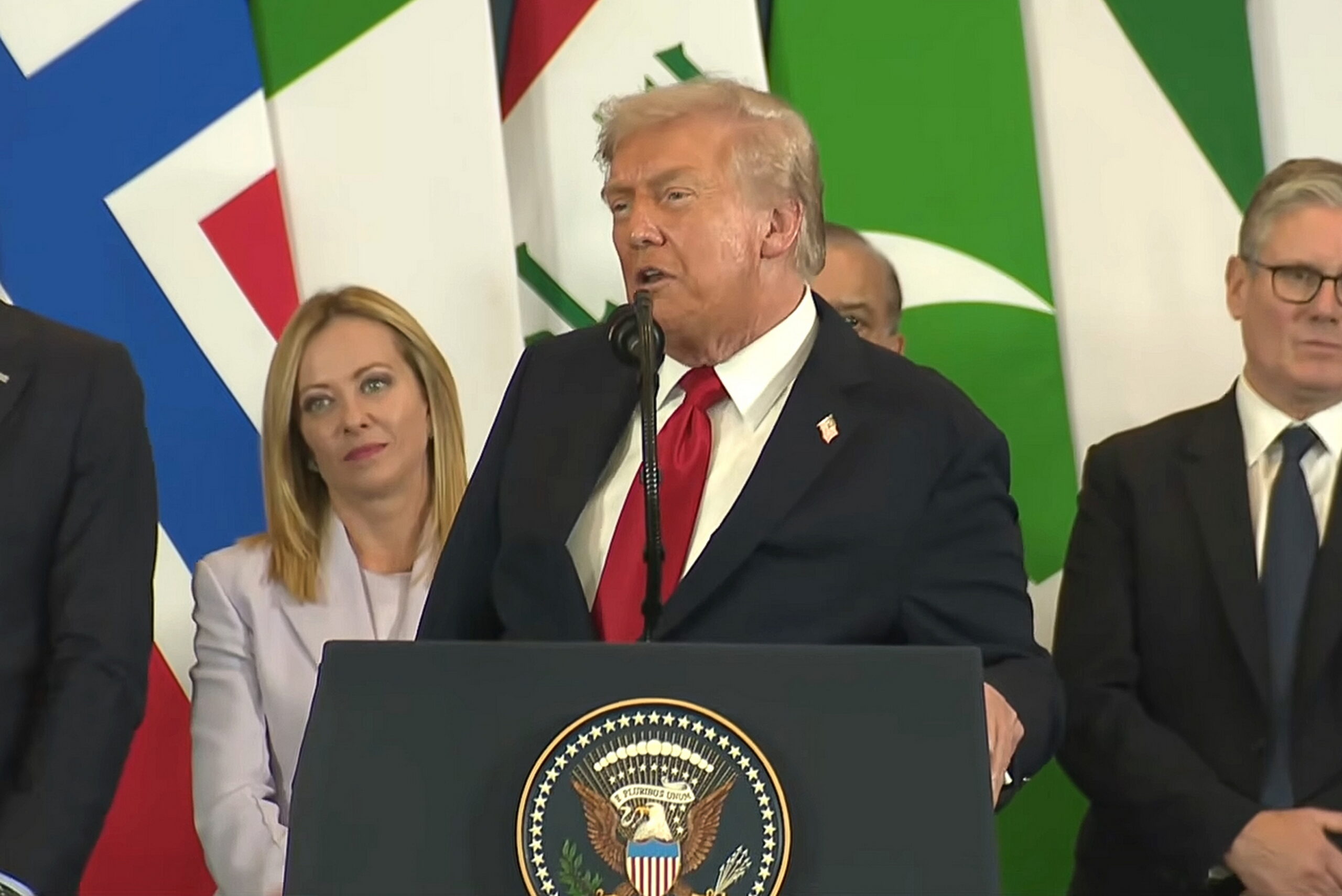“L’Italia sequestra beni per 600 milioni di euro in relazione a presunte frodi comunitarie”. Così ha titolato il Financial Times in prima pagina l’articolo di apertura del 5 aprile. Nel quale, riprendendo gli annunci stampa della Guardia di Finanza italiana e dell’Ufficio del Procuratore Europe (EPPO), riferisce che “la polizia italiana e di diversi altri Paesi europei ha arrestato 22 persone e sequestrato beni per un valore di 600 milioni di euro in relazione a presunte frodi riguardanti il fondo di recupero post-pandemia dell’UE”. “La Guardia di Finanza italiana – scrivono le corrispondenti da Palermo, Amy Kazmin, e da Bruxelles, Paola Tamma – ha dichiarato di aver sequestrato appartamenti, ville, auto di lusso, orologi e gioielli per un valore complessivo di oltre 600 milioni di euro”. Precisando che “l’annuncio di questa presunta frode potrebbe riaccendere le preoccupazioni sul potenziale uso improprio del fondo di ripresa dell’Ue da 800 miliardi di euro. Un programma di prestiti congiunti una tantum lanciato per rilanciare l’economia del blocco dopo la pandemia di Covid-19”. E ricordando che “l’Italia è il principale beneficiario del fondo, che dovrebbe ricevere circa 200 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti”.
L’importanza di una corretta comunicazione antifrode
É una notizia il cui clamore non fa certo bene all’Italia, ma nemmeno all’Unione europea. Perché data in periodo di verifica della spesa del Pnrr e di vigilia delle elezioni europee. Durante il quale le opinioni pubbliche nazionali, soprattutto nei Paesi cosiddetti “frugali”, possono essere pericolosamente influenzate dal clamore, senza adeguata spiegazione, dell’uso indebito fatto in Italia del denaro dei contribuenti europei.
Ancorché le autrici dell’articolo abbiano correttamente riferito che, secondo quanto dichiarato dalla Guardia di Finanza, l’indagine ha dimostrato “l’esistenza di controlli adeguati per garantire la “corretta esecuzione” dei fondi, e “recuperare il denaro dell’Ue ottenuto illegalmente”. Ma anche che “la Commissione europea ha dichiarato di aver preso atto dell’annuncio”, e che il Pnrr “contiene un quadro di controllo molto solido”.
Dove “quadro di controllo molto solido”, significa che notizie come questa, riportate da tutti i media nazionali, spesso con minore prudenza e precisione del Financial Times, e riprese da tutta la stampa europea, possono assumere un rilievo importante anche nelle valutazioni – che la Commissione starebbe già facendo – sul prossimo bilancio Ue. La cui proposta è prevista per luglio 2025. Laddove circolano già voci secondo le quali i “frugali” chiederebbero una estensione a tappeto dei controlli stringenti previsti per il PNRR. Con la evidente differenza che mentre i fondi Next Generation Eu sono debito comune, garantito dal bilancio UE, i fondi di coesione e della PAC sono contributi degli Stati Membri. E l’Italia è un contribuente netto al bilancio, al netto di NGEU.
Quindi, mai come in questo momento, anche la meritoria attività operativa della Guardia di Finanza e della magistratura italiana, coordinate in questo caso dall’EPPO, deve essere comunicata all’opinione pubblica, e non solo agli addetti ai lavori, con estrema professionalità e chiarezza. Nell’interesse nazionale, ma anche della stessa Unione Europea, che può essere vittima di campagne di delegittimizzazione basate sulle distrazioni criminali dei fondi Ue, pagati dal contribuente.
Cosa si dovrebbe fare?
A mio avviso bisognerebbe innanzitutto abbattere la storica timidezza derivante dal riconoscimento dei nostri vizi etici nazionali. Che non significa nasconderli, né trasformare i complessi di colpa in arroganti, ed inutili, pugni sul tavolo. Bensì pretendere dalla Commissione europea la raccolta di dati oggettivi, e comparabili, sugli strumenti investigativi e giudiziari a tutela del bilancio Ue di cui dispone l’Italia, rispetto a quelli di cui dispongono gli altri Stati membri.
Obbligando poi la Commissione a renderli noti all’opinione pubblica europea, a cominciare da quella dei Paesi “frugali”. Che avrebbe la sorpresa di scoprire che l’Italia dispone di mezzi investigativi a tutela delle finanze Ue che sono armi nucleari, rispetto alle fionde che usano invece la maggior parte degli altri Paesi, a cominciare proprio dai “frugali”.
L’esempio del Belgio del Qatargate
Prendiamo, tanto per fare un esempio, quello del Belgio. Teatro del Qatargate che, dal punto di vista investigativo, sinora è stata la montagna che ha partorito un topolino. Oltre ad essere sede delle principali istituzioni Ue, ha un’opinione pubblica generalmente critica verso gli stereotipi “mafia, pizza e corruzione” del nostro Paese. Innanzitutto, in Belgio, a differenza dell’Italia, l’azione penale non è obbligatoria, ed il pubblico ministero dipende dal Ministro della Giustizia. Rispetto all’Italia poi, che ha un numero di appartenenti alle forze di polizia tra i più alti in Europa, 306.000 addetti (453/100.000 abitanti), il Belgio ne ha solo 37.000 (337/100.000). Mentre in Italia vi sono ben tre grandi forze di polizia nazionali, il Belgio dispone di una sola e piccola polizia federale.
Senza dimenticare inoltre che, nonostante le grandi infiltrazioni di organizzazioni di tipo mafioso, che gestiscono il contrabbando (non solo di droga) che entra in Europa dal porto di Anversa, il Belgio non dispone della legislazione antimafia, né della Procura Nazionale antimafia e antiterrorismo italiana, considerata all’avanguardia nel mondo. E neppure di servizi investigativi interforze paragonabili alla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia.
Non parliamo poi delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Utilizzate per moltissimi reati, ed in grandissima quantità in Italia, comprese le truffe ai danni del bilancio dell’Ue, in Belgio sono permesse per pochissimi reati (prevalentemente terrorismo e tratta di esseri umani), e con molta moderazione. Secondo il quotidiano belga “Le Soir” del 2 agosto 2018, la polizia belga, nel 2017, ha effettuato infatti solo 7.475 intercettazioni telefoniche, nel quadro di 956 indagini giudiziarie. Il cui costo è stato di 6 milioni di euro. Quando, nel solo 2019, in Italia, vi sono state ben 120.810 intercettazioni (97.159 telefoniche – 17.127, ambientali – 6.524 informatiche), per un costo che si è aggira attorno ai 200 milioni di euro l’anno.
Il Ministro degli Affari europei dispone di un nucleo della Guardia di Finanza
Se fossi quindi il ministro per gli Affari europei, che dispone anche di un nucleo speciale per la repressione delle Frodi comunitarie, retto da un Generale, farei impartire dal Governo alla Guardia di Finanza l’ordine di ricordare, sempre e molto chiaramente, in ogni attività di comunicazione operativa e promozionale a tutela degli interessi finanziari Ue, che la stessa, composta da oltre 60.000 effettivi, dispone di un arsenale di strumenti investigativi e normativi a tutela anche delle finanze Ue, incomparabilmente superiore a quelli di cui dispongono i corpi di polizia di tutti gli altri stati membri. E che l’Italia è l’unico Paese europeo a disporre di una polizia economico-finanziaria di tali dimensioni.
Ed è qualcosa che solo il governo, nell’interesse generale nazionale, può chiedere ad una forza di polizia. Perché, come è normale che avvenga, ogni forza di polizia avrà sempre remore a riconoscere che ha più mezzi e risorse degli altri, e che non è soltanto più brava. Visto che è fisiologico che ogni organismo tenda sempre a richiedere maggiori mezzi e risorse, piuttosto che dichiarare che ne ha più di altri. Ma, in questo caso, è in gioco la credibilità nazionale e, come ricordato, anche quella dell’uso delle finanze Ue. Ed è quindi una linea di comunicazione che dovrebbe essere dettata dal Governo del Paese.
Comparare le percentuali di PIL destinate alla tutela degli interessi finanziari Ue
Sui tavoli di Bruxelles, poi, l’Italia non dovrebbe limitarsi a ricordare che le frodi in Italia si scoprono non solo perché il nostro Paese non manca certo di delinquenti, ma anche perché da noi si cercano e si combattono più che altrove.
Dovrebbe invece cominciare a pretendere, con fermezza e costanza, accompagnate da informazioni alla stampa internazionale, che anche gli altri stati membri investano nella lotta alla frode Ue percentuali di PIL simili a quelle che l’Italia spende a difesa delle finanze Ue. E basterebbe indicare una buona parte del bilancio della Guardia di Finanza, che quest’anno festeggia due secoli e mezzo di storia, cui andrebbe aggiunto parte di quello delle altre forze di polizia, per fare impallidire per senso di colpa la maggior parte dei Ministri dell’economia dei Paesi cosiddetti “frugali”.
Dopo che, dal 1990, l’Italia è riuscita, con molta fatica, a fare modificare il modo di presentazione dei rapporti antifrode Ue della Commissione europea, grazie a ministri delle Politiche europee pro tempore, quali Emma Bonino e Andrea Ronchi, ed agli sforzi in tal senso coordinati da generali illuminati come Nicolò Pollari, che hanno portato alla creazione di un Nucleo Speciale della Guardia di Finanza per la repressione delle Frodi Ue presso il Ministero degli Affari Europei, continua a non spettare certo ai “frugali”, ma all’Italia, spiegare ciò anche alle loro stesse opinioni pubbliche.
Deve essere data più attenzione alla stampa estera
L’attività di comunicazione del nucleo della Guardia di Finanza presso il ministero degli Affari europei dovrebbe essere intensificata soprattutto nei confronti della stampa internazionale, e non solo di quella nazionale. Mentre quest’ultima dovrebbe essere costantemente sensibilizzata sui limitati strumenti investigativi utilizzati negli altri stati membri. Il che non significa mai nascondere le frodi scoperte e perpetrate dai criminali nostrani, perché sarebbe inaccettabile, ma dare la giusta dimensione del problema. Sottolineando cioè l’esigenza che anche gli altri Paesi si dotino di strumenti adeguati ai nostri per difendere il denaro pubblico europeo.
E questo dovrebbe essere fatto al più presto, e con professionalità, se non vogliamo che il nostro virtuosismo investigativo si ritorca contro i nostri interessi generali.
Una comunicazione professionale verso tutti, e non solo gli addetti ai lavori
Sono cose che, personalmente, dico e scrivo da decenni, soprattutto nell’ambito della Rete dei Comunicatori Antifrode dell’Olaf. Da ultimo in un mio recente libro (“Io, l’Italia e l’Europa: Pensieri in libertà di un patriota italiano-europeo”, Le Colibrì Editrice, Gubbio), che mi permetto di citare solo perché tutti i diritti d’autore li dono allo Sportello Anti-Stalking del Codacons ed all’Operazione “Mato Grosso”. Prima e dopo averle precisate anche nei comunicati stampa dell’Olaf (l’Ufficio Europeo per la Lotta alla Frode), che firmavo quando, nel primo decennio del secolo ne ero il portavoce. E sono cose che, passo dopo passo, sono ormai diventate note agli addetti ai lavori si tutti gli stati membri dell’Ue. Ma è ora che le stesse cose vengano fatte conoscere, dicendole in modo forte e chiaro, anche alle opinioni pubbliche nazionali. Che le ignorano sull’onda dei soliti stereotipi negativi sul Belpaese.
Intensificando l’azione di comunicazione nei confronti della stampa estera. Utilizzando anche la rete di esperti della Guardia di Finanza nelle nostre ambasciate. Che dovrebbero ricevere anche il compito di fare conoscere quanto investe nella lotta alla frode Ue l’Italia, non solo in assoluto, ma anche, e soprattutto, rispetto ai Paesi europei nei quali prestano servizio. Aiutando peraltro il governo ad avere una ricognizione delle risorse, umane, finanziarie e legislative, utilizzate dagli altri Paesi nella tutela del bilancio Ue.
In altri termini, divulgando un messaggio fatto di cifre e statistiche che non deve continuare ad essere sussurrato in qualche riunione del Consiglio Ue o della Commissione europea. Dove gli addetti ai lavori, come detto, lo sanno e lo riconoscono ormai da tempo. Perché non é certo il messaggio percepito dalla maggioranza dei lettori del Financial Times e degli altri giornali europei. Che non fa bene all’Italia, ma nemmeno all’Europa.