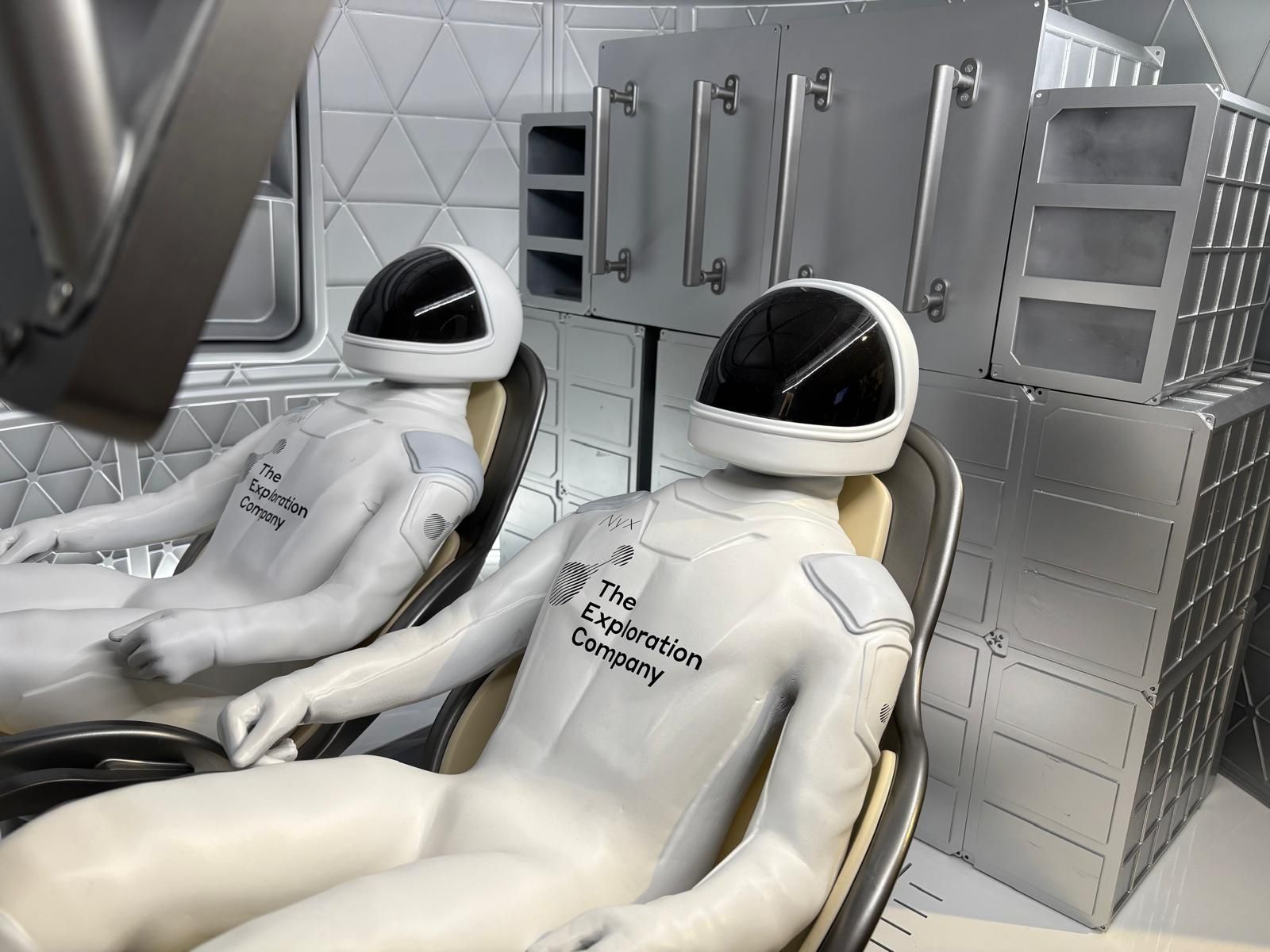Sul salario minimo sono in corso audizioni informali alla Commissione Lavoro della Camera sulle varie proposte di legge, ma la questione è lontana dal trovare una equilibrata soluzione.
Nel PNRR lo si propone solo “per i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva”. Quindi non si vuole il salario minimo perché tutti i lavoratori sono sulla carta coperti? Bisogna evitare queste ipocrisie perché ben sappiamo da fonte certa (Cnel) com’è la situazione reale.
Partiamo dalla considerazione che la questione si pone in Italia dopo l’accordo sulla direttiva UE per il salario minimo, perché questa comune regola europea aiuta i poveri, che sono cresciuti. Ma purtroppo sono cresciuti anche i poveri che lavorano: una volta si pensava che i poveri fossero solo i disoccupati; adesso lavorare ed essere poveri è veramente un paradosso intollerabile.
Nella Direttiva si specificano due possibilità: o stabilire un salario minimo per legge come fanno già molti Paesi ma non l’Italia; oppure, per i Paesi che non vogliono un intervento legislativo, si devono rafforzare i contratti collettivi nazionali, prevedendo salari giusti.
In Italia ci sono contratti ‘cosiddetti pirata’ che non danno nessuna garanzia. Addirittura, alcuni lavoratori di settori deboli non sono coperti da contratti e quindi hanno un salario di 4-5 euro all’ora. C’è comunque una spinta nella direzione di adottare il salario minimo, anche da parte dei sindacati, ma guardando come ha agito la Germania, ad esempio, che ha alzato il salario minimo orario a 12 euro. La Francia ha una norma simile. Si può dare forza ai contratti conclusi dalle parti maggiormente rappresentative affinché si applichino a tutti.
I salari minimi nei paesi Ocse variano tra il 40 e il 60 per cento del salario mediano. In Italia, vorrebbe dire tra i 5 e i 7 euro all’ora. Il livello sarebbe anche compatibile con i minimi tabellari fissati dalla contrattazione collettiva, che oggi partono dai 7 euro circa per i contratti principali.
Su un testo di legge condiviso, essenzialmente le obiezioni al salario minimo per legge attengono alla discussione se tale potere debba appartenere alle parti sociali, che lo esercitano liberamente tramite la contrattazione collettiva, o allo Stato, che lo esercita tramite la legge. In realtà sono due cose diverse: un conto sono i minimi tabellari fissati dalla contrattazione nazionale, che incorporano una parte di redistribuzione della ricchezza creata e premiano quindi almeno in parte i risultati generali del comparto (una distribuzione più importante e articolata deve spettare alla contrattazione aziendale, che gestisce la premialità).
Non a caso i minimi tabellari sono differenti a seconda dei comparti: non rappresentano un minimo vitale, ma la retribuzione minima per chi lavora in quel settore, relazionata alla ricchezza che il settore può redistribuire. Un salario minimo legale rappresenta invece una condizione minima garantita universalmente, con finalità di assicurare a chiunque lavori un trattamento che prescinda dalle condizioni contingenti dell’impresa e/o del comparto.
Al Cnel sono depositati oltre 870 CCNL, di cui solo 1/3 firmati da CGIL CISL e UIL; anche a voler aggiungere a questi i Contratti stipulati da Sindacati autonomi dalle tre maggiori Confederazioni ma dotati di una vera base associativa e attori di pratiche sindacali “serie”, è evidente che sono centinaia i CCNL che possiamo definire di comodo: formalmente legali, ma che fissano però condizioni salariali al ribasso.
Va tenuto conto anche di una percentuale difficile da definire con precisione, ma certamente non irrilevante, di lavoratori autonomi “economicamente dipendenti”, essenzialmente finte “partite IVA” o monocommittenze. Stiamo parlando di una platea di circa 5.300.000 lavoratori autonomi, per cui se parliamo di 3.000.000 di persone sottopagate tra autonomi e dipendenti ci avviciniamo alla realtà probabilmente per difetto.
La contrattazione sindacale non basta perché l’art. 39 della Costituzione è rimasto inattuato: esso riconosce efficacia obbligatoria universale soltanto per gli accordi siglati da Sindacati Registrati che rappresentino la maggioranza degli addetti del settore cui si riferisce il CCNL. Purtroppo nessuna Organizzazione Sindacale è, per l’appunto, registrata, e comunque rimane ancora forte l’ostilità dei sindacati ad una legge applicativa dell’art. 39. L’accordo resta pertanto vincolante solo per chi lo sottoscrive, e nulla può vietare ad un’organizzazione che si autodefinisce sindacale tramite regolare procedura notarile di firmare un contratto con retribuzioni al ribasso, che poi qualunque impresa non aderente alle Associazioni Datoriali “ufficiali” può applicare ai propri dipendenti.
È ben vero che la giurisprudenza consolidata, nel caso di contenzioso giudiziario, riconosce ai lavoratori la retribuzione fissata dai CCNL siglati dai Sindacati “maggiormente rappresentativi”, ma evidentemente non si tratta di un rimedio efficace, visto il numero dei lavoratori sottopagati!
Ancora più difficili le condizioni di quei lavoratori che per effetto di un “accordo”, ricevono sì una busta paga con le dovute retribuzioni contrattuali, ma sono costretti a restituirne una parte al datore di lavoro. Né si capirebbe perché il presidente di Legacoop invoca il salario minimo per legge per difendersi dai ribassi anomali nelle gare di appalto.
La gran parte dei sottopagati si colloca nelle aziende minori e nelle Regioni in cui il confine tra lavoro regolare e lavoro nero è poco netto, la presenza del sindacato è marginale, e quindi c’è poca propensione da parte dei lavoratori ad affrontare cause giudiziarie, dall’esito peraltro non sempre scontato, per reclamare una retribuzione equa. Ciò rende la “via giudiziaria” certamente praticabile ma insufficiente a risolvere radicalmente il problema.
Se la retribuzione minima viene fissata a ridosso dei minimi tabellari previsti dai CCNL certamente potrebbe risultare depotenziata la Contrattazione Nazionale, perché occorre ricordare che il CCNL si occupa di altre cose oltre al salario base: maggiorazioni per straordinari, turni, riposi, orari, inquadramento, formazione continua, diritti sindacali, permessi, ecc. E comunque non verrebbe minimamente limitata la contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale.
Viceversa, il rischio è che fissando un minimo significativamente inferiore ai minimi contrattuali si possa indurre parte delle imprese ad adottarlo per risparmiare rispetto al CCNL. Le aziende che potrebbero essere interessate a quest’operazione sarebbero sostanzialmente le stesse che già oggi non applicano nessun CCNL o ne applicano uno di comodo, e che determinano un ribasso retributivo mediamente del 20%: si deve ragionare attorno a questa soglia per determinare effetti concreti.
Scendere troppo significa creare le condizioni per un peggioramento. Salire senza arrivare a ridossi dei minimi contrattuali dovrebbe concretamente migliorare le condizioni di quel 10% di dipendenti che sono sottopagati, per non dire degli “autonomi” che non godono neppure di una simulazione di contratto collettivo e sono in completa balia dei rapporti di forza con il committente.
Del resto in Germania il minimo salariale di legge è attorno al 50% del salario mediano reale e ciò non ha minimamente intaccato il ruolo della contrattazione collettiva. Vero è che in Germania il tessuto di piccole imprese, che sono più propense ad eludere i CCNL, è molto inferiore all’Italia, e che la rappresentanza sindacale è più diffusa e soprattutto non frazionata. D’altra parte questo paragone deve tener conto di una condizione normativa molto differente: soltanto la piena attuazione dell’art. 39 restituirebbe al Sindacato la potestà legale per fissare minimi retributivi con valore obbligatorio.
I minimi contrattuali si applicano indifferentemente su tutto il territorio nazionale, ma dati ben noti ci danno diversi livelli di sviluppo tra le regioni, il peso relativo dei minimi tabellari è diverso sia che li si compari al potere d’acquisto regionale sia rispetto al salario mediano regionale. Un livello ragionevole in una regione al nord potrebbe essere fuori mercato in molte zone del sud, e viceversa un livello accettabile al sud potrebbe essere irrisorio al nord. La soluzione è se si vuol fare un’operazione che abbia effetti reali sulle retribuzioni, sia opportuno individuare un minimo orario medio per poi riparametrarlo per aree territoriali.
In materia retributiva sarebbe meglio affidarsi alla contrattazione tra le Parti Sociali, ma è altrettanto vero che in una cornice normativa come la nostra questa contrattazione non può avere effetti erga omnes.
Si sta cercando un accordo in Parlamento prima tra le parti sociali (la cui piena rappresentatività dovrebbe essere oggetto di una formale legittimazione) ma non si comprende per quale ragione non si dia attuazione all’art. 39 della Costituzione che sarebbe la soluzione più chiara e coerente, ma la supplenza del legislatore però non può portare a sbagli madornali come i vari testi rappresentano in discussione.
Ne segnalo due determinanti: uno è quello cigiellino di comodo per i sindacati inerti, che prevede un salario per legge non relativo al trattamento minimo lordo contrattuale ma al all’interno del trattamento economico, trattamento di fine rapporto ferie e premi di produzione, welfare compresi. Che significa segare la contrattazione privata centrale e quella aziendale, lasciando tutto alla politica. L’altro è la sanzione prevista per chi non rispetta la legge: sanzioni intorno ai 100 euro, invogliano al nero, quando invece le sanzioni sono pesanti inducono ad un ripensamento dallo scavalcare la legge.
Insomma, la discussione è molto ma molto lontana da una soluzione ragionevole.