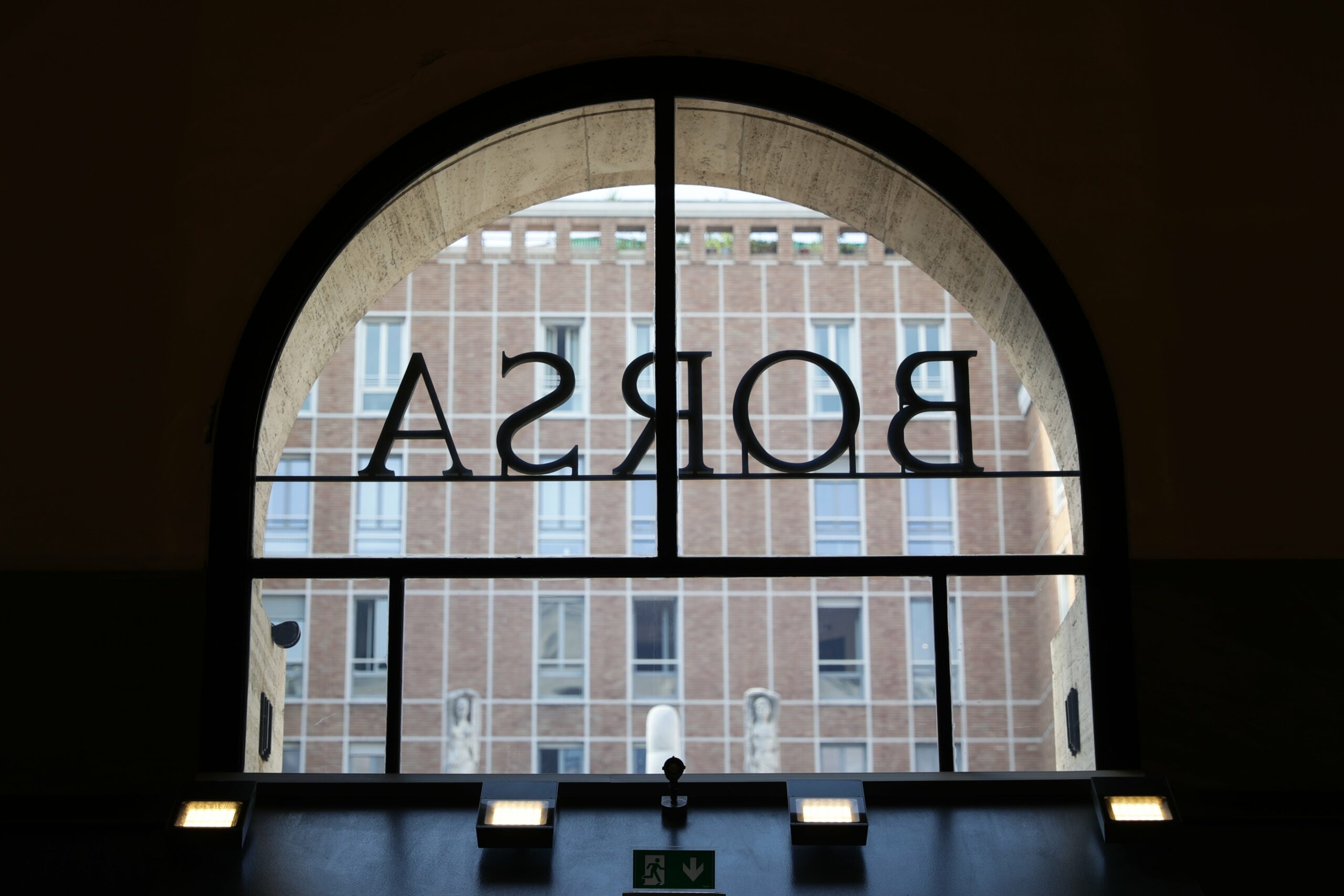Quando uno strumento come il Superbonus viene agitato come una clava a fini di lotta politica, la prima vittima sono i numeri. Presi a casaccio, distorti, male interpretati. Fino a diventare un inestricabile groviglio manipolabile a piacere.
Partiamo dal dato fornito nei giorni scorsi dall’Enea aggiornato ad agosto che, per il Superbonus, mostra un ammontare di detrazioni maturate per lavori conclusi pari a 76,1 miliardi (+1,9 miliardi rispetto a luglio) che salgono a 93,5 miliardi se si tiene conto anche delle detrazioni previste a fine lavori. Un significativo rallentamento rispetto alla media mensile di 3,5 miliardi dell’ultimo anno.
Queste cifre sono cosa ben diversa – ma ne sono ovviamente alla base – dal fabbisogno statale e saldo netto da finanziare, cioè la stima della somma che mancherà nelle casse dello Stato man mano che nel corso degli anni i contribuenti compenseranno i propri crediti, e che quindi andrà reperita emettendo titoli sul mercato e aumentando il debito pubblico. Osservando tutti i bonus edilizi, ad aprile, tale dato è stato ancora una volta rivisto al rialzo rispetto alle stime iniziali ed alla Nadef del settembre 2022. Siamo passati dagli iniziali 71 miliardi a 116 miliardi (di cui 67 per il Superbonus), ben 45 miliardi di aumento in pochi mesi, seppur distribuiti su più anni, che mettono in forte dubbio la bontà delle stime della Ragioneria Generale dello Stato (Rgs). Questo importo è una previsione di quanto i contribuenti compenseranno fino al 2035 (ma l’84% è previsto entro il 2026) e dell’effetto di mancato utilizzo di altre detrazioni, ed è già per intero nei tendenziali di finanza pubblica.
Da domenica, per completare la confusione, circolano ampi stralci di un “appunto riservato” di Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate (AdE), indirizzato a Giorgia Meloni per avvisarla che “una frana si sta abbattendo sui conti pubblici e sull’economia italiana”.
In particolare, sulle pagine del Corriere della Sera domenica si leggeva che “tra la fine di marzo e la fine di agosto, secondo l’appunto di Ernesto Maria Ruffini alla Premier, i crediti legati ai bonus edilizi che sono stati ceduti o scontati dalle imprese in fattura sono cresciuti da 110 a 147 miliardi. Di questi, solo 23 sono stati già compensati, portandoli a riduzione delle tasse dovute. Gli altri 123 miliardi, che possono essere scontati in un quadriennio, sono in gran parte alla vana ricerca di un compratore. Al conto vanno aggiunti i crediti che i titolari portano direttamente in detrazione dalle imposte, si stima un’altra ventina di miliardi”.
Sono dati che però confondono una parte delle mele di un cesto (le cessioni o sconto in fattura) con l’intero cesto (il fabbisogno finanziario per lo Stato) e sono di conseguenza contraddittori rispetto alle cifre riportate in audizione parlamentare dai dirigenti del Mef e della Rgs solo pochi mesi fa.
In quella memoria del Mef, si specifica inoltre che – a fine aprile 2023 –le cessioni comunicate all’AdE relative a tutti i bonus edilizi erano pari a 65,6 miliardi, di cui 15,2 già compensate a partire dal 2021.
Ora, se questi sono i punti fermi noti a fine aprile, poiché non è possibile che i crediti ceduti siano volati da 65,5 a 147 miliardi in pochi mesi, si deve supporre che i 147 miliardi siano una ulteriore revisione al rialzo del fabbisogno attestato ad aprile a 116 miliardi. A cui non dovrebbero affatto aggiungersi “un’altra ventina di miliardi” in quota ai contribuenti che detrarranno direttamente in dichiarazione il loro credito, come pure sostenuto sul Corriere.
Arriveremmo a circa 167 miliardi, che è un dato privo di senso. È ragionevole dedurre che – proprio in previsione della imminente Nadef – i tecnici del Mef abbiano dovuto aggiornare i tendenziali del fabbisogno e del saldo netto da finanziare portandoli dai 116 di aprile ai 147 della “nota” di Ruffini di agosto. A questi ultimi vanno sottratti 13 miliardi di crediti bloccati per frodi e 23 miliardi già pagati. E si giunge quindi ai circa 110 miliardi di fabbisogno residuo, di cui ha parlato il sottosegretario all’Economia Federico Freni. In ogni caso si tratta di circa 15 miliardi in più di debito pubblico, che mettono in discussione anche il deficit/PIL del 2023 (4,5%), per il quale l’incidenza dei bonus era stata stimata pari a 0,7 punti di PIL, e del biennio 2024-2025 (0,4 punti).
Ma questo fabbisogno si scaricherà effettivamente sul debito dello Stato nei prossimi anni, in conseguenza delle compensazioni? È tutto da dimostrare. Infatti, ad aprile a fronte di 116 miliardi di fabbisogno stimato, risultavano crediti ceduti e compensabili in F24 per 66 miliardi, oltre a circa 30 miliardi di crediti incagliati (stima Ance) e una somma imprecisata che i contribuenti detrarranno direttamente in dichiarazione. Le compensazioni sono state pari fino ad agosto a circa 23 miliardi, aumento in linea rispetto agli 8,5 miliardi compensati nel primo quadrimestre. Poiché il fabbisogno è una stima, ma cessioni e compensazioni sono un dato certo, gli inghippi sono due: non è sicuro che tutti i crediti ceduti si scaricheranno in compensazione, ed è molto probabile che, anche a causa del divieto alle cessioni per lavori avviati dopo il 16 febbraio 2023, molti committenti a fine anno si ritrovino tra le mani una quota annuale di credito originario non ceduto e non compensabile per assenza di debiti fiscali, che dal 1 gennaio varrà zero. Per la gioia di chi potrà comprare il tutto a prezzi stracciati. L’ennesimo danno collaterale di una misura in teoria valida, ma che è stata progettata male e gestita peggio con pochi precedenti nella storia della Repubblica.