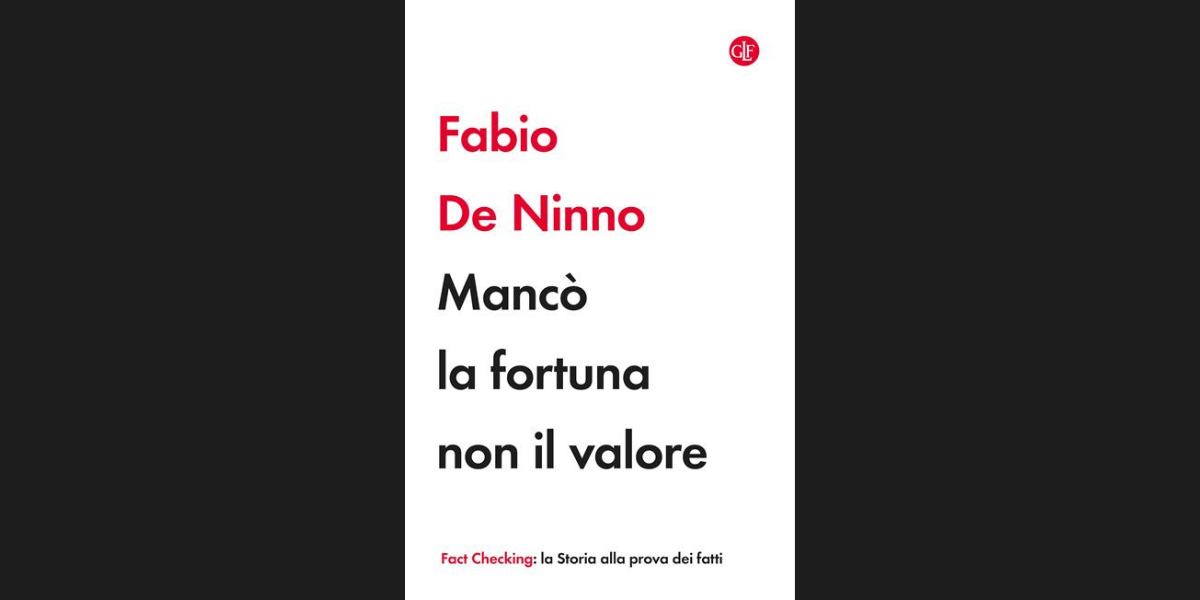Nel grande teatro della finanza europea, il tema della trasparenza a tutela degli investitori ha assunto un’importanza via via più rilevante. Regolatori e autorità di Borsa dei vari paesi europei hanno sviluppato un complesso e ponderoso sistema documentale che deve accompagnare ogni emissione di titoli con il dichiarato intento di fornire agli investitori, particolarmente quelli retail, tutti gli strumenti utili a una piena e autonoma valutazione del rischio.
Dobbiamo però ormai riconoscere che questo sistema di trasparenza e tutela, rassicurante a parole, in realtà non funziona. È una maschera opaca per milioni di risparmiatori, che in teoria tutela, ma che in pratica confonde, paralizza, espone. Ma funziona bene, invece, per altri fini.
Il prospetto informativo, simbolo della trasparenza obbligatoria, è diventato un compendio mostruoso: di norma ben oltre cento pagine di descrizioni, numeri, clausole legali, nonostante i rendiconti finanziari siano spesso incorporati solo per riferimento (cioè con un rimando e non riportati fisicamente: bisogna andarseli a cercare).
Tutto questo non aiuta affatto l’investitore retail, spesso chiamato dal gestore o consulente ad approvare una proposta di investimento in tempi brevissimi e senza avere né il tempo né le conoscenze tecniche necessarie per interpretare adeguatamente documenti così complessi.
Nella gran parte dei casi nemmeno il gestore o consulente hanno letto il prospetto, ma si fidano delle loro conoscenze o di quelle dei sales o dei broker che gli hanno proposto l’operazione (e lasciamo da parte i casi di malafede), i quali a loro volta – nella stragrande maggioranza dei casi – non lo hanno letto. Nei casi più fortunati, solo pochi di questi soggetti hanno assistito al road-show dell’emittente: una presentazione di “vendita” dell’operazione, in cui l’emittente illustra i propri piani futuri.
All’interno dei prospetti c’è una sezione chiamata “Risk Factors”, che cresce sempre di più. Nata per sintetizzare all’investitore i rischi potenziali dell’operazione, è diventata un’ottima esimente per gli emittenti: se ti ho citato l’esistenza di un rischio, non ho responsabilità, se dovesse verificarsi.
Per sfruttare al meglio la situazione, è bene quindi che la sezione Risk Factors sia la più ampia possibile: dai terremoti alle pandemie, dagli scioperi alle guerre, dalle nazionalizzazioni a crisi di settore, a eventi molto più specifici, ma ben commisti al mare magnum citato. Insomma, un enorme raccoglitore dove tutto si perde e il peso di ciascun fattore finisce per essere non valutato e non valutabile.
Un “fortino informativo” invalicabile. Tanti dati, tante informazioni, nessuna sintesi, nessuna guida alla lettura in chiave di rischi effettivi e comparativi. L’esondazione informativa non tutela: nasconde. Un rischio serio indicato a pagina 174 finisce sepolto sotto centinaia di pagine: l’unico a leggerlo sarà l’ufficio legale dell’emittente. Il piccolo investitore? Mai.
Un ulteriore elemento, qualora aveste ancora qualche dubbio: il prospetto viene prodotto al momento dell’emissione. Se un investitore compra un bond a dieci anni, riceve il prospetto al giorno zero e poi più nulla. L’informazione sull’evoluzione dei rischi è totalmente a suo carico. Ma quanti investitori, particolarmente quelli retail, lo fanno e quanti sarebbero in grado di farlo?
In sostanza: tanto lavoro per redigere e far approvare dalle autorità di Borsa un documento che nella realtà serve poco o nulla a tutti gli operatori. In compenso però, le autorità hanno la coscienza a posto: caro risparmiatore investitore, ti ho fatto avere tutte le informazioni disponibili.
Oltre al Prospetto ci sono i KIID (Key Investor Information Document) e i KID (Key Information Document). Il KIID, nato con la direttiva UCITS IV (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, ovvero Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari), era un documento relativamente chiaro, ridotto a due pagine, riservato ai fondi armonizzati, con una analisi della performance passata dell’emittente e una valutazione sintetica di rischio. Guarda caso è stato archiviato, nel 2023.
Il KID, invece, frutto del regolamento PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Investment Products), è oggi obbligatorio per una vasta gamma di prodotti complessi: fondi non armonizzati, polizze assicurative, strumenti derivati, obbligazioni strutturate. Non si occupa della storia e la sostituisce con scenari simulati: ottimistico, moderato, pessimo e catastrofico. Una visione di scenari futuri generati da modelli opachi, che non danno indicazioni di probabilità e rischio effettivo e tralasciano i dati storici. Un errore logico e metodologico, non accettabile in una analisi seria.
Peraltro, anche i KID vengono prodotti solo al momento dell’emissione: nessun update, nessun follow-up. E il linguaggio non è sempre di facile interpretazione per i non addetti ai lavori. A questo punto è bene precisare che le cose non stanno così solo in Italia, ma praticamente in tutti i paesi dell’Ue con mercati finanziari avanzati e le differenze si vanno riducendo.
Cambiano però alcuni requisiti, il livello di scrutinio preventivo delle autorità preposte, i tempi di esame e approvazione, nemmeno i KID presentati sono omogenei. Inevitabilmente ci sono emittenti che ne approfittano, scegliendo la Borsa più “conveniente”: naturalmente quella con prassi più permissive e tempi più rapidi per la quotazione. Poi, volendo, possono ottenere con il Passporting l’estensione ad altre Borse, negli altri paesi.
La confusione per i risparmiatori investitori ovviamente aumenta. Risparmiatori tedeschi, italiani, olandesi, ricevono lo stesso documento ma con standard, supervisione e tutela diversa a seconda del paese scelto dall’emittente. È l’arbitraggio regolamentare fatto sistema in nome del mercato unico. Tralasciamo qui gli aspetti fiscali, altro caso di frammentazione e labirinto normativo che mina una vera unione europea, perché richiederebbero una lunga trattazione.
In un contesto così, i prospetti e i KID diventano un labirinto utile a chi emette, ma inutile a chi investe. I risk factors sono estesi fino al ridicolo per immunizzare gli emittenti. I rating, utili a comprendere la qualità del credito, restano spesso facoltativi: chi vuole risparmia l’onere. I KID appaiono come infografiche rassicuranti, ma nascondono scelte discutibili: nessuna informazione realmente decisionale, nessuna protezione reale.
Tirando le somme, abbiamo un sistema di trasparenza apparente, dove più si scrive, meno si dice. Dove più si regola, più si nasconde. Dove il risparmiatore, che dovrebbe essere protetto, finisce invischiato in una palude linguistica in cui anche le autorità vigilanti si perdono.
Viene da chiedersi perché il sistema sia stato così costruito. La risposta probabilmente più semplice è anche la più probabile: con questo sistema gli emittenti hanno poche responsabilità e le autorità praticamente nessuna.Si realizza un implicito – e improvvido – scarico di responsabilità da parte di chi ha il potere di dettare le norme e dovrebbe tutelare gli investitori.
Ciascuno passa la “scimmia” sulla spalla di un altro, come direbbero gli americani, fino a che questa si poggia sulla spalla degli stessi inconsapevoli investitori, ovvero del presunto tutelato (che non protesta, perché non ha competenze adeguate ed è invischiato dal sistema). Il rating obbligatorio potrebbe essere uno strumento di presidio adeguato, almeno per le società quotate e per le emissioni destinate al retail.
Probabilmente sarebbe invece meno adatto ai fondi, agli emittenti nuovi, medi e medio-piccoli, alle emissioni strutturate. In questi casi si dovrebbe predisporre un documento unico e coerente, predisposto e/o controllato da operatori specializzati: integrare KID e prospetto (in una versione sintetica e adatta allo scopo) in un formato modulare condiviso, con sezioni comuni, chiarezza visiva, aggiornamenti periodici certi, performance storiche e simulate fianco a fianco, indicazioni chiare di rischio/rendimento.
Il tutto andrebbe ovviamente realizzato in maniera uniforme in tutti i paesi UE: un vero “esame minimo europeo” per trasparenza, approvazione e tempi, superando il pasticcio di regole locali divergenti. Servirebbe infine, ma è un obiettivo di lungo periodo, anche una educazione finanziaria diffusa: corsi, campagne, piattaforme interattive per portare la competenza al cittadino, non solo ai professionisti. Occorre finalmente riconoscere che la tutela del risparmiatore retail non si costruisce con il peso delle carte o la quantità di megabyte dei PDF, ma con la chiarezza del contenuto.
La vera trasparenza è quella che si capisce, non quella che copre. È tempo di sollecitare un cambio di paradigma: dal brontosauro burocratico all’ecosistema informativo intelligente, che renda il risparmiatore consapevole, non confuso. Solo con questo cambio, il patto fiduciario tra emittente e cittadino potrà essere rispettato. Solo così la finanza tornerà ad essere un vero servizio al risparmio e all’economia, e non un sistema di semplice trasferimento di rischi e di ricchezza.