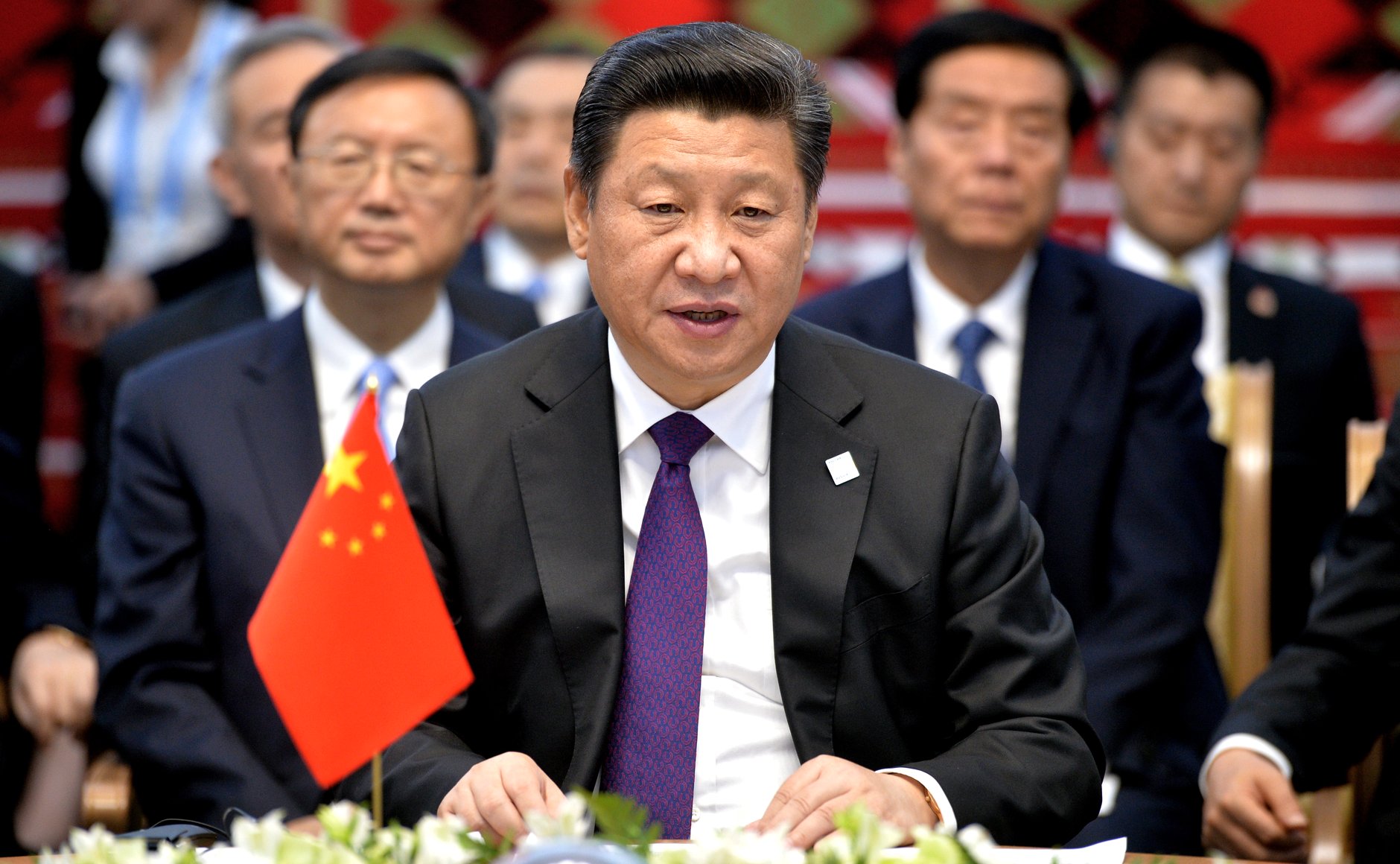L’allarme sulle condizioni dell’economia europea – in particolare lo storico nucleo franco-tedesco – è ormai oltre il livello di guardia.
Proprio in settimana è arrivato il rapporto sulla stabilità finanziaria della Bce e, venerdì, gli indici anticipatori PMI pubblicati da S&P, hanno contribuito alla definizione di un quadro che chiamarepreoccupante è già una professione di ottimismo.
La Bce ha puntato l’attenzione sulla micidiale combinazione di bassa crescita, alti deficit pubblici e elevati stock di debito pubblico che potrebbero creare una crisi di fiducia negli investitori, a proposito della sostenibilità di quegli elevati stock di debito. Da lì potrebbe partire una nuova crisi degli spread dei titoli sovrani. Ma questa volta, l’attenzione del vice presidente della Bce, Luis De Guindos si è concentrata sulla Francia, il cui deficit 2024 appare fuori controllo (verso il 6% del PIL) e quello del 2025 è tuttora oggetto di una durissima contesa parlamentare. Al punto che lo spread sul titolo decennale con la Germania è salito intorno a 80 punti, contro i 125 dell’Italia che però è in discesa. In Bce evidenziano che basterebbe un qualsiasi shock esogeno macroeconomico e gli interessi sul debito supererebbero il 4% del PIL in Francia e salirebbero a poco meno del 6% in Italia. Tra minacce esogene all’orizzonte, la Bce vede la sopravvalutazione del mercato azionario e la bolla dei prezzi che si è creata intorno a tutti gli asset legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Su un terreno già così ben arato, venerdì hanno facilmente attecchito gli indici anticipatori PMI di Francia, Germania e Eurozona che si sono situati sui livelli minimi degli ultimi 10-12 mesi.
In Eurozona, l’indice composito è passato sotto 50, limite che separa la contrazione dall’espansione dell’economia. Questa volta alla cronica contrazione in atto da tempo nel manifatturiero, si è aggiunta anche la contrazione del settore dei servizi. Come prevedibile, è la Germania a trascinare verso il basso l’intera area. Al “rosso fisso” del settore manifatturiero che ha manifestato solo un lieve sussulto, si è stavolta aggiunto il passaggio in contrazione del settore dei servizi (al minimo da 9 mesi). Da Parigi, passato il fuoco di paglia delle Olimpiadi, il segnale di debolezza è ancora più evidente. Infatti l’indice composito è ancora peggiorato da 48,4 a 44,8, e la sua scomposizione tra manifattura (da 44,5 a 43,2) e servizi (da 49,2 a 45,7) offre un quadro ancora più preoccupante rispetto a quello tedesco, anche alla luce delle considerazioni della Bce.
Se questa è la (disastrosa) diagnosi, è sul piano della terapia che le cose vanno, se possibile, ancora peggio.
Infatti solo pensare che in un’Europa che continua ad inanellare massicci avanzi della bilancia commerciale (Germania e Italia in testa) il problema sia quello della perdita di competitività, al punto di affidare a Mario Draghi la redazione di uno specifico rapporto, è indice rivelatore della qualità ed efficacia della terapia. Perché, puramente e semplicemente, se ci fosse un problema di competitività non riusciremmo a vendere nemmeno mezzo container delle nostre merci in giro per il mondo e dovremmo essere invasi da prodotti stranieri.
Una conferma arriva dalla «dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea», uscita pomposamente dal Consiglio Europeo informale dello scorso 8 novembre.
In materia di competitività sui mercati esteri, la realtà ci restituisce numeri che descrivono ben altro. L’Eurozona, dopo la flessione causata dalla crisi dei prezzi dei prodotti energetici del 2021 e 2022, continua a conseguire ogni mese avanzi commerciali nell’ordine di 20 miliardi, come detto con Berlino in testa. Ma nei 12 mesi terminati ad agosto 2024, l’Italia può vantare un avanzo della bilancia commerciale di 59 miliardi, tra i più alti degli ultimi anni, quasi il 3% del
Pil. Allora qual è il problema? Banalmente, la crescita di un Paese non può continuare ad avvenire inondando di merci e servizi il resto del mondo e sperando che questi ultimi continuino a comprarle. La crescita è il risultato, anche e soprattutto, di consumi e investimenti (privati e pubblici) relativi al mercato interno. Consumi e investimenti che purtroppo sono il vero buco nero dell’Eurozona. È il mercato interno che è asfittico, non la nostra capacità di competere sui mercati esteri e quindi il rapporto Draghi è, come minimo, titolato male.
Ad offrirci uno spaccato di questa drammatica realtà, di cui la Germania è stata la maggiore protagonista e quindi responsabile, è un recente e accurato articolo apparso sul sito Bloomberg in cui si evidenzia il fenomeno della fuga di capitali destinati a investimenti all’estero. L’altra faccia della medaglia dell’ingente saldo commerciale è proprio il deflusso di capitali all’estero: l’uno è lo specchio dell’altro, come insegnano i saldi settoriali. Sono numeri impressionanti: dal 2010 è stato di ben 650 miliardi il deflusso netto di capitali da Berlino, di cui il 40% concentrati negli anni del governo Scholz. Dal 2010, secondo la Bundesbank, le imprese tedesche hanno investito all’estero circa 1.700 miliardi di euro. Disincentivati dal proibitivo costo dell’energia e dalla invadente burocrazia, i tedeschi hanno aperto fabbriche ovunque, soprattutto Cina e Usa, tranne che in Europa.
Nessuno si è tirato indietro. Il gigante della chimica Basf, il costruttore di componenti per automobili ZF, la Miele con i suoi elettrodomestici, Volkswagen (che ha più fabbriche in Cina che in patria), Mercedes, fino ad arrivare al caso della Siemens che ha investito all’estero in acquisizioni e espansioni 30 miliardi dal 2020. Si segnalano difficoltà anche per quanto riguarda la capacità di attrarre investitori esteri. Intel ha annunciato a settembre il rinvio di un investimento di 10 miliardi in un impianto in Sassonia. Il produttore Usa di semiconduttori Wolfspeed ne ha bloccato uno da 3 miliardi nella Saarland. A dispetto della mitologica efficienza tedesca, sembra che tra i fattori disincentivanti ci sia la burocrazia, intesa come eccesso di regolazione.
Tuttavia non è nemmeno corretto sostenere che «il modello di business tedesco si è rotto». Perché ciò che sta accadendo è esattamente ciò che è prevedibile che accada quando si adotta quel modello trainato dall’export (la domanda degli altri) e dalla compressione della domanda interna. Eccellenti risultati nel breve termine – sfruttando anche il dumping valutario, come ha fatto la Germania – e poi basta un qualsiasi accidente di natura più o meno esogena (lockdown, guerra in Ucraina, un gasdotto che «esplode»nel Baltico…) e tutto finisce. Ma è solo il prevedibile esito prodotto da un modello di sviluppo che volutamente ignora le conseguenze di lungo termine e crede che la corda della domanda estera non si possa mai spezzare.
Paradossalmente, sono proprio i propositi manifestati da Donald Trump per il prossimo quadriennio a fornire la speranza che tale modello squilibrato sia abbandonato. Infatti, una domanda estera frenata dai dazi potrebbe condurre a un ribilanciamento a favore della domanda interna come vettore di crescita. Insomma i dazipotrebbero costituire un’opportunità anziché una minaccia. Una tempestiva sveglia per capire che il mercato migliore è quello interno, che peraltro è uno dei pilastri della Ue, almeno sulla carta.
Ad oggi, purtroppo, la risposta che è arrivata dal vertice dei capi di governo europeo somiglia alla suicida scelta di accelerare in prossimità di un ostacolo. Sono tornati alla memoria i comunicati di Breznev negli anni del crepuscolo dell’Urss.
In premessa, l’obiettivo di «assicurare la prosperità economica» e «rafforzare la nostra competitività» e contemporaneamente «fare dell’
Il successivo elenco dei presunti «fattori di competitività» offre dettagli ancora più sconfortanti ed è una sequenza di propositi contraddittori. Si vorrebbe potenziare il mercato unico, che invece è stato danneggiato da aiuti di Stato autorizzati per sussidiare investimenti nella transizione energetica. Si insiste sull’unione del mercato dei capitali come panacea per finanziare Pmi e start-up, nella errata convinzione che basterebbe uniformare il diritto societario e fallimentare per conseguire quell’obiettivo.
La «rivoluzione di semplificazione che consente alle imprese di prosperare senza un’eccessiva regolamentazione» significa negare la ragion d’essere della UE, fondata sulla regolazione ossessiva di tutto il regolabile. «L’obiettivo di spesa pari al 3% del Pil in ricerca e sviluppo entro il 2030» si scontra con la traiettoria di riduzione dei bilanci pubblici prevista dal riformato Patto di Stabilità, così come paiono incompatibili gli obiettivi della «sovranità energetica strategica» e della «neutralità climatica entro il 2050». L’altisonante volontà di «p
Da ultimo, le idee su come finanziare tutti questi «buoni» propositi sono sempre poche e pure confuse. C’è di tutto (capitali pubblici, privati, Bei, il modesto bilancio pluriennale Ue, nuove risorse proprie…) tranne le parole «debito comune». E questo la dice lunga su quanto sia irrealizzabile tutta la sequenza di sogni fin qui elencata. Anche il sogno del debito comune resterà tale.