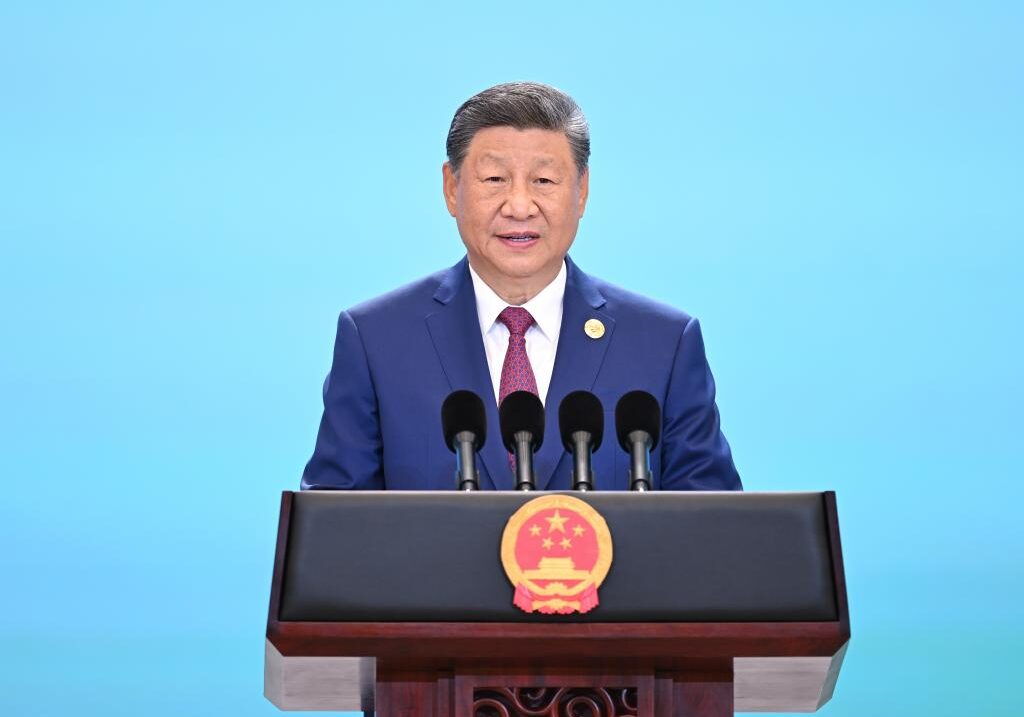La gran parte dei prodotti informativi—trasmissioni, giornali, podcast—è strutturata intorno a un nucleo di persone stabili. Questo di per sé non è un problema. Avere una linea editoriale chiara se supportata da un lavoro ben fatto è una cosa positiva.
Inoltre, bisogna distinguere tra prodotti che danno spazio a interventi ben strutturati—giornali, riviste, siti web ben curati—e quelli basati su conversazioni spontanee. Queste ultime sono più esposte a errori perché un testo scritto prevede un minimo di pianificazione e di revisioni, mentre una conversazione spontanea implica margini di errore più ampi.
Il problema di cui parlavo all’inizio nasce dal fatto che un numero ristretto di opinionisti influenti è chiamato a dare la propria opinione, spesso in tempo reale, su qualsiasi tema saliente.
Ora, non dico che i giornalisti o gli opinionisti non possano dare spiegazioni o fornire opinioni. Tutt’altro. Quando ci informiamo sugli ultimi fatti del giorno, investiamo una dose considerevole di attenzione.
Relegare tutto agli specialisti rischia di farci perdere la visione d’insieme, perché per farlo dovremmo offrire una panoramica completa delle opinioni sostenute dagli esperti.
Dato il tempo ridotto per commentare le notizie, non è realistico pensare di poter fare a meno di figure intermedie tra gli esperti e il pubblico. E neanche si può pensare che queste figure intermedie siano prive di autonomia intellettuale e debbano essere semplicemente divulgatori della ricerca fatta dagli esperti.
Il problema è un altro: non è ragionevole pensare che gli opinionisti siano una categoria che ha le competenze per dire cose significative su tutto in tempo reale.
Questo problema mi sembra essere esacerbato dal fatto che, in televisione e sui giornali, sono sempre le stesse persone a esprimersi negli anni su tutto.
Lo stesso fenomeno sembra che si stia replicando nei podcast, nei canali YouTube e nelle pagine social, in cui pochissimi vincono la competizione e diventano super influenti e, grazie a questa posizione dominante, iniziano a colmare ogni spazio.
Partiamo, quindi, dal problema generale. Quando un piccolo gruppo prende la maggior parte dello spazio dedicato al commento dell’attualità, vuol dire che pochissime persone daranno la loro opinione su una grandissima varietà di temi.
Per rimanere nell’ambito della televisione e dei giornali, persone come Scanzi o Travaglio sono intervenute sulla gestione del Covid e sulla guerra in Ucraina, sulla Palestina e sull’ultimo scandalo politico. Ognuno di questi temi richiede competenze specifiche.
Sicuramente, concedo che sia Scanzi sia Travaglio abbiano le competenze per affrontare temi riguardanti la politica interna. Però, dove trovano il tempo per sviluppare competenze così trasversali?
Per inquadrare il problema, è utilissimo usare un concetto approfondito nella ricerca filosofica contemporanea: lo sconfinamento epistemico.
Qualche anno fa, il filosofo Nathan Ballantyne ha pubblicato un articolo sulla rivista accademica Mind (la rivista, per intenderci, in cui Alan Turing pubblicò l’articolo sul test di Turing) in cui sosteneva che lo sconfinamento epistemico fosse un problema. Il problema è il seguente. L’autorità che deriva dall’essere un esperto è confinata all’ambito in cui si è maturata l’esperienza.
Per esempio, essere un premio Nobel per la fisica non garantisce che tu sia in grado di capire molto di politica. Nel momento in cui si sconfina in un ambito in cui non si è esperti, si perde di affidabilità.
Ecco, quindi, da dove nasce il problema. Affidandosi sempre alle stesse persone per affrontare qualsiasi tema, il rischio dello sconfinamento epistemico è altissimo.
Il problema è poi ingigantito da un ulteriore fattore.
Nel suo articolo, Ballantyne usava come esempi di sconfinamento epistemico il premio Nobel per la chimica Linus Pauling e Richard Dawkins. Dunque, persone che sono considerate ai vertici della ricerca nei loro campi e che hanno accesso a una fitta rete di relazioni accademiche che permette loro di avere una presa almeno di base anche su ambiti che non sono i propri.
Nonostante ciò, commettono sconfinamenti e, occupandosi di cose di cui non sono esperti, commettono errori grossolani.
Spero che si sia tutti d’accordo nel dire che nessuno tra gli opinionisti sia un esperto del livello di un premio Nobel o di un professore di Oxford. Questo, sia chiaro, senza nulla togliere al loro lavoro: sono giornalisti e il loro compito non è essere esperti in un ambito di ricerca.
Il problema, però, è che agli opinionisti vengono chieste analisi e spiegazioni. Quindi, vengono trattati come persone in grado di identificare i fattori rilevanti, avanzare ipotesi e spiegazioni su eventi anche molto complessi come una pandemia o una guerra.
In breve, vengono trattati come esperti che però non sono.
Quello che succede, dunque, è che delegando agli opinionisti il ruolo degli analisti, li si induce a diventare degli sconfinatori epistemici seriali.
Uniamo quindi i due punti: l’informazione come riduzione dell’incertezza e lo sconfinamento epistemico.
Prendiamo un esempio da una puntata recente di Otto e mezzo. Lilli Gruber chiede a Scanzi (a partire dal minuto 08:35) se crede che la questione palestinese possa nuocere a Giorgia Meloni. La risposta di Scanzi è in molti modi un ottimo esempio di risposta che non fornisce un’analisi informativa.
In primo luogo, dice che sa che le manifestazioni in supporto a Gaza non sposteranno di una virgola il comportamento del governo. Dire di sapere qualcosa è un’affermazione molto forte. Vuol dire escludere qualsiasi possibilità che le cose vadano altrimenti. Quali basi ha Scanzi per dire che sa che questo avverrà?
Poi, Scanzi prosegue esprimendo il suo sconcerto per la reazione molto tarda del governo. Questo è un punto su cui siamo tutti d’accordo. Ma quale informazione acquisiamo? Solamente che Scanzi è, come tutti, allarmato. Non c’è nella sua risposta neppure un tentativo di accennare a un’analisi.
L’unica cosa che viene trasmessa è l’espressione del disappunto.
Sia chiaro, io condivido appieno questo disappunto: è l’aspetto dialettico che non mi convince. Impiegare il proprio tempo televisivo solamente per esprimere disappunto senza fornire un’analisi o un approfondimento anche minimo è una mossa retorica che funziona per catturare il proprio pubblico, ma che non fornisce nessun tipo di informazione.
Il problema non riguarda solamente una mossa come quella di Scanzi, che sostituisce un’analisi che non può fare, con una semplice espressione di posizionamento.
Un altro caso in cui, nonostante non si faccia palese disinformazione ma neppure chiaramente informazione, è lo spazio dedicato al monologo di Travaglio in Accordi & Disaccordi. Travaglio ha a disposizione anche venti minuti, in cui può articolare un monologo sugli eventi rilevanti.
Anche tralasciando il fatto che Travaglio non è un esperto di geopolitica e relazioni internazionali, tema che al momento affronta spesso, in questi monologhi, Travaglio segue il suo stile, che è fatto di battute taglienti e sarcasmo.
Questo stile aveva probabilmente una funzione positiva nel momento in cui è esploso Travaglio––negli anni ruggenti del berlusconismo, quando Berlusconi controllava direttamente o indirettamente quasi tutti i canali televisivi, non c’erano i social, e usare il sarcasmo poteva servire per ridimensionare Berlusconi sul piano dell’immagine e mostrarne l’inadeguatezza in un caso in cui i fatti erano chiari.
Però, il sarcasmo non è una forma argomentativa valida, è una mossa retorica che toglie l’opinione oggetto di battuta dallo spazio argomentativo. Spazio argomentativo importantissimo quando i fattori da considerare sono molti e si mischiano con considerazioni di valore.
Quindi, fare un uso sistematico del sarcasmo avrà certamente una funzione mediatica––cattura l’attenzione––ma non necessariamente una funzione epistemica perché non migliora la qualità di quello che sappiamo/crediamo.
Questi sono chiaramente esempi ma sono esemplificativi di una tendenza generale, che coinvolge televisioni, quotidiani, e novità editoriali, in cui alle vere analisi e agli approfondimenti, sono sostituite le opinioni. E queste opinioni, a loro volta, sono selezionate guardando principalmente a fattori non epistemici: la riconoscibilità del personaggio, la sua adattabilità al format, il seguito che già possiede e che può contribuire a lanciare il contenuto.
Ora, sarebbe certamente ingenuo chiedere che tutti i mezzi di informazione smettano di valutare chi invitare sulla base di considerazioni commerciali.
È altrettanto ingenuo chiedere che siano invitati solamente esperti perché è molto difficile, e non sempre possibile, identificare l’ambito di esperienza rilevante. Inoltre, non è neanche detto che ce ne sia uno solo o che, in questo ambito ci sia un largo consenso sul problema. È poi rischioso perché, una parte del dibattito pubblico democratico è volta ad articolare posizioni comprensibili da tutti.
Non si può, in breve, sperare di trasformare lo spazio pubblico in un seminario scientifico.
Il punto è un altro. Da circa dieci anni, parliamo tutti di disinformazione, fake news ed echo chambers. Guardiamo agli aspetti chiaramente negativi del discorso pubblico, senza però valutare le molte zone d’ombra. Non dare spazio alle fake news e alle altre forme di disinformazione è certamente necessario. Questo, però, non basta.
Questo è il punto cruciale che voglio sollevare: anche quando si crede di fare buona informazione perché le notizie sono vagliate e non si dà spazio a fake news, ci sono altri rischi non meno dannosi per la qualità dell’informazione.
Uno di questi è lo sconfinamento epistemico legato al fatto che i maggiori mezzi di informazione cercano opinionisti prima che persone capaci di fare analisi e approfondimenti.