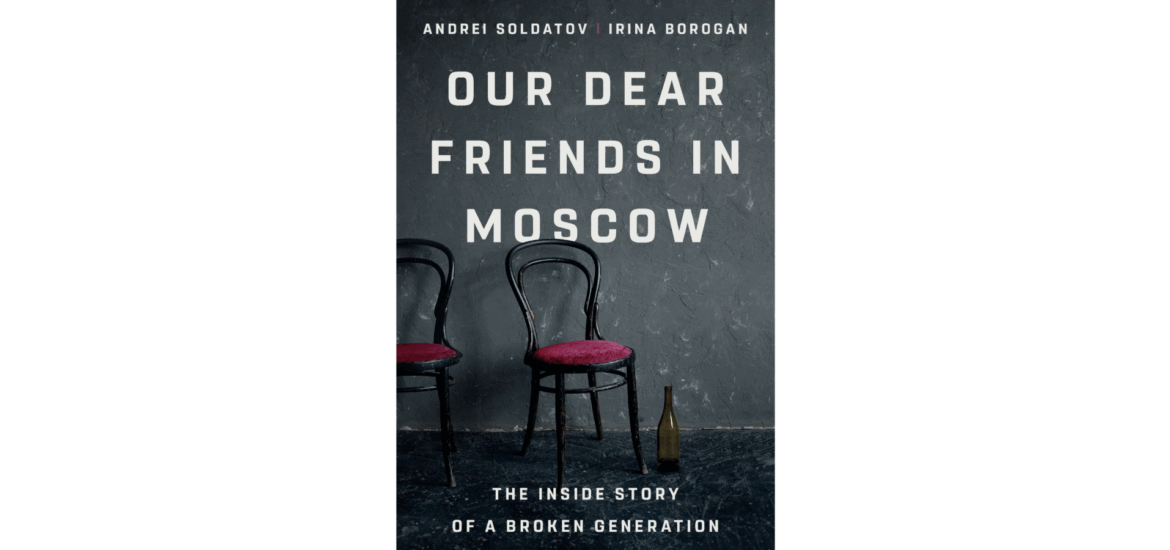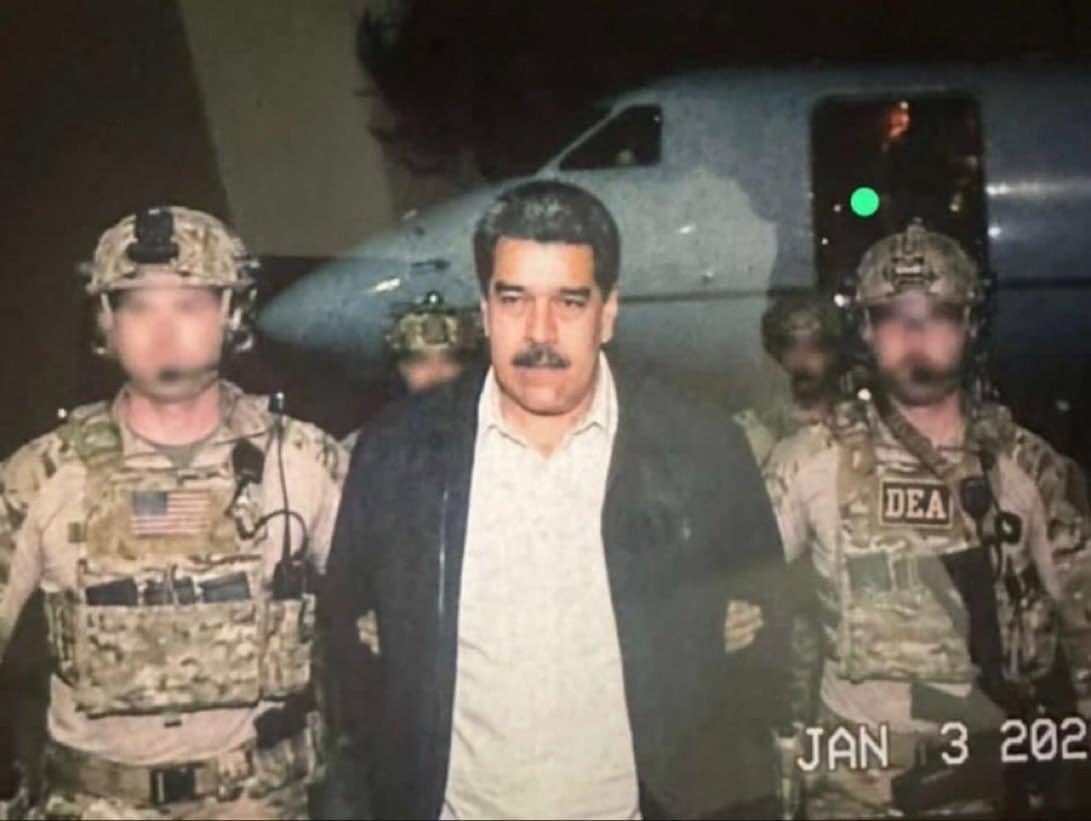È una sorta di grande freddo in salsa moscovita. È il falò delle illusioni di quella generazione di giovani russi, cresciuti all’indomani della caduta dello Stato dei soviet, che ha visto il dissolvimento dei propri ideali di libertà e il lento scivolamento di una parte di essa verso la compromissione con le atmosfere e le regole del regime di Vladimir Putin.
“Our Dear Friends in Moscow: The Inside Story of a Broken Generation” è un nuovo libro scritto dai giornalisti investigativi Irina Borogan e Andrei Soldatov, edito da PublicAffairs (parte di Hachette Book Group). L’opera ricostruisce, con uno sguardo intimo e al tempo stesso storico, la traiettoria di una generazione di giovani russi cresciuti a Mosca negli anni della caduta del comunismo. È il racconto di un’illusione collettiva, di un’apertura al mondo che sembrava destinata a cambiare il destino del paese e che, invece, si è infranta con la progressiva chiusura politica, l’ascesa del nazionalismo e la riconfigurazione autoritaria dello Stato russo. Attraverso vite intrecciate, amicizie spezzate e percorsi individuali segnati da scelte inesorabili – dall’esilio alla collaborazione col potere – il libro offre una testimonianza vivida di come la storia, che qualcuno scrive con la maiuscola, con le sue svolte drammatiche, possa travolgere generazioni intere.
Il libro è stato pubblicato negli Stati Uniti e finora non ha conosciuto edizioni in altri paesi (anche se in Francia sono stati tradotti due loro precedenti lavori sulla Russia di oggi). In Germania ne ha parlato di recente il quotidiano berlinese Tagesspiegel che ha pubblicato una lunga intervista con i due giornalisti. Il libro è disponibile per i lettori che masticano l’inglese sulle principali piattaforme online, anche nella più economica edizione digitale.
UN’EPICA DI FINE SECOLO
Il volume si apre con gli anni Novanta, quando Mosca era attraversata da un’energia caotica e speranzosa. Per la generazione che aveva conosciuto solo l’Unione Sovietica, la dissoluzione del vecchio regime appariva come l’inizio di un’era luminosa. L’Occidente sembrava vicino, quasi a portata di mano: la possibilità di dialogo con l’Europa, le nuove libertà, il risveglio culturale e sociale. Soldatov e Borogan raccontano come quel gruppo di giovani amici colse avidamente quelle chance – viaggi, studi, iniziative imprenditoriali, forme di espressione creativa – e credette in un futuro finalmente aperto e globale.
Ma dietro l’euforia persisteva un paese fragile. Il tessuto sociale si lacerava sotto i colpi di un’economia al collasso, con crisi devastanti che impoverivano famiglie intere. Le radicali riforme economiche non trovarono contesti di legge e di capitale umano pronti a sfruttarle. Al contrario il loro effetto fu di polverizzare anche quelle piccole reti sociali sopravvissute alla fine del comunismo. Allo stesso tempo, la guerra in Cecenia irrompeva come una ferita interna, segnando una generazione che iniziava a scoprire l’altro volto dell’assenza di autorità: quello della violenza e dell’instabilità.
LA LENTA CHIUSURA
Ben presto l’illusione di un’integrazione con l’Occidente cominciò a dissolversi. Gli autori mostrano il progressivo accumulo di risentimenti da parte delle élite governative, insofferenti verso le ingerenze straniere e decise a ricostruire una narrazione autonoma. L’ombra del terrorismo, con gli attacchi che colpirono Mosca, rafforzò l’idea di una fortezza da difendere.
Il gruppo di amici raccontato in “Our Dear Friends in Moscow”, inizialmente unito dall’ottimismo, iniziò a incrinarsi sotto il peso di queste trasformazioni. Alcuni scelsero la via della fuga, rifugiandosi all’estero pur di mantenere le proprie convinzioni. Altri, invece, rimasero e finirono per adattarsi, diventando parte di quel sistema sempre più autoritario che andava prendendo forma. La divisione tra chi aspirava a un futuro diverso e chi si piegava al nuovo corso scandisce la parabola di questa generazione, proprio mentre il Paese stesso imboccava una strada di isolamento.
L’ERA PUTINIANA
Con l’avvento e il consolidarsi della leadership di Vladimir Putin, il quadro muta radicalmente. La Russia non appare più un partner in cerca di integrazione, ma uno Stato che rafforza un’identità fondata sull’etnonazionalismo e sulla centralità del potere. Soldatov e Borogan delineano con precisione come, nel corso dei mandati presidenziali apparentemente infiniti, il Cremlino abbia costruito un sistema impermeabile, in cui la dissidenza viene repressa e la lealtà allo Stato è premiata.
All’interno di questo scenario, le storie personali dei protagonisti si fanno emblemi delle scelte obbligate: dall’adeguamento al regime all’opposizione solitaria, dal conseguente esilio forzato all’abisso di chi diventa ingranaggio della macchina repressiva. È in questa frattura che si consuma la “rottura di una generazione”: amici inseparabili che finiscono su fronti opposti, incomprensioni, rotture, legami spezzati da decisioni che sembrano non lasciare alcuna via di mezzo.
IL GRANDE FREDDO DI UNA GENERAZIONE
“Our Dear Friends in Moscow” non è soltanto una cronaca storica, ma anche un ritratto umano, costruito attraverso figure reali e vicende che incarnano un’intera epoca. Quella che Soldatov e Borogan presentano è una generazione consegnata alle contraddizioni più dure: dall’ebbrezza della libertà al peso della repressione, dalla fiducia nella modernità al ritorno dei fantasmi imperiali. Non è però la storia di chi questa delusione l’ha vissuta dalla sponda occidentale: la prospettiva è interna, di chi queste lacerazioni, con il mondo esterno e con la propria coscienza, le ha vissute sulla propria pelle.
L’opera mostra come il sogno europeo e occidentale della Russia degli anni Novanta sia stato gradualmente abbandonato a favore di una narrazione interna che privilegia la forza, l’orgoglio nazionale e un’identità chiusa, spesso contrapposta all’esterno. La guerra “a casa e all’estero”, come scrivono gli autori, è il punto d’arrivo di un percorso segnato da delusioni e fratture, che si riflette inesorabilmente sul destino individuale di chi aveva creduto in un futuro diverso.
Con una prosa documentata e al tempo stesso ricca di pathos, il libro diventa una lente privilegiata per comprendere la recente storia politica della Russia attraverso la disillusione di una generazione che aveva osato immaginare la libertà come possibilità concreta. La forza dell’opera di Soldatov e Borogan risiede nella capacità di intrecciare la grande storia con i drammi personali, dando voce a un’esperienza generazionale che, dal cuore di Mosca, parla a chiunque abbia vissuto la tensione tra la promessa e la perdita, tra il sogno di un’apertura e la realtà finale di una chiusura. Tra la Russia che poteva essere e quella con cui ci dobbiamo confrontare oggi.