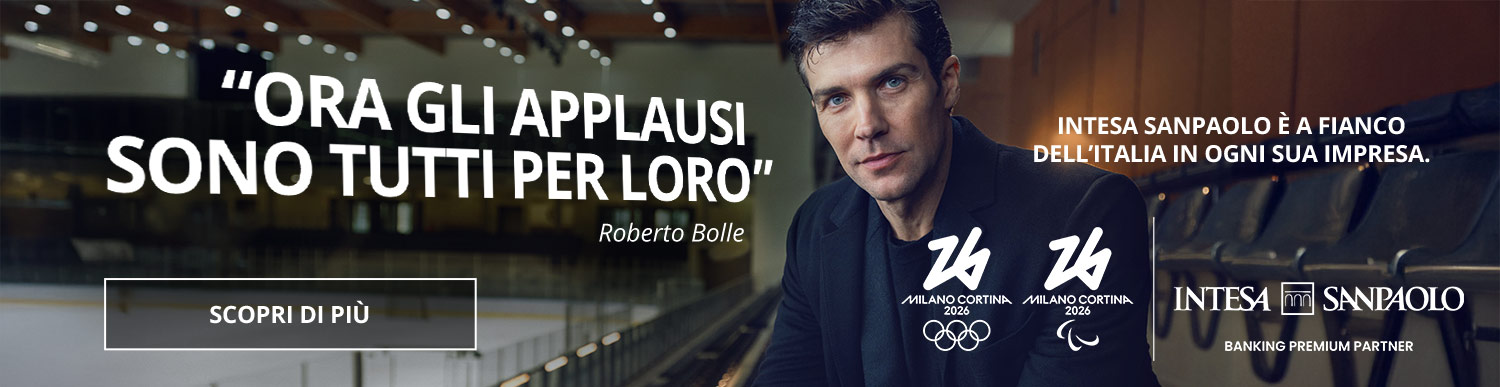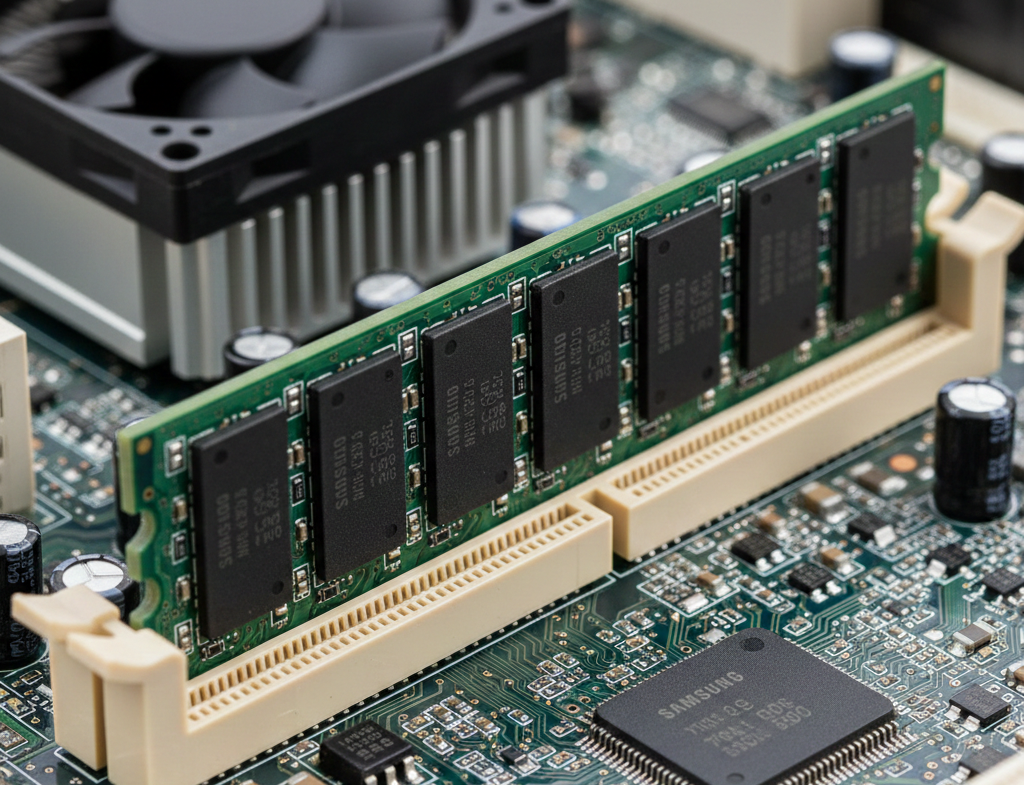A causa delle pressioni politiche dell’amministrazione Trump e dell’imminente nomina del prossimo Presidente – il mandato di Powell scade a maggio 2026 – l’indipendenza della Fed è stato uno dei principali temi di discussione in occasione dei General Meeting del Fondo Monetario Internazionale. Oltre alle decisioni di politica monetaria, è emerso anche il tema di stabilità del sistema finanziario, in quanto il Board of Governor ha la responsabilità della supervisione del sistema bancario.
Sul fronte della politica commerciale degli Stati Uniti, si attende la sentenza della Corte Suprema sulla legittimità dei poteri utilizzati da Trump per imporre le tariffe reciproche (IEEPA). La domanda che ci si pone è se il deficit commerciale statunitense sia una causa emergenziale che giustifica l’utilizzo dei poteri del Presidente sotto IEEPA. Legalmente la questione è dubbia, tanto che alcune corti di grado inferiore si sono già espresse a sfavore del Presidente. Secondo alcuni esperti, tuttavia, la Corte Suprema potrebbe adottare un approccio più pragmatico per non togliere al Presidente questo potere. È possibile che la sentenza introduca elementi di distinzione, offrendo una valutazione più articolata piuttosto che una semplice conferma o smentita della legittimità complessiva delle tariffe imposte ai sensi dell’IEEPA. Il dibattitto aperto sulle tariffe riguarda principalmente il loro ruolo fiscale (maggiori entrate) piuttosto che come strumento di reindustrializzazione del Paese.
Altro nodo, resta il rapporto con la Cina e la recente escalation delle relazioni tra i due Paesi. Il consenso tra gli investitori è che sia una tattica di negoziazione, per arrivare ad un meeting in una posizione di forza. Tuttavia, per Trump non sarà semplice come è stato con altri paesi arrivare ad un accordo favorevole con la Cina. La Cina, infatti, ha un’importante arma di negoziazione: le terre rare. Inoltre, fornisce agli Stati Uniti buona parte dei beni di consumo, per questo sembra un fornitore troppo importante da perdere.
Sul fronte domestico, è difficile stabilire in quale fase del ciclo economico ci troviamo, da un lato vediamo chiari segnali di indebolimento del mercato del lavoro, dall’alto vediamo capex in crescita. In questo contesto l’intelligenza artificiale sta sicuramente giocando un ruolo, ma è per tutti difficile dire fino a che punto potrà continuare a sostenere l’economia. C’è consenso sul fatto che valutazioni azionarie e spread di credito suggeriscano che siamo in una fase avanzata del ciclo economico. Detto questo, c’è ancora ottimismo (o meglio difficoltà a dare una visione ribassista).
Riassetto delle relazioni internazionali
L’impressione è che siamo in un mondo sempre più polarizzato tra Stati Uniti e Cina. Si è discusso su cosa faranno in questo contesto le economie emergenti, chi sceglieranno tra la Cina, principale partner commerciale per molti di questi Paesi, e gli Stati Uniti, il principale partner finanziario. In questo contesto si calano il recente accordo Stati Uniti e Argentina e le discussioni in vista delle rinegoziazioni dell’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada.
Inoltre, il ruolo degli Stati Uniti sta mutando: non sono più l’assicuratore globale che funge da consumatore di ultima istanza, garantisce una protezione militare all’Occidente e offre i Treasury come asset di riferimento per liquidità e sicurezza. Se questo ruolo dovesse venir meno, i rischi per gli altri Paesi – in particolare per quelli più piccoli e vulnerabili – aumenterebbero sensibilmente, costringendo ciascuno a proteggersi in autonomia.
Da qui a fine anno ci saranno elezioni di medio termine in Argentina, Chile e Perù e il prossimo anno toccherà a Colombia e Brasile. Andando verso queste elezioni, in molti casi ci sono aspettative di un cambio di Governo e uno spostamento verso partiti di destra nella regione. Non c’è consenso se questo sia uno shift strutturale o trainato da sentimento anti-incumbent. I problemi sociali in cima alla lista degli elettori puntano a favorire governi di destra. Si è discusso dell’imprecisione dei sondaggi nelle ultime tornate elettorali, un indicatore più affidabile sembra essere l’approval rating (come barometro di volontà di cambio di governo o meno).
Politica monetaria: si tende alla divergenza
Dopo lo shock inflazionistico post-pandemico e con buona parte del processo di disinflazione ormai alle spalle, le dinamiche dei prezzi appaiono oggi più idiosincratiche e, di conseguenza, le politiche monetarie tendono a divergere. Se, in alcune aree il target di inflazione delle banche centrali sembra ormai raggiunto, in altri Paesi rimangono molto caute. In alcune economie emergenti periodi prolungati di inflazione, anche solo marginalmente al di sopra del target, possono disancorare le aspettative di inflazione e rendere più difficile la convergenza al target.
La Banca Centrale Colombiana, in particolare, ha descritto un’economia piuttosto surriscaldata e vede diversi rischi al rialzo sull’inflazione. In Romania, alcune misure di correzione delle metriche fiscali (tagli a sussidi e aumento dell’IVA) hanno causato un aumento dell’inflazione. La Banca Nazionale della Romania è, per il momento, convinta che questo sia un aggiustamento one off dei prezzi, che rappresenti una dinamica transitoria e, anzi, che l’allineamento di politica fiscale e politica monetaria in territorio restrittivo possano aiutare, il prossimo anno, una convergenza verso i target, anche se per il momento mantengono un approccio cauto.
Negli Stati Uniti, invece, c’è consenso sul fatto che il passaggio delle tariffe ai prezzi al consumo possa essere stato ritardato dalle aziende impegnate nello smaltimento delle scorte di magazzino accumulate nella prima parte dell’anno. C’è, invece, meno consenso sulla capacità delle aziende di passare questi costi sul consumatore.
Eurozona: ripresa economica resta una chimera?
L’ottimismo di inizio anno per una ripresa economica inizia a svanire. Il piano infrastrutturale tedesco c’è, i soldi anche, ma la spesa è più lenta delle attese e le riforme strutturali richiedono più tempo per essere messe a terra. Gran parte del piano è incentrata sulla spesa per la difesa, che si sviluppa in due fasi: la prima caratterizzata da un aumento degli acquisti all’estero e la seconda volta al potenziamento della capacità produttiva interna, un processo più lungo che potrebbe richiedere anche la riconversione di parte dell’industria automobilistica. Al momento, ci troviamo ancora nella prima fase.
Più in generale a livello europeo non c’è interesse a cooperare in materia di difesa: gli stati hanno maggiore flessibilità fiscale (con il rilassamento delle regole fiscali), ma manca un progetto di spesa armonizzato. Per quanto riguarda la crisi politica francese, sembra che il rischio sia contenuto e senza spill over su altri Paesi. Tuttavia, per il momento si fatica a vedere una strada di uscita da tale situazione di stallo.