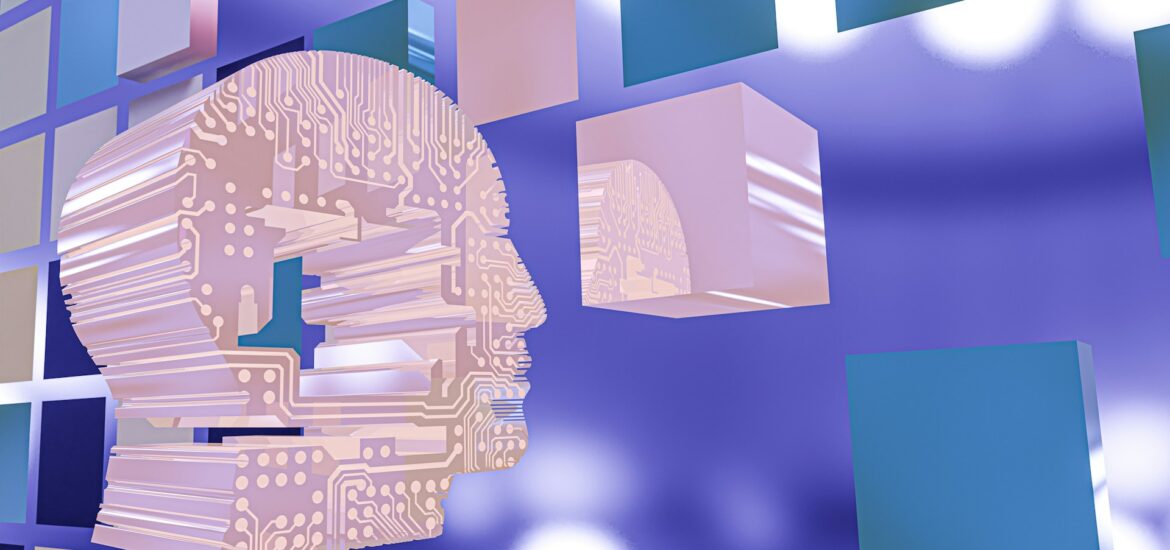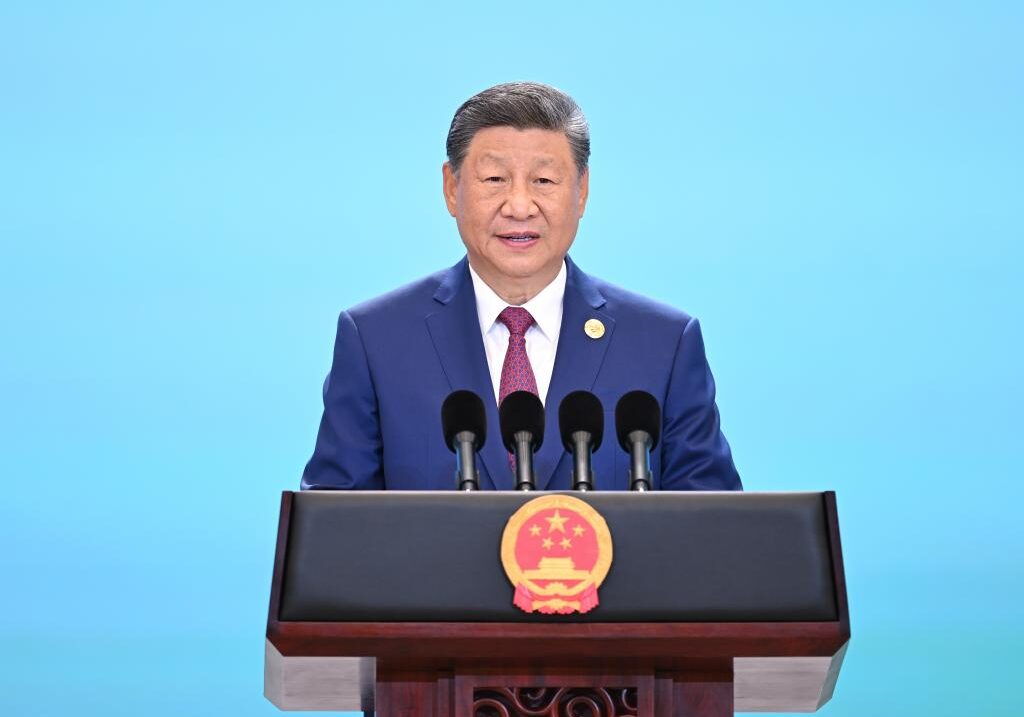Scrivo questo articolo mosso da un recentissimo post dell’eccellente collega Walter Quattrociocchi, l’ennesimo – a dire la verità – in cui spiega, come fa da molto tempo sui social, la pericolosità, per chi non conosce bene il tema su cui chiede spiegazioni, degli strumenti di intelligenza artificiale generativa (IAGen, nel seguito). Nel post Walter ricorda due recenti episodi di sciatteria derivanti dall’uso di questi strumenti. Il primo è un articolo di giornale cartaceo pubblicato includendo anche il testo della solita domanda finale che tutti gli strumenti di IAGen propongono al termine della loro risposta, se cioè l’utente voglia estendere o modificare quanto scritto in funzione di una diversa sede di pubblicazione (p.es., articolo divulgativo invece che scientifico). Il secondo è che una notissima casa di consulenza internazionale ha inserito in un rapporto governativo, tra l’altro molto ben pagato, citazioni inventate ed è stata, per questo, costretta a rimborsare parzialmente quanto ricevuto.
Nessuno dei due esempi è una novità: l’inserimento in memorie legali di casi inventati prodotti da IAGen è qualcosa che accade negli USA da almeno un paio di anni e il dimenticarsi, nel contesto di articoli scientifici, di togliere frasi di contorno prodotte dall’IAGen accade anche questo con una certa regolarità da un po’ di tempo.
Ciò che giustamente Walter osserva, e con cui sono completamente d’accordo, è che adesso il discorso è sistemico, diffuso in tutti i settori e a ogni livello. Queste le sue parole: «Abbiamo delegato il giudizio a un motore statistico del linguaggio, scambiando la coerenza di un testo per la verità di un contenuto. È questo il cuore dell’epistemia: la confusione tra consistenza linguistica e verità epistemica». Concetto che risuona con quanto avevo scritto nell’aprile 2023, avvertendo che il principale pericolo degli strumenti di IAGen è che essi «… non hanno alcuna reale comprensione del significato di ciò che stanno facendo, ma purtroppo (e questo è un problema di grande rilevanza sul piano sociale) poiché ciò che fanno lo esprimono in una forma che per noi ha significato, proiettiamo su di essa il significato che è in noi» e ricordando, due anni dopo, che «esibire competenza sulle parole che descrivono il mondo non equivale ad avere competenza sul mondo».
Ci sono due recenti ricerche che portano ulteriore evidenza di come gli strumenti di IAGen non riescano ad esprimere il loro potenziale e di come, quindi, sarebbe necessaria molta cautela invece che esaltarli acriticamente come qualcosa che tutti devono assolutamente saper usare.
La prima è il rapporto del MIT State of AI in Business 2025 che parla, appropriatamente, di “Divario dell’IAGen”, indicando quello che esiste tra gli alti tassi di adozione di questi strumenti nelle aziende e il basso ritorno sugli investimenti che è stato finora riscontrato. Secondo il rapporto, il 95% delle aziende sta ottenendo un ritorno nullo sugli investimenti, nonostante gli strumenti in sé siano largamente utilizzati. A livello del singolo individuo c’è un aumento di produttività, ma questo non trova riscontro nella redditività aziendale.
Le cause dei fallimenti sono la fragilità nel supportare i processi di lavoro, la mancanza di apprendimento del contesto e il disallineamento con l’operatività giornaliera. Interessante il giudizio sulla scalabilità: «la barriera principale non è costituita dall’infrastruttura, i regolamenti o il talento. È la capacità di apprendere. La maggior parte dei sistemi di IAGen non incorpora il feedback ricevuto, non si adatta al contesto, né migliora col tempo». Di questa difficoltà ne avevo parlato già tre anni fa nel mio libro La rivoluzione informatica (pubblicato proprio quando i primi sistemi si stavano diffondendo) in cui avevo scritto, parlando in generale di “macchine cognitive” (il termine che uso per indicare tutti i sistemi informatici), che queste «non hanno né flessibilità né adattabilità per cambiare il loro modo di operare al mutare delle condizioni di contesto». Fa piacere vedere le proprie valutazioni rimanere valide col passare del tempo.
Quel 5% di aziende che invece ha successo, lo sta ottenendo chiedendo ai fornitori di personalizzare questi strumenti sulle specifiche esigenze dei loro processi lavorativi e sui loro specifici dati (come ho sempre suggerito a chi privatamente mi ha chiesto come poter usare l’IAGen nella propria azienda) e valutandone l’efficacia non in base a generici indicatori di riferimento (tipo il superamento di esami standardizzati in varie discipline) ma considerando quanto effettivamente prodotto.
Una successiva ricerca di un team di ricercatori di Stanford e di BetterUp Labs ha investigato ulteriormente questa situazione. Nello specifico, 1.150 lavoratori USA di diversi settori sono stati intervistati per capire come viene utilizzato sul lavoro ciò che viene prodotto da IAGen. È emerso che mentre alcuni usano questi strumenti per raffinare ciò che hanno realizzato, molti li usano per produrre lavoro di bassa qualità che deve poi essere corretto da qualcun altro a valle. Si sta diffondendo il termine “workslop”, dove “slop” è un termine informale che vuol dire “brodaglia” o “sbobba”, per indicare contenuto generato dall’IA che sembra buono, ma manca della sostanza necessaria per proseguire efficacemente nello svolgimento di un compito. In modo più aulico possiamo tradurre “workslop” come “lavoro raffazzonato”, ed il suo risultato è che la produttività aziendale ne soffre.
In questa ricerca, il 40% dei lavoratori intervistati ha rivelato di aver ricevuto brodaglia nell’ultimo mese, praticamente inutilizzabile. Mentre il fenomeno riguarda soprattutto le interazioni tra pari, nel 18% dei casi si verifica anche gerarchicamente, in entrambi i versi. L’impatto più grave, sul lungo periodo, è quello sulle relazioni di fiducia tra colleghi, che vengono compromesse quando si riceve della sbobba. Anche in questo caso, come per tutte le precedenti ondate tecnologiche, è necessaria prima di tutto una chiara identificazione della strategia mediante la quale questi strumenti possono migliorare i processi lavorativi, seguita dalla scelta della tecnologia in grado di supportare questa strategia e da un’appropriata opera di formazione della forza-lavoro. Insomma, le potenzialità l’IAGen le ha, tutto dipende da come viene usata.
Al retore romano Marco Porcio Catone, detto il Censore, si attribuisce il detto «rem tene, verba sequentur» ovvero conosci bene il tuo argomento, e riuscirai a parlarne bene, per ammonire sull’importanza di padroneggiare a fondo un tema per poterne sostenere validamente la causa. Analogamente potremmo dire, in questo caso: «rem tene, mens mechanica te sustinebit», dove “mens mechanica” indica quella che io chiamo “intelligenza meccanica” invece del più usuale “intelligenza artificiale”.
Solo se si conosce bene ciò di cui si parla, l’IAGen sarà in grado di arricchire e potenziare ciò che uno fa. Per questo ritengo necessario che le basi di ogni conoscenza vadano acquisite, com’è sempre stato, col “sudore della fronte”. Solo così si sarà in grado di usare gli strumenti IAGen nel modo migliore possibile.
(I lettori interessati potranno dialogare con l’autore, a partire dal terzo giorno successivo alla pubblicazione, su questo blog interdisciplinare.)