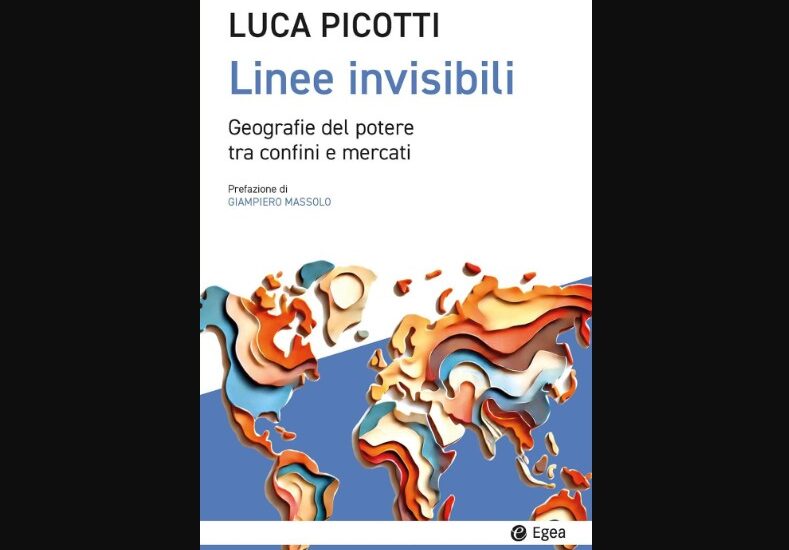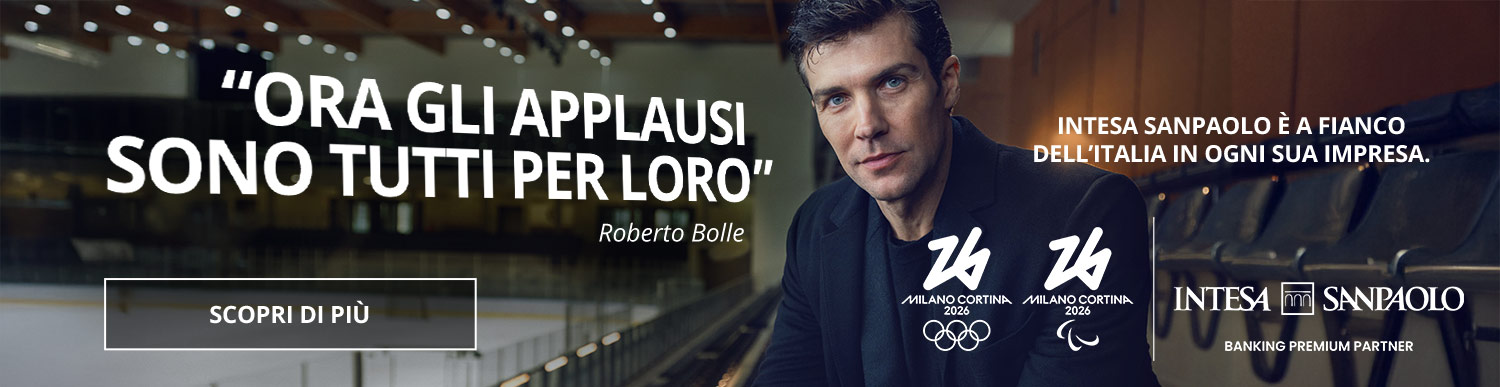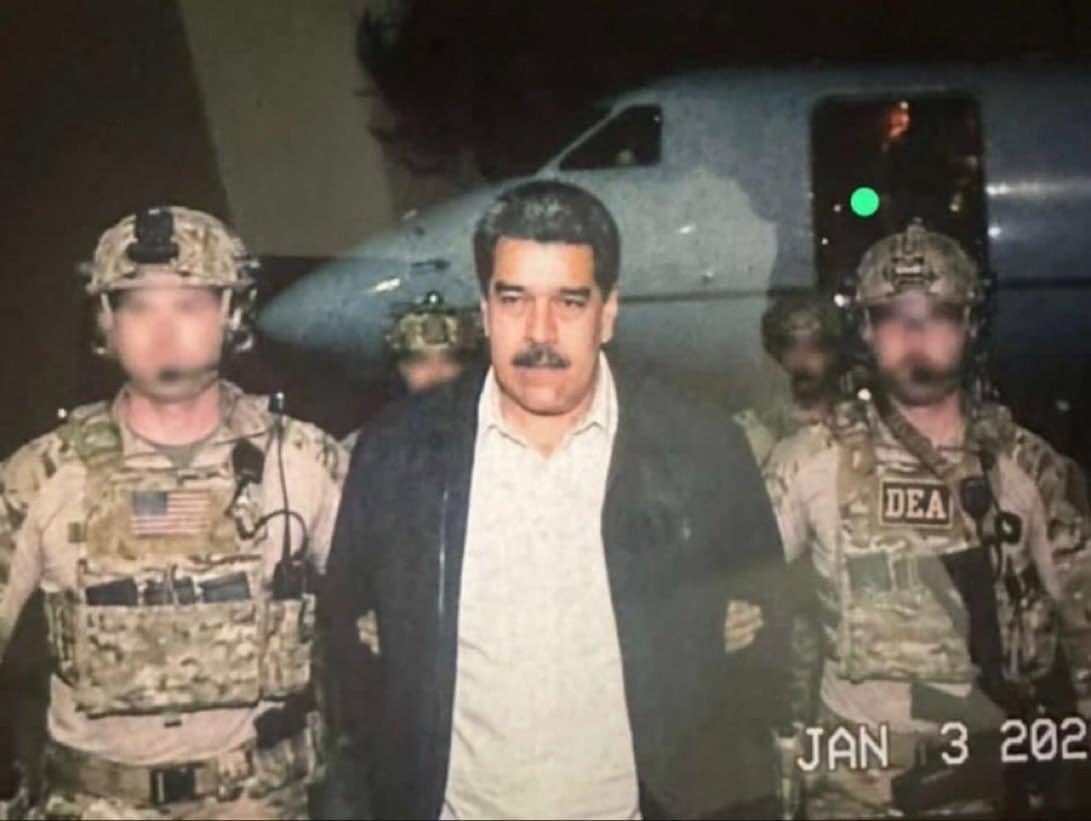In questa sede si è insistito molto sulla dimensione materiale della globalizzazione. Le catene del valore estese, che percorrono decine e decine di paesi e giurisdizioni, sono a tal proposito emblematiche. Più che la finanza o la libera circolazione dei capitali, che pure hanno informato gli ultimi quarant’anni, il vero cuore del mondo globalizzato è dato dall’infografica dei trasporti via mare, attraverso cui passano le merci in un flusso continuo che collega i porti di tutto il mondo e da qui, tramite strade e rotaie, i diversi magazzini.
Peraltro, anche dietro a fenomeni apparentemente intangibili come la finanza o i capitali si nascondono geografie concrete. Sono proprio quelle geografie giuridiche che plasmano il mondo: una piazza finanziaria si trova ubicata in una determinata realtà; i capitali, salvo le azioni più strettamente speculative o certi gusci offshore, vanno in una certa impresa, appartenente a un determinato Stato, a una specifica giurisdizione, a un ecosistema che ha una propria cultura, i propri canoni, i propri consulenti legali. Un capitale di una società basata in Italia che circola e va ad acquisire una quota di una società indiana sta entrando in una nuova geografia giuridica: un diritto che regolerà quell’investimento e il relativo disinvestimento, un legame tra le sorti del capitale investito e la società incorporata nel sistema-paese indiano. La quotazione alla Borsa di New York piuttosto che a quella di Francoforte presuppone che le azioni vengano negoziate in un determinato ordine giuridico, con le sue regole e, soprattutto, le sue autorità di vigilanza. Concrete e tangibili. È vero che esistono incroci opachi di partecipazioni azionarie, arbitraggi, paradisi fiscali, movimenti sospetti; ma le reti della finanza rimangono comunque legate agli specifici ordini giuridici da cui originano, riconducibili in ultima istanza alla dimensione statuale: la legge che regola la Borsa italiana o il Nasdaq o quella che regola la costituzione e l’organizzazione societaria di un’impresa, nonché le relative autorità politico amministrative.
Dopodiché è pure problematico, a ben vedere, riferirsi al mercato in senso astratto, come se fosse una soggettività unica in grado di dettare l’agenda politica. Il mercato è un’entità composita, costellata da imprese soggette a diverse giurisdizioni e con interessi sovente contrapposti, più o meno legate agli Stati di appartenenza, per ragioni territoriali, di sedi a cui sono collegati i centri di produzione, di porte girevoli tra dirigenti pubblici e manager privati, di autorità regolatrici, di sussunzione dell’attività di impresa nella politica estera.
Più che un mercato ci sono enti e imprese statunitensi, francesi, cinesi, giapponesi e via dicendo, intrecciate tanto con i propri Stati, quanto con paesi e società terze, quanto ancora con la singola piazza di scambio, anch’essa a sua volta localizzata in un dato ordine giuridico. Ancora una volta è un sistema prismatico.
Attesa la materialità delle catene del valore e le radici concrete, specie sul fronte dell’ordine giuridico, dei movimenti di capitale e finanziari, ci chiediamo se anche la tecnologia, nella sua dimensione digitale, possa essere ricondotta alla materialità, o se invece sfugga a tale perimetro e, di conseguenza, trascenda le geografie giuridiche della globalizzazione. Sebbene il digitale rappresenti un’effettiva sfida alla configurazione delle linee invisibili, dimostrando una forte attitudine all’intangibile a-territorialità, nemmeno in questo caso si riesce a prescindere da un radicamento concreto, che si declina nelle infrastrutture materiali da un lato e nella localizzazione geo-giuridica dall’altro.
Innanzitutto, il digitale vive di milioni di chilometri di cavi sottomarini, da cui passa circa il 95% delle comunicazioni e la cui tutela risulta centrale, per esempio contro i rischi di sabotaggio. L’ubicazione è perlopiù in alto mare, ossia in una zona priva di sovranità, motivo per cui risulta centrale la gestione delle diverse fasi: costruzione, posa, gestione, proprietà, manutenzione. In questo senso non è indifferente che a effettuare le operazioni di manutenzione sia un’impresa cinese o giapponese o americana, così come a gestirne il funzionamento ordinario o ad averne i titoli di proprietà. Chi controlla i cavi può permettersi di dominare le informazioni che vi transitano. Le partite che si giocano nei progetti di costruzione dei cavi e i relativi protagonisti sono state raccontate in modo piuttosto efficace da Antonio Deruda in Geopolitica digitale. Il volume non solo permette di farsi un’idea sulle principali società attive nel settore, da SubCom ad ASN, da Orange a HMN Tech, da NEC all’italiana Prysman, ma racconta anche i diversi casi in cui la politica è intervenuta tra le geografie giuridiche delle operazioni.
Emblematico è l’accordo del 2016 tra Google e Meta per la costituzione di un consorzio finalizzato a realizzare un cavo sottomarino in fibra ottica (PLCN) per collegare Hong Kong a Los Angeles; nel 2020 il cavo viene posato e il consorzio richiede alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti (FCC) l’autorizzazione finale. Senonché, la presenza nel consorzio della partnership di Pacific Light Data Co. (PLDC), società basata a Hong Kong di proprietà dell’imprenditore cinese Wei Junkang, insospettisce le autorità di sicurezza americane: difatti, nel 2017 PLDC era stata acquisita da Dr Peng Telecom & Media Group, società basata a Pechino con stretti legami con il governo e Huawei. Da qui le pressioni su Google e Meta perché abbandonino o quantomeno dirottino il progetto, nonostante gli ingenti investimenti già effettuati: pressioni accettate infine dalle due società. Peraltro, tra le ragioni di sicurezza evocate vi era anche quella più generale di evitare che Hong Kong diventasse un hub di transito dei dati.
Geografie economiche e giuridiche. Un tema che riguarda non solo il transito e gli sbocchi dei cavi, ma anche i loro stessi progetti di costruzione oltre che di manutenzione. Deruda ricorda come gli Stati Uniti abbiano sostanzialmente impedito, come politica generale, che un cavo costruito, per esempio, da Huawei Marine potesse avere un punto di approdo in territorio americano, optando per altri operatori, come SubCom. Difatti, sottolinea Deru da, la fase di costruzione e posa del cavo è delicata: «tramite accordi segreti un governo potrebbe sfruttare questa fase produttiva per far inserire delle backdoor, prima ancora dell’implementazione delle strutture», alla società incaricata e sottoposta alla sua giurisdizione (e al suo potere politico, pensiamo a Pechino).
Ancora, i dati, sebbene spesso trasferiti con un click, possono essere soggetti a normative che ne disciplinano il trasferimento. Fenomeno sempre più diffuso: secondo un’indagine dell’Information Technology&Innovation Foundation, già solo tra il 2017 e il 2021 si è registrato un aumento, da 35 a 62, dei paesi che hanno deciso di imporre limiti o divieti di trasferimento dei dati all’estero e, di converso, l’archiviazione in server ubicati nel territorio nazionale, con le misure restrittive passate da 67 a 144. In quest’ottica i dati non sfuggono a una localizzazione concreta: stiamo parlando dei cosiddetti data center, infrastrutture fisiche essenziali e alla base del cloud, ossia capannoni che richiedono un’enorme quantità di energia e che contengono al loro interno i vari server nei quali sono conservati i dati. L’ubicazione del data center in una certa geografia giuridica rileva, a partire da controlli, interventi di manutenzione e normative che possono arrivare addirittura a controllare investimenti in zone limitrofe da parte di soggetti stranieri. La specifica localizzazione di queste infrastrutture fisiche del digitale non è qualcosa di trascurabile e non è un caso che la maggior parte di esse sia ubicata negli Stati Uniti dell’«underground empire», per citare i politologici Newman e Farrell, in particolare nel centro più grande al mondo, quello di Ashburn, in Northern Virginia. Uno dei tanti chokepoints dell’impero statunitense.
Non va poi trascurata nemmeno l’impronta materiale (ed ecologica) del digitale, tra mining e consumo elettrico dei data center, come argomentato da Guillame Pitron in Inferno digitale: «L’industria digitale mondiale consuma così tanti materiali, acqua ed energia da rendere la sua impronta ecologica tre volte quella di un paese come la Francia o l’Inghilterra. Le tecnologie digitali consumano oggi il 10% dell’elettricità prodotta al mondo e producono quasi il 4% delle emissioni globali di CO2, ovvero poco meno del doppio dell’aviazione civile mondiale». Il tema, tra parentesi, è rilevante anche per il settore del bitcoin, che ha avuto diversi picchi, da ultimo dopo l’elezione di Trump, e ha dato l’illusione a molti di una realtà in grado di emanciparsi dalla cornice statale e di vivere in una bolla immateriale, senza avvedersi dell’elettricità su cui tale bolla poggia: si è infatti stimato che all’apice dell’utilizzo di tale strumento ogni singola transazione in bitcoin consumasse in media circa 100 dollari di elettricità.
Analogo discorso, in termini di tangibilità di ultima istanza, vale per le varie tecnologie tutelate dai diversi istituti giuridici: brevetti, invenzioni, specifiche tecniche, segreti industriali e commerciali. Non solo vi è la dimensione effettiva della tutela giuridica, che si traduce in controversie nel caso di violazioni di tali gusci protettivi per le imprese innovatrici, ma spesso può accadere che dietro alla generica proprietà intellettuale e relativa geografia vi siano elementi banalmente concreti: per esempio, una documentazione informatica o cartacea inerente a certe soluzioni tecnologiche – che vanno a spiegare i diversi progetti tecnici, protocolli di fabbricazione, passaggi produttivi –, alla quale un membro del consiglio di amministrazione della società che la detiene, o anche solo un addetto minore in caso di scarsi controlli, può accedere e farne copia per poi mostrarla a un’impresa rivale. È un’azione illecita, che passa per il binomio tecnologia-materialità: la singola soluzione così come riportata in una documentazione replicabile, oppure una password per accedere o falle nella sicurezza intra-aziendale. Non è un caso che molte normative sugli investimenti esteri si traducano in prescrizioni atte a garantire la presenza nei consigli di amministrazione di soggetti nazionali e una ponderata ripartizione delle deleghe, soprattutto per quanto concerne affari strategici e di sicurezza. Si pensi alla controversia sui segreti industriali relativi alla produzione di memorie DRAM nel caso Micron-UMC-Fujian Jinhua, in cui vi fu proprio l’indebita trasmissione della documentazione.