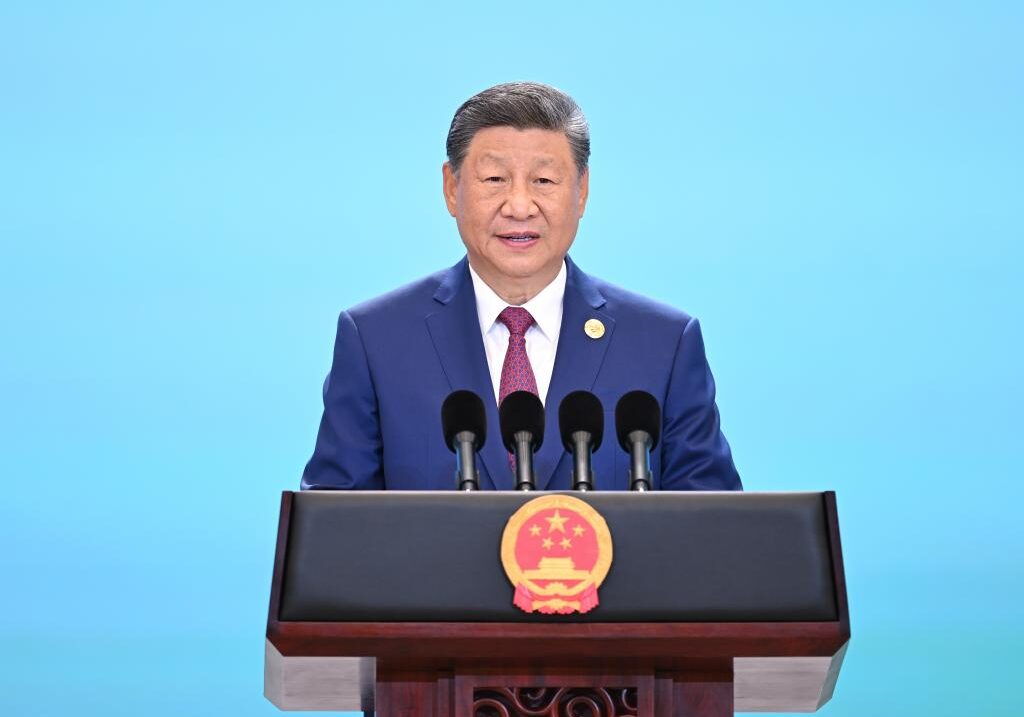È un principio di enorme rilievo per le responsabilità penali di imprenditori e dirigenti aziendali, ma, in materia ambientale, fino a poche settimane fa costituiva una previsione specifica all’interno della disciplina di un singolo reato, la combustione illecita di rifiuti. Dal 9 agosto scorso, data di entrata in vigore del decreto – legge “Terra dei fuochi”, che ha cambiato il volto e il corpo del diritto penale dei rifiuti, è diventato un principio generale (non solo a livello giurisprudenziale) e codificato. Stiamo parlando dell’obbligo di vigilanza a carico del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività comunque organizzata, da cui discende – in caso di violazione di quell’obbligo – la punizione per omessa vigilanza di questi soggetti, se un loro sottoposto commetta qualcuno dei nuovi delitti ambientali. Ma andiamo con ordine.
UNA RESPONSABILITÀ GENERALE E AUTONOMA: L’IMPATTO DELLA RIFORMA
La trasformazione della norma sull’omessa vigilanza da previsione specifica, confinata al delitto di combustione illecita di rifiuti, a principio generale applicabile a un’ampia gamma dei nuovi delitti ambientali (gestione non autorizzata, discarica abusiva ecc…) segna una svolta nella responsabilità penale d’impresa in materia ambientale, che forse sarebbe eccessivo qualificare come “epocale”; ma, di sicuro, sarebbe fuori luogo banalizzarla.
È da rimarcare, comunque, che il diritto pretorio – con particolare riferimento alla nota Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione – aveva già sancito il principio in questione.
La nuova norma titolata “Aggravante dell’attività di impresa” afferma, anzitutto, che le pene previste per i nuovi delitti ambientali su citati sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Subito dopo viene sancito il fondamentale principio oggetto di questo lavoro: il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Ai predetti titolari d’impresa o responsabili dell’attività si applicano altresì le sanzioni cosiddette “interdittive” previste dalla normativa in materia di responsabilità diretta da reato delle persone giuridiche.
Questa disposizione, nella sua nuova collocazione, non si limita più a sanzionare la mancata sorveglianza su un singolo, seppur grave, reato, ma eleva l’obbligo di vigilanza a pilastro della gestione aziendale per prevenire le principali fattispecie delittuose in materia di rifiuti. Proviamo ad analizzare le effettive implicazioni di questa evoluzione.
IMPLICAZIONI DELLA GENERALIZZAZIONE: DALL’ECCEZIONE ALLA REGOLA
Il cambiamento più rilevante è l’ampliamento del campo di applicazione. Mentre prima l’imprenditore rispondeva per omessa vigilanza solo se un suo sottoposto appiccava illecitamente il fuoco a dei rifiuti, ora questa responsabilità autonoma sorge ogniqualvolta un soggetto riconducibile all’impresa commetta uno dei seguenti delitti:
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: include una vasta gamma di condotte, dalla realizzazione di discariche abusive alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni. La giurisprudenza ha chiarito che per integrare il reato è sufficiente la qualifica soggettiva dell’autore (titolare di impresa), senza che sia necessario che i rifiuti provengano dalla specifica attività imprenditoriale.
Combustione illecita di rifiuti: la fattispecie originaria, ora ricompresa nel nuovo sistema.
Spedizione illegale di rifiuti: la norma sanziona la condotta costituente spedizione illegale sulla base della normativa europea di riferimento.
La principale conseguenza pratica di tutto ciò è che l’imprenditore o il responsabile dell’attività organizzata è ora gravato da un dovere di controllo pervasivo su tutta la filiera della gestione dei rifiuti all’interno della propria organizzazione. Non può più invocare la propria ignoranza o estraneità rispetto a condotte illecite poste in essere da dipendenti o collaboratori, perché la legge gli imputa un reato proprio e autonomo che consiste proprio nel non aver predisposto e attuato misure di vigilanza idonee a prevenire tali condotte.
LE SANZIONI: UN MECCANISMO AFFLITTIVO POTENZIATO
Il meccanismo sanzionatorio, già severo nella precedente formulazione, acquista una portata ancora più temibile. La responsabilità si articola su un doppio binario, che colpisce sia la persona fisica al vertice sia l’ente stesso.
RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA FISICA (TITOLARE/RESPONSABILE)
Pena principale: l’imprenditore risponde del reato di omessa vigilanza. Sebbene la norma non specifichi una pena autonoma, il rinvio alle pene previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 suggerisce che la sanzione sarà commisurata alla gravità del reato-presupposto commesso dal sottoposto.
Sanzioni interdittive del decreto legislativo 231\2001: questo è l’aspetto più dirompente, e la cui tenuta dovrà essere testata nella pratica giudiziaria. La norma stabilisce che al titolare d’impresa si applicano “altresì” le sanzioni dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231. Si tratta di misure pensate per l’ente, ma qui estese alla persona fisica, che possono includere il divieto di esercitare la propria attività, di contrattare con la P.A., la sospensione di licenze e l’esclusione da finanziamenti.
RESPONSABILITÀ DELL’ENTE (SOCIETÀ)
Parallelamente, l’ente risponderà ai sensi del già citato D. L.vo 231\2001 se il reato -presupposto (es. gestione non autorizzata di rifiuti) è stato commesso da un suo apicale o da un sottoposto nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il “vantaggio” è stato interpretato dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo anche un mero risparmio di spesa, come quello derivante dal non aver attuato adeguate procedure di controllo e sicurezza.
L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), previsto dalla stessa normativa in materia di responsabilità aziendale da reato, idoneo a prevenire i reati ambientali e vigilato da un apposito Organismo (OdV), diventa quindi non solo un’opzione, ma una necessità strategica imprescindibile per l’imprenditore che voglia mitigare il rischio di incorrere in queste pesantissime responsabilità della sua impresa.
LA GENESI DELL’OBBLIGO: LA POSIZIONE DI GARANZIA
La generalizzazione del principio di omessa vigilanza proviene dalla cosiddetta “posizione di garanzia”, e al contempo la rafforza e cristallizza: quella che la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto in capo all’imprenditore. Questa condizione impone al titolare di poteri di gestione e di spesa il dovere giuridico di impedire eventi lesivi per beni tutelati a livello costituzionale, come l’ambiente e la salute.
La nuova norma, in esame, non fa altro che tipizzare la violazione di questo dovere di garanzia, trasformandola in un illecito penale autonomo. Se prima la responsabilità del vertice per il fatto del dipendente doveva essere costruita attraverso un meccanismo generale previsto dal codice penale (“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”), oggi la legge fornisce una fattispecie ad hoc, che semplifica l’accertamento della responsabilità e ne definisce contorni e sanzioni.
L’OBBLIGO DI VIGILANZA E LA DELEGA DI FUNZIONI
La questione diventa particolarmente delicata in relazione all’istituto della delega di funzioni. La giurisprudenza ammette che l’imprenditore possa trasferire compiti e relative responsabilità a un soggetto delegato, a patto che la delega sia effettiva e rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. La Suprema Corte ha costantemente affermato che la delega, per essere valida, deve, tra l’altro, essere puntuale, espressa, conferita a un soggetto tecnicamente idoneo e dotata dei necessari poteri decisionali e di spesa.
Tuttavia, anche la delega più impeccabile non spoglia mai completamente il delegante delle sue responsabilità. Su di lui permane un inderogabile obbligo di “alta vigilanza” sul corretto operato del delegato. Questo non significa un controllo capillare e quotidiano, ma una verifica sulla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Il delegante è chiamato a rispondere per colpa in (mancata) vigilanza se, pur potendo accorgersi di una gestione inadeguata da parte del delegato, omette di intervenire.
La norma che stiamo esaminando in questo articolo si innesta perfettamente in questo quadro, agendo come sanzione penale per la violazione proprio di questo obbligo residuo di vigilanza. Di fronte a un reato ambientale commesso nell’ambito aziendale, l’imprenditore non potrà più semplicemente difendersi esibendo l’atto di delega. Dovrà dimostrare di aver esercitato attivamente e diligentemente il suo potere-dovere di supervisione. In assenza di questa prova, la sua omissione integrerà il delitto autonomo previsto dalla nuova norma, con tutte le gravi conseguenze sanzionatorie che ne derivano.
CONCLUSIONI PROVVISORIE
In conclusione, come abbiamo già scritto in altre sedi, questa complessiva riforma dei reati in materia di rifiuti dovrà passare al vaglio della prova del fuoco: quella delle aule d’udienza. Come ogni novità legislativa, peraltro.
Tuttavia, per tornare al tema specifico di questo contributo, la previsione sin qui esaminata, spostando e generalizzando il principio di omessa vigilanza, non sembra un mero ritocco formale; pur in presenza di una pregressa e costante affermazione in sede giurisprudenziale di questo stesso principio, come già rimarcato. Appare, invece, come un passaggio sostanziale che formalizza e consolida la mappa delle responsabilità penali ambientali che aveva già disegnato la Corte di Cassazione, ponendo un accento senza precedenti sulla cosiddetta “colpa di organizzazione” e spingendo in modo deciso le imprese verso l’adozione di modelli di compliance efficaci e di una cultura della legalità ambientale effettiva e proattiva.