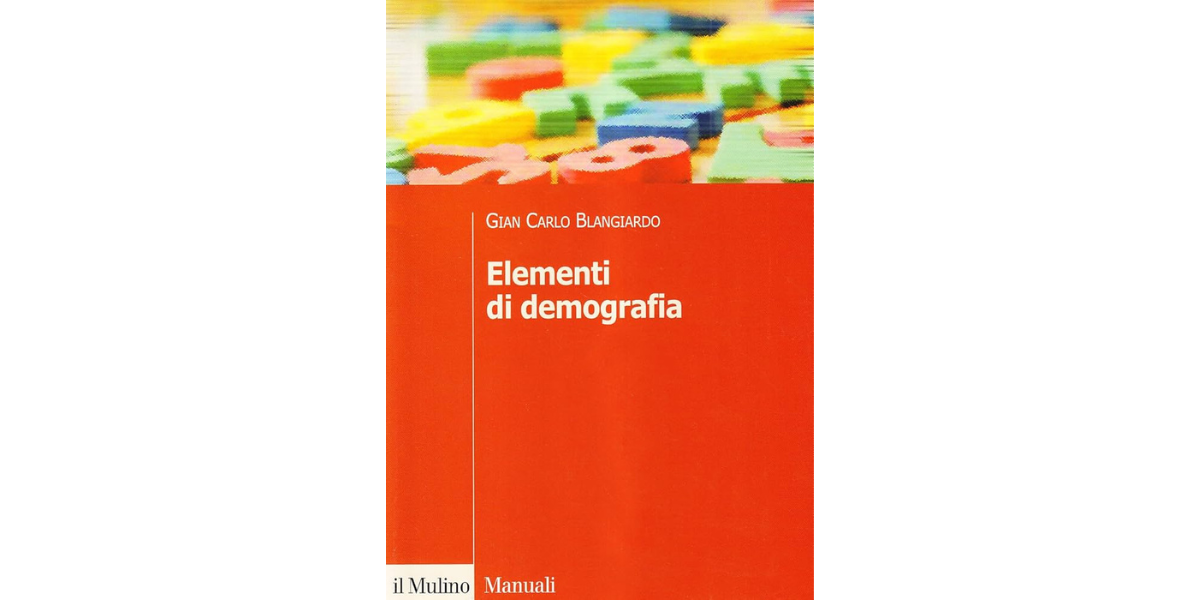È doverosa una precisazione di contesto prima di procedere con l’analisi: sarebbe illogico e fuorviante attribuire la responsabilità della situazione demografica all’attuale esecutivo. Le tendenze in atto vengono da lontano; in particolare, come confermato dalle serie storiche dei dati sulla natalità, il colpo decisivo al calo delle nascite è stato inferto dalla grande crisi finanziaria globale innescata dal crollo della banca d’affari Lehman Brothers nel 2008, uno shock le cui ripercussioni si sono aggravate in Italia con la crisi dei debiti sovrani che ha segnato l’inizio del secondo decennio degli anni Duemila, generando un clima di profonda incertezza economica che ha inciso pesantemente sulle scelte di vita delle famiglie.
L’allarme lanciato dal quotidiano Il Sole 24 Ore circa il futuro crollo delle immatricolazioni universitarie – stimate in calo del 38% nei quindici anni successivi al 2030 – è la punta visibile di un iceberg che lo stesso quotidiano economico, da tempo, segnala in rapido avvicinamento verso le coste del Bel Paese. Questa non è solo una proiezione statistica, ma una minaccia diretta alla sostenibilità dell’intero sistema di istruzione superiore. Un calo così drastico di studenti si tradurrà inevitabilmente in una severa contrazione finanziaria per gli atenei, le cui entrate dipendono meccanicamente dalle tasse studentesche e, indirettamente, dal Fondo di Finanziamento Ordinario, in parte legato agli indicatori di performance che includono il numero di iscritti. L’articolo rappresenta l’ultimo, specifico segnale di quella che è stata definita una “glaciazione demografica”, le cui dinamiche sono state certificate con precisione da tutte le massime istituzioni. Il “Rapporto Annuale 2025: La situazione del Paese” dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) fissa il tasso di fecondità a un minimo storico e proietta un calo della popolazione residente dagli attuali 59 milioni a 54,8 milioni entro il 2050. Questa tendenza è confermata e contestualizzata in un quadro internazionale dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che nella sua nota specifica “Prospettive dell’Occupazione OCSE 2025: Italia”, prevede per il nostro Paese un crollo del 34% della popolazione in età lavorativa (20-64 anni) entro il 2060. Questo dato demografico si traduce in un conto economico pesantissimo. Meno persone in età lavorativa significa, matematicamente, meno braccia per produrre e meno cervelli per innovare. L’OCSE ha quantificato questo impatto in una perdita strutturale di crescita del Prodotto Interno Lordo pro capite pari allo 0,67% ogni anno, un freno a mano tirato sull’economia del Paese. Tale diagnosi è pienamente condivisa dalla Banca d’Italia, che nella sua “Relazione annuale” del 30 maggio 2025, ha avvalorato stime secondo cui la sola riduzione di circa cinque milioni di persone in età lavorativa entro il 2040 potrebbe comportare una contrazione del prodotto nazionale nell’ordine dell’11 per cento. Le università, con il loro imminente calo di iscritti, sono il canarino nella miniera: preannunciano la futura carenza di capitale umano qualificato, in un Paese dove, secondo i dati citati da Il Sole 24 Ore, la percentuale di laureati nella fascia 25-34 anni si attesta al 31,6%, un valore tra i più bassi a livello internazionale e lontano dall’obiettivo europeo del 45%.
L’impatto più dirompente di questa crisi si scaricherà sul sistema di welfare, mettendo a dura prova la sostenibilità delle pensioni e dei servizi alla persona. L’invecchiamento della popolazione si traduce direttamente in una marea crescente di fragilità. Le proiezioni basate su dati ISTAT stimano che il numero di anziani non autonomi, pari a 2,9 milioni nel 2020, è destinato a salire a 5 milioni già nel 2030. Questa prospettiva si innesta su una realtà già imponente, testimoniata dai dati del Rapporto 2025 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), secondo cui le prestazioni di natura assistenziale sono 4.033.210, ovvero il 22,8% del totale, e di queste quasi l’80% riguarda l’invalidità civile. A rendere la sfida ancora più ardua è il progressivo squilibrio del rapporto di dipendenza: vi saranno sempre meno persone in età lavorativa per sostenere, economicamente e con la cura diretta, una popolazione anziana e con disabilità sempre più numerosa. In questo scenario, il lavoro del Comitato tecnico scientifico per l’individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (CLEP), come delineato nel suo “Rapporto finale” Dicembre 2024”, assume un’importanza cruciale. Il rapporto evidenzia la necessità di definire con chiarezza le prestazioni che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio, legandole a un’analisi dei costi e dei fabbisogni reali. La crescente domanda di assistenza per la disabilità e la non autosufficienza rende la definizione di Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) in questo ambito non più un esercizio tecnico, ma un’emergenza nazionale. Senza LEP chiari e adeguatamente finanziati per servizi come l’assistenza domiciliare, l’accesso a strutture residenziali o il pronto intervento sociale, il rischio è che il diritto alla cura venga soddisfatto in modo frammentario e diseguale, aggravando i divari territoriali. Il CLEP sottolinea che il calcolo dei fabbisogni non può più basarsi sulla “spesa storica”, definendola un “vincolo non invalicabile”, ma deve evolvere per rispondere a una domanda di servizi sanitari e socio-assistenziali in profonda e strutturale trasformazione. Questa pressione rende, inoltre, l’innalzamento dell’età pensionabile una leva quasi inevitabile per garantire l’equilibrio attuariale del sistema, una necessità evidenziata non solo dalle analisi della Commissione Europea nel suo “The 2024 Ageing Report”, ma anche dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che indica proprio nella mobilitazione dei lavoratori più anziani una delle strategie chiave per compensare il calo della forza lavoro.
Di fronte a uno scenario così complesso, le strategie future devono muoversi su più fronti, non limitandosi a gestire le conseguenze della crisi, ma aggredendo le cause. L’allungamento della vita lavorativa, necessario per la sostenibilità delle pensioni, pone una questione di qualità e sostenibilità del lavoro stesso, dove la diffusione di modelli di lavoro agile (smart working) può offrire la flessibilità necessaria per conciliare vita e cura. Tuttavia, sebbene le analisi economiche attuali, come quelle contenute nel “Documento di finanza pubblica”, si concentrino sulla mitigazione degli impatti, è evidente che nessuna politica demografica può avere successo senza affrontare la radice dell’incertezza che frena le giovani generazioni. Per invertire la tendenza è indispensabile un potenziamento deciso delle misure volte a garantire stabilità ai giovani. Ciò si traduce in interventi strutturali per contrastare il lavoro precario, incentivando forme contrattuali stabili che permettano di costruire un percorso di vita, e in politiche attive per sostenere l’accesso all’abitazione, agevolando l’indipendenza economica e la formazione di nuovi nuclei familiari. Solo creando un orizzonte di stabilità per i più giovani si può sperare di incidere sulle scelte di genitorialità. Parallelamente, in un contesto di forza lavoro in contrazione, diventa non solo un imperativo etico ma una necessità economica rafforzare con decisione le misure per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Garantire loro l’accesso a percorsi formativi adeguati, anche universitari, e a un mercato del lavoro privo di barriere significa attivare un prezioso bacino di talenti e competenze oggi sottoutilizzato. Permettere a queste persone di raggiungere la massima autonomia possibile non solo risponde a un principio di civiltà, ma consente loro di contribuire attivamente alla ricchezza del Paese, generando reddito e gettito fiscale e trasformando un costo percepito in una risorsa strategica per la tenuta dell’intero sistema economico e sociale.
Francesco Alberto Comellini
Componente Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulla Disabilità – OSPERDI ETS