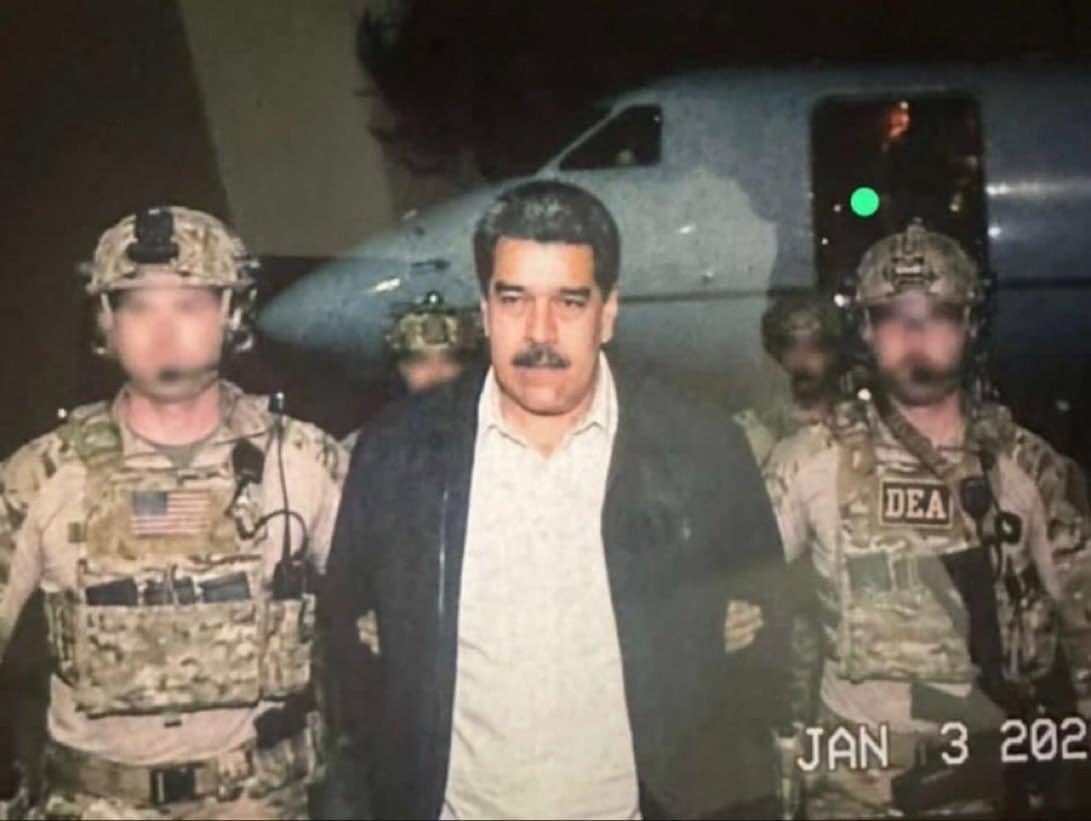Ieri abbiamo provato a stigmatizzare lo scontro in atto tra il ministro Alessandro Giuli e gli ambienti letterati e artistici, ammonendo che certe battaglie tra i vertici istituzionali e intellettuali portano solo ad allargare il distacco da entrambi, trasferendo i cittadini verso la fruizione di prodotti culturali alternativi, come quelli forniti dai social media e dalla rete. Constatazione almeno altrettanto preoccupata si può fare per un altro dissidio istituzionale, quello tra i governi e la magistratura. Un problema che si concretizza in continui casi di polemiche, disapplicazioni, pareri e sentenze dei quali leggiamo dai media e che, in Italia, si colora di tinte fortemente e forzatamente ideologico-partitiche. Per capirci: “I giudici sono di sinistra e fanno opposizione politica” vs “Il governo di destra cerca di sottomettere la giustizia”.
Il problema non è solo italiano e vicende analoghe occorrono in tante nazioni, Usa in primis, talvolta con pronunciamenti che si contraddicono tra loro. La dinamica è sostanzialmente comune: un governo o un leader decidono un’innovazione normativa; un tribunale, un giudice, una corte le contesta la legittimità. Uno scontro tra due poteri che in teoria, secondo la famosa ripartizione di Montesquieu, sarebbero tre: il legislativo affidato al Parlamento, l’esecutivo del Governo e il giudiziario affidato alla Magistratura. Solo che i primi due si sono da tempo fusi, o almeno tendono a convergere, in forme diverse, verso processi politici, decisionali e normativi più celeri, agili. Talvolta spicci. In ossequio a una diffusa convinzione secondo cui i tempi moderni, nella loro concitazione, richiedono scelte al limite della fretta.
Anche questo processo è molto dibattuto, si lamentano spesso “l’esautoramento” delle Camere, ridotte a mere certificatrici di norme scritte altrove, e il ricorso alla decretazione, a dare carattere di urgenza a una legge per la quale si adotta quindi una scorciatoia procedurale. Il principio guida è sempre la velocità, alla quale si oppone la fisiologica, quasi somatica lentezza degli iter istituzionali, delle filiere normative e giudiziarie. I cold case che si riaprono dopo decenni, minacciando di capovolgere sentenze passate in giudicato, e i procedimenti che per decenni si trascinano, fino a dirci che il tale è per certo l’autore dell’orribile delitto, costruiscono narrative appassionantissime per gli amanti del genere ma deleterie per la certezza del diritto.
A una giustizia giusta la rapidità occorre quanto l’equità: un innocente scagionato o un colpevole sanzionato correttamente ma a tanta distanza dai fatti sono ingiusti quasi quanto un reo libero e un non colpevole dietro le sbarre. Il potere giudiziario – di fronte a questa sua sostanziale impotenza, a questa debolezza intrinseca -appare come una torre eburnea occupata da inaciditi legulei, anche quando svolge il suo sacrosanto controllo verso il potere normativo. Che finisce invece per apparire la vittima persino quando partorisce idee improvvisate che sarebbe bene frenare, bloccare, ripensare. Anche perché il suo contropotere di intervenire su atteggiamenti e scelte dannose della magistratura,mediante le norme, appare spuntato dal fatto che queste ultime restano poi soggette al filtro della magistratura stessa.
Come lo scontro culturale, anche quello normativo finisce per indurre in noi persone comuni e ignoranti l’idea che tutte le istituzioni coinvolte abbiano un’ampia parte di colpa, che non siano credibili, che sia tutto uno schifo, che destra e sinistra siano uguali e che si stava meglio quando si stava peggio. Un vento qualunquista, superficialotto ma giustificato dal cattivo esempio che arriva dall’altro. E che spinge i consensi e i voti in direzione delle destre. Cosa di cui, ai politici di sinistra che difendono pregiudizialmente i magistrati, converrebbe tener conto.