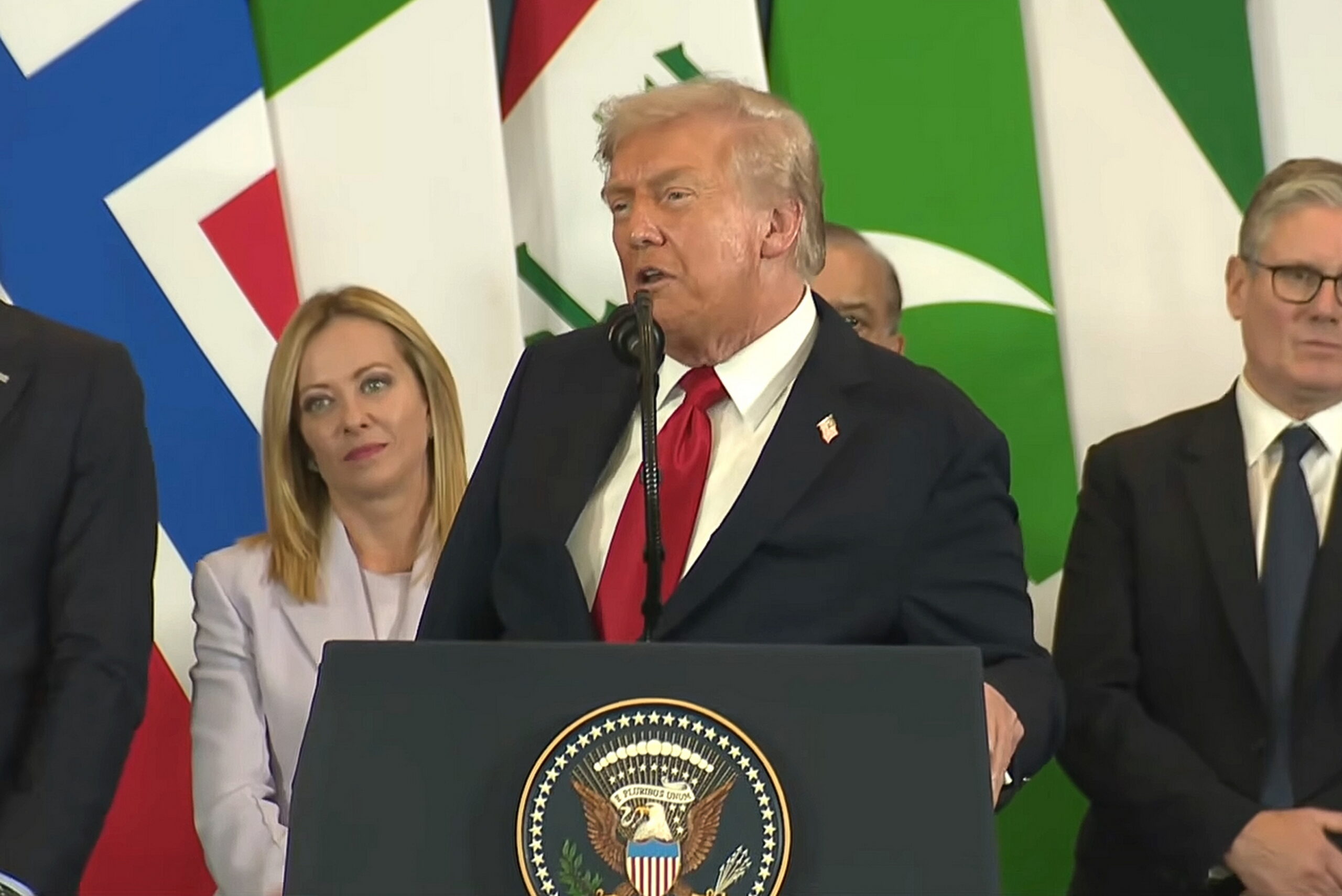Sentii parlare la prima volta di lui nel 2001, un amico uruguaiano mi raccontava di un cardinale atipico: s’alzava prima che il sole sorgesse e passava le prime ore del giorno in preghiera, non aveva né autisti né un’auto propria, si muoveva per Buenos Aires con i mezzi pubblici ed era amico dei curas villeros, i parroci che avevano scelto di vivere nelle baraccapoli alla periferia della città. In Italia era un perfetto sconosciuto, nessun giornale aveva mai scritto di lui. Questi primi racconti mi incuriosivano, come giornalista e come cattolico. Furono confermati e arricchiti di dettagli, pochi mesi dopo, dal mio amico Gianni Valente, che aveva realizzato per la rivista 30Giorni un reportage sull’Argentina intervistando anche il cardinale di Buenos Aires. Fu proprio Gianni a farmi conoscere Bergoglio durante un suo viaggio a Roma, in occasione del sinodo mondiale dei vescovi. Era l’ottobre 2005, esattamente venti anni fa. Nella cena, a casa di Gianni con sua moglie Stefania, il cardinale ci parlò di un’amica di infanzia che era finita a fare il mestiere più antico del mondo e che, ora, radunava in chiesa alcune ex colleghe e chiedeva a “padre Bergoglio” di celebrare una messa per loro, ogni mese. Ci parlò anche di padre Pepe e di come questo giovane prete aveva riscoperto la sua vocazione, andando poi a fare il parroco in una villa miseria. Mi aspettavo una figura monacale, severa, al cui cospetto non sarei riuscito a profferire parola; scoprivo invece una persona mite, dotata anche di sano umorismo, che aveva la capacità unica di mettere a proprio agio il suo interlocutore. Finita la cena, prima di tornare nel pensionato di via della Scrofa, mi chiamò da parte: “devo dirti una cosa”. Sapevo che non aveva gradito il mio articolo sui retroscena del Conclave dell’aprile 2005, apparso su Limes. Mi aspettavo quindi un rimprovero. Lui invece mi guardò, e mi chiese con tono serio: “Lucio puoi pregare per me?”. Non dimenticherò mai quello sguardo. Sembrava che per lui, in quel momento, la mia risposta fosse la cosa più importante del mondo. Balbettai di sì, e allora lui mi disse che anche lui, avrebbe sempre pregato per me. Dall’espressione del suo viso capivo che l’avrebbe fatto davvero. Non potevo immaginare, allora, che la richiesta di pregare per lui sarebbe diventata una delle espressioni più caratterizzanti il suo pontificato. Iniziammo a scriverci, via mail, andai a trovarlo a Buenos Aires, e quando lui veniva a Roma ci vedevamo a casa di Gianni e talvolta nella basilica di san Lorenzo fuori le mura dove don Giacomo Tantardini, vivace discepolo di don Giussani, celebrava la messa prefestiva con centinaia di fedeli (questa foto è stata scattata proprio davanti alla chiesa di san Lorenzo il 3 giugno 2006, da Paolo Galosi).
Nelle nostre lettere ci scambiavamo impressioni sul cristianesimo, su come la fede potesse incontrare il cuore dell’uomo d’oggi. Non poteva accadere, certo, in forza di un dovere o di un ragionamento. Solo per attrazione. Riprendendo sant’Agostino, e la sua “attrattiva amorosa della Grazia” in una delle lettere contestava il pensiero da lui definito “lineare”, che inscatolava tutta la realtà, anche la fede, in rigide categorie intellettuali: «In questo pensiero lineare – scriveva – non c’è posto per la delectatio e la dilectio, non c’è posto per lo stupore. Ed è così perché il pensiero lineare procede nella direzione contraria alla grazia… La delectatio e la dilectio e lo stupore non si possono possedere: si ricevono, semplicemente». Faceva l’esempio evangelico della preghiera del fariseo e del pubblicano: «L’essenza manichea del fariseo non lascia nessuna fessura perché vi possa entrare la grazia; basta a se stesso, è autosufficiente, ha un pensiero lineare. Il pubblicano, al contrario, ha un pensiero tensionante che si apre al dono della grazia, possiede una coscienza che non è autosufficiente ma profondamente mendicante». (Lettera del 30-1-2007). Un cristianesimo dell’attrattiva e dello stupore. Un cristianesimo della mendicanza. Di questo aveva bisogno la Chiesa, e soprattutto il mondo. Non di militanti imbronciati. Bergoglio non si trovava a suo agio con certi interpreti del pontificato di Benedetto XVI che riducevano la testimonianza cristiana a infinite guerre culturali. Ma verso Benedetto aveva stima sincera. lo aveva votato nel conclave del 2005. Nel gennaio 2013 gli inviai il link a un mio documentario su Ratzinger, un ritratto inedito in controtendenza con gli stereotipi del “pastore tedesco”. Gli piacque molto, proprio perché – scrisse – sottolineava «la sua carità e la sua mansuetudine». (Lettera del 17-1-2013).
Meno di un mese dopo giunsero, improvvise, le dimissioni di Benedetto. Da vaticanista sentivo che, fra i cardinali dell’orbe cattolico, non si voleva un papa italiano perché gli scandali che avevano fatto tanto male alla Chiesa erano imputati, a torto o a ragione, proprio ad una curia a trazione italiana. Credetti possibile, quindi, l’elezione di Bergoglio, il più europeo dei latinoamericani. Il suo intervento nelle congregazioni generali, il 9 marzo, aveva impressionato tutti. Quando ci fu la fumata bianca, il 13 marzo, ero in diretta da san Pietro per il mio tg. Non fu facile tenere a bada l’emozione.
Pensavo che dopo l’elezione non ci saremmo più sentiti. Invece fu Francesco a cercarmi. Siamo rimasti sempre in contatto. Il Bergoglio che ho conosciuto io è stato soprattutto un sacerdote, un curatore di anime. Mi è stato vicino, con quella discrezione che è «una prima forma di carità», nei momenti più lieti e in quelli più dolorosi della mia vita. Una volta gli confidai un grande dispiacere, la mattina successiva mi fece recapitare a casa un libro, “Lettere dalla tribolazione”, e una busta piena di santini con preghiere a san Giuseppe e a santa Teresina del Bambino Gesù. Ho fatto sempre fatica a capire quanti dipingevano Bergoglio come un pericoloso modernista. La sua fede si è sempre nutrita di una pietà molto tradizionale: rosario, adorazione eucaristica, novena a santa Teresina… Anche la sua sollecitazione per le anime mi è sempre sembrata molto tradizionale, nel solco dei grandi missionari gesuiti, ma anche del curato d’Ars o, per restare in Argentina, del Cura Brochero che a dorso di un mulo percorreva chilometri per raggiungere tutte le anime affidate al suo ministero.
Mi è capitato, alcune volte, di riferire a Francesco situazioni di sofferenza, vissute da persone comuni con cui venivo in contatto. Lui è sempre intervenuto, lontano dalle telecamere, a consolare o confortare nella fede, con una telefonata o un biglietto scritto a mano. Immagino quanti altri casi abbia seguito, con lo stesso cuore sacerdotale, in questi dodici anni. Una carità nascosta, che è bello sia rimasta tale. «Vicinanza, compassione tenerezza»: lo ripeteva spesso in pubblico, descrivendo il modo con cui Dio si rapporta all’uomo, ideale a cui doveva ispirarsi anche l’approccio della Chiesa verso le persone, senza chiudere la porta a nessuno: «Tutti, tutti, tutti!». Se potesse leggere queste righe credo che commenterebbe, con una risata, che ne sto facendo un santino. Ma i santi non sono uomini perfetti, sono uomini veri, con i loro errori, il loro difetti, a volte il loro caratteraccio. Peccatori guardati dal Signore. “Misericordiati”.
Il discorso per me più bello resta quello ai detenuti del carcere di Palmasola, in Bolivia, il 10 luglio 2015: «Chi c’è davanti a voi? Potreste domandarvi. Vorrei rispondere alla domanda con una certezza della mia vita, con una certezza che mi ha segnato per sempre. Quello che sta davanti a voi è un uomo perdonato. Un uomo che è stato ed è salvato dai suoi molti peccati. Ed è così che mi presento. Non ho molto da darvi o offrirvi, ma quello che ho e quello che amo, sì, voglio darvelo, voglio condividerlo: è Gesù, Gesù Cristo, la misericordia del Padre».
Mi è capitato, alcune volte, di esprimergli perplessità su alcune sue scelte, ad esempio nell’ambito della comunicazione. Lui aveva la capacità di farti sentire libero, anche di dirgli ciò che non ti convinceva. Non so se con altri ha avuto la stessa pazienza, ma mi ha sempre ringraziato per le critiche. In un’intervista che gli feci insieme con Paolo Ruffini, per Tv2000, nel 2016, ci disse di preferire i detrattori agli adulatori: «Io ho allergia degli adulatori. Mi viene naturale, non è virtù. Perché adulare un altro è usare una persona per uno proprio scopo, nascosto o meno… I detrattori parlano male di me, e io me lo merito, perché sono un peccatore: così mi viene di pensare. Ma non te lo meriti per quello di cui ti accusano? No. Però, magari per un’altra cosa che lui (il detrattore) non sa».
Ci siamo scritti brevi messaggi anche negli ultimi mesi. Mi impressionava la lucidità, la passione e il coraggio con cui denunciava le crudeltà della guerra combattuta in Ucraina e in Terrasanta. Anche a costo di apparire impopolare o di irritare qualcuno.
Profondamente libero. Il 20 gennaio scorso, già con quella brutta bronchite che provocò il ricovero al Gemelli, mi confidò il desiderio di compiere un viaggio a Gaza, una visita pastorale alla piccola comunità cattolica, con cui era stato sempre in contatto telefonico dall’inizio dei bombardamenti israeliani. L’immagine del Papa, in carrozzina, tra le macerie della guerra sarebbe stata un messaggio potente di vicinanza a tutta la popolazione palestinese. «Sarebbe una buona cosa» scriveva. Aggiungendo: «ne parlerò con la Segreteria di Stato per “sondegiare” la cosa». L’aggravarsi delle condizioni di salute bloccò forse ogni verifica. Un viaggio che sarebbe stato impossibile, probabilmente, in ogni caso, per motivi politici. Ma commuove il pensiero del Papa quasi novantenne, malato, che desiderava essere fisicamente vicino alla popolazione della Striscia di Gaza, come lo era stato con i familiari delle vittime israeliane delle stragi del 7 ottobre e dei rapiti da Hamas. Segno di quella compassione per l’uomo propria di Cristo, di cui Francesco ha domandato al Signore di essere un povero testimone.
(Estratto dal blog di Lucio Brunelli)