Esperti e massmediologi hanno cominciato a cercare le ragioni della caduta relativa del Paese oltre il perimetro dei fattori strettamente economici e guardano anche ai fattori istituzionali come il ruolo delle classi dirigenti economico-finanziare, operatori della comunicazione inclusi. Ne parlano gli economisti Carlo Bastasin e Gianni Toniolo nel recente volume La strada smarrita (Laterza).
Ne trattano Emanuele Felice e Andrea Capussela esponenti della così detta Institutional economics nei loro libri. Ernesto Galli della Loggia ha scritto sul Corriere della Sera che il sistema informativo è il “regista” del fenomeno per cui in Italia si parla di tutto tranne che delle cose importanti.
I massmediologi Daniel Hallin e Paolo Mancini hanno inquadrato l’Italia nel cosiddetto modello mediterraneo di giornalismo, un giornalismo più orizzontale che verticale, ossia che parla più alle élite che ai fruitori finali delle notizie (i famosi 1550 lettori evocati da Enzo Forcella in un famoso libro che si dice gli costò la cacciata da La Stampa), un giornalismo che più che fare da ponte tra le elite e i cittadini si schiera (perdendo in questo modo “credibilità” secondo Fabio Martini, editorialista de La Stampa e studioso dei problemi dell’informazione).
E’ anche per questo che il giornalismo italiano, concentrato sulle vicende del Palazzo, non ha mai visto arrivare il nuovo che avanzava.
Non ha anticipato il fenomeno Lega (esploso nelle politiche del 1987 ma già evidente nelle precedenti elezioni locali), né Tangentopoli (scoperta grazie ai magistrati nonostante le avvisaglie non mancassero) né il boom dei Cinque Stelle, nè (come molti nel mondo va detto) la crisi finanziaria del 2008.
Il giornalismo con le debite eccezioni ovviamente ha più che altro assecondato la classe politica piuttosto che stimolarla criticamente al cambiamento. Basta vedere come è stata trattata la questione della guerra in Ucraina.
Come sottolinea Sofia Ventura non si può non rilevare la “differenza tra come i media britannici hanno trattato la questione e la approssimazione dei format italiani ossessionati dall’insopprimibile necessità di dare spazio alle opinioni più disparate”.
In Italia è potuto accadere che in piena guerra ucraina siano stati intervistati gli esponenti più radicali del “nemico” o addirittura il ministro degli Esteri della Federazione russa con la scusa di fare informazione, come se non lo conoscesse nessuno.
Oppure può succedere che sempre trincerandosi dietro il vincolo del pluralismo, in piena pandemia si sia dato spazio alle più sguaiate tesi no vax. Non meraviglia che in qualche caso le persone più competenti si siano rifiutate di partecipare. Come Natalie Tocci, direttrice dello Iai, secondo la quale la sua presenza nei talk finirebbe per “legittimare le tesi più strampalate che vi si espongono”.
Grazie ai talk succede anche che si possa lanciare nell’empireo televisivo un personaggio discutibile come Alessandro Orsini, lanciato e poi abbandonato come uno straccio vecchio, quindi recuperato da Bianca Berlinguer.
Con l’arrivo al governo della Destra la musica non è cambiata. Anzi, semmai certe caratteristiche si sono accentuate, tenuto conto della forza della maggioranza parlamentare di cui dispone Giorgia Meloni, e la selezione dei media in funzione del grado di “amicizia” si è intensificata.
Oggi il sistema informativo italiano ruota attorno a un vasto e variopinto circo mediatico politico. Il sistema è strutturato sostanzialmente su due emittenti televisive, la Rai pubblica e Mediaset privata, due grandi quotidiani nazionaIi, diversi giornali politicamente schierati e alcuni fogli minori dotati di notevole reputazione votati all’analisi e all’approfondimento critico.
La tv è diventata il principale medium di riferimento (e questo è normale), i social sono esplosi.
Purtuttavia la carta stampata sebbene in crescente difficoltà non ha perso la sua influenza. Anche se le copie vendute si sono ridotte di due terzi il numero dei quotidiani è in aumento e di recente un imprenditore della sanità che è anche un politico di centro destra come Antonio Angelucci ha investito nella filiera dei fogli filogovernativi con l’arrivo di Giorgia Meloni al potere.
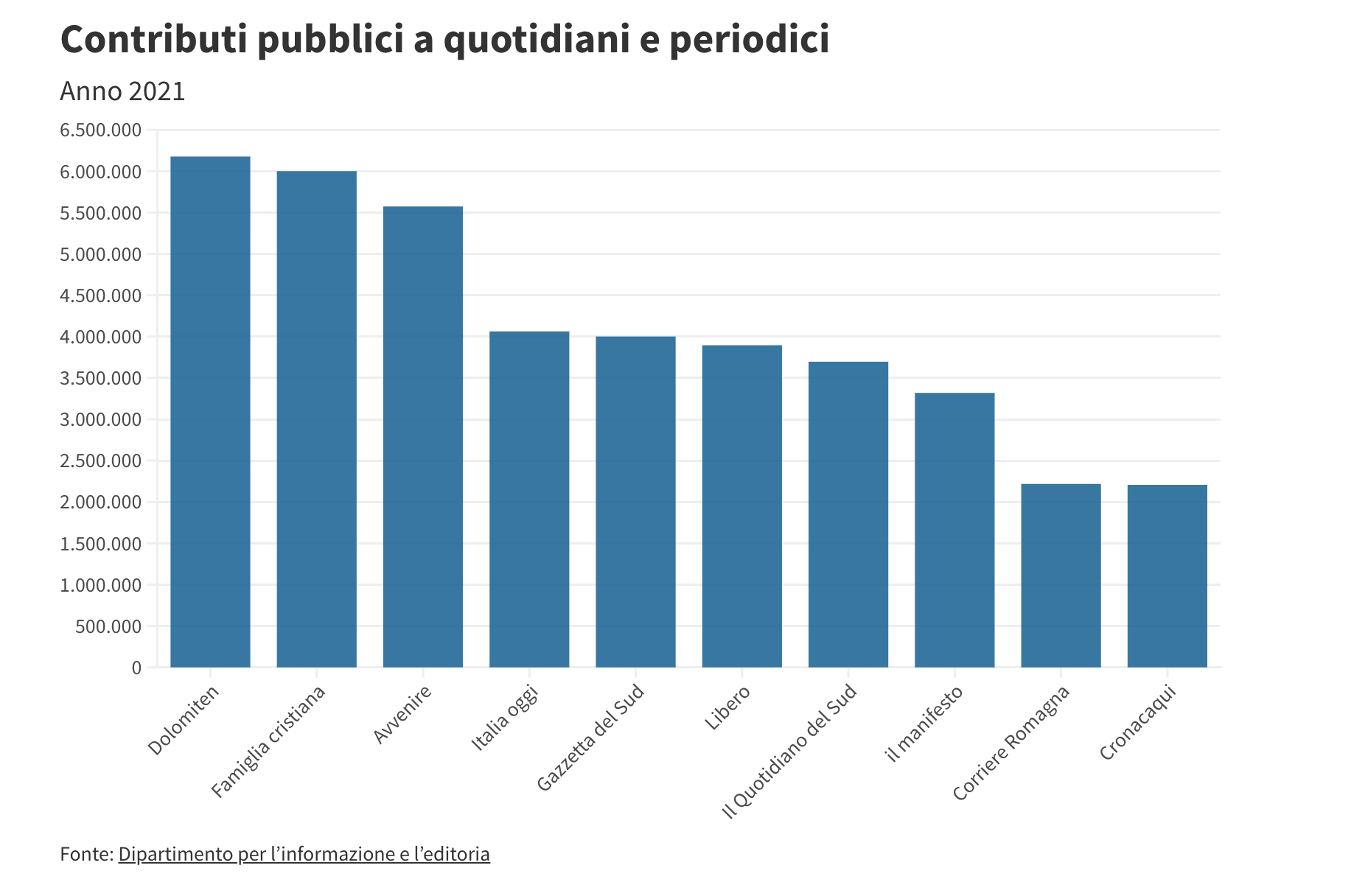
Inoltre sono tornati in edicola l’Espresso, la Gazzetta del Mezzogiorno, l’Unità. Da qualche tempo è alle stampe la funzione il Quotidiano del Sud. La proprietà di un mezzo editoriale resta una fonte non trascurabile di potere.
La cifra del circo politico mediatico è una contiguità con il potere che secondo i maligni sfiora la collusione.
I salotti della politica e del giornalismo a Roma sono sempre aperti. Nella Prima Repubblica il monopolio lo aveva Maria Angiolillo, di cui Bruno Vespa e Candida Morvillo hanno raccontato con chirurgica precisione i riti.
Oggi, mancata Donna Maria, il suo pubblico si è riversato in tanti salotti e salottini diversi.
La contiguità con il potere non riguarda solo la politica, tocca anche l’economia, la finanza e relativamente al potere giudiziario ha avuto la sua più macroscopica manifestazione nel periodo di Tangentopoli (un “infamia” secondo Indro Montanelli). Tuttavia la politica ne è l’espressione più eclatante. Entro certi limiti, la contiguità con il potere è un “fenomeno comune”.
Il punto è che i giornalisti italiani, fatte le dovute eccezioni naturalmente, non sembrano considerare il sistema informativo come “qualcosa che ha un valore in sé e ciò li rende più condizionabili e dunque tendenzialmente percepiti come meno credibili”, dice Richard Heuze, l’ex corrispondente di Le Figaro da Roma, uno che conosce bene la realtà del nostro paese in cui ormai ha deciso di vivere.
Dal giardino della sua casa sul colle si gode una speciale vista sulla città. Nell’ingresso sono impilate decine e decine di copie del Corriere della Sera e della Repubblica: da consumato corrispondente cresciuto in anni pretecnologici ama assaporare il profumo della carta quando varca la porta della sua abitazione.
Il fenomeno del così detto parallelismo politico è presente anche altrove. Tuttavia, “se si sfogliano le pagine di Les Echos, le Figaro o Le Monde, della Faz o perfino della Bild si percepiscono aree culturali di riferimento ma non posizioni di fiancheggiamento di questa o quella parte politica, i toni sono più freddi, meno partecipati, l’informazione più neutra. I fatti più numerosi, le opinioni più controllate”.
Secondo gli ex-editorialisti del Financial Times Ferdinando Giugliano e John Lloyd il rapporto tra giornalismo e politica in Italia è cambiato con l’entrata in scena di Silvio Berlusconi che con il suo enorme potere economico e mediatico ha obbligato gli operatori dell’informazione a schierarsi, o di quà o di là (Eserciti di carta, Feltrinelli).
Nel Centro Nord Europa i mezzi d’informazione presentano tratti non dissimili, che tuttavia si associano a un forte senso dell’autonomia e della libertà di stampa, una elevata considerazione per la professione e una informazione più neutra e verticale, vale a dire imparziale e destinata all’uomo della strada più che alle elite.
In Italia viceversa i media sono percepiti più come strumenti per influenzare l’opinione pubblica che come fonti super partes di informazione.
Anche negli Stati Uniti cresce la tendenza alla polarizzazione politica dei media. New York Times e Washington Post, Fox News Tv sono organi d’informazione schierati.
Ma il principio che le opinioni devono il più possibile essere separate dai fatti o quando li accompagnano devono essere dichiarate continua a fare parte della tradizione del giornalismo americano.
Nel nuovo assetto i talk show, che in Italia hanno una diffusione che non ha eguali in Europa e forse nel mondo, sono diventati la sede deputata del dibattito politico nazionale.
Funzione meritoria che tuttavia data la natura del mezzo paga un prezzo molto alto sul piano della qualità dell’informazione. Nei talk show che, come dice la parola stessa, sono dibattito e spettacolo l’equilibrio tra il talk e lo show oscilla. Il terrore dei conduttori sono i commenti noiosi e complessi che possono abbassare lo share.
Gli ospiti sono selezionati in base alla loro competenza ma anche alla loro appetibilità televisiva. E la discussione più che un confronto sui fatti è uno scontro organizzato di opinioni.
Gli stili di conduzione sono diversi ma accomunati dalla semplificazione e dalla velocità imposta dai tempi televisivi, il che rende praticamente impossibile un reale approfondimento. C’è il conduttore serio ed affidabile, look istituzionale in giacca e cravatta.
C’è il giovane con l’aria da primo della classe che fa di tutto per apparire super partes. C’è il conduttore all’americana, look aggressivo, maniche di camicia arrotolate. C’è il liberale narciso, molto protagonista. C’è la conduttrice polically correct con un direttore di riferimento ospite fisso.
C’è il conduttore sguaiato che urla, strepita, si traveste, utilizza il proprio corpo, genere trash tv. C’è la conduttrice esuberante che mette in piedi un salotto mattutino in cui appare in confidenza con tutti indistintamente.
Naturalmente sarebbe ingiusto generalizzare. Il giornalismo di qualità e i bravi reporter d’inchiesta non mancano in Italia, sia nella carta stampata che nella televisione pubblica e privata.
Secondo uno studio della rivista Il Mulino tuttavia, quello prevalente oggi in Italia è un giornalismo succube della televisione, fatto di battute ad uso e consumo dei giornali del giorno dopo, dichiarazioni, interviste “al volo”, iperboli (la mucca nel corridoio di Pierluigi Bersani).
Questa modalità di fare informazione ha trovato porte aperte in un personale politico disposto a trascurare le realtà istituzionali in favore dello spazio mediatico. Una comparsata in un talk show per un politico è più importante di una seduta parlamentare.
L’informazione di qualità finisce per perdersi in questo incessante rumore mediatico di fondo fatto di notizie non notizie, facili denunce per vellicare i gusti del “qui niente funziona” del pubblico, trattazione dei problemi più vari nello stesso contesto.
Il paradosso del fenomeno è nell’era della spettacolarizzazione all’italiana la funzione informativa è sempre più appannaggio di soggetti diversi dai veicoli classici delle notizie, mentre la carta stampata pur perdendo vistosamente copie assume sempre più la funzione di baluardo di interessi specifici e i giornalisti si pongono più come power broker portatori di reti relazionali che come veicoli informativi.
La chiacchera politica domina mentre il rispetto per la politica intesa come funzione alta latita. I politici talvolta sono ridicolizzati dai comici che intervengono negli intermezzi dedicati all’intrattenimento per solleticare i sentimenti qualunquisti e antipolitici dei telespettatori. Ma devono stare al gioco e sorridere.
Il risultato di questo quotidiano mix di contenuti importanti e politica politicante, dibattito e intrattenimento è che politici e giornalisti sembrano appartenere a un universo indistinguibile e scarsamente credibile agli occhi del pubblico.






