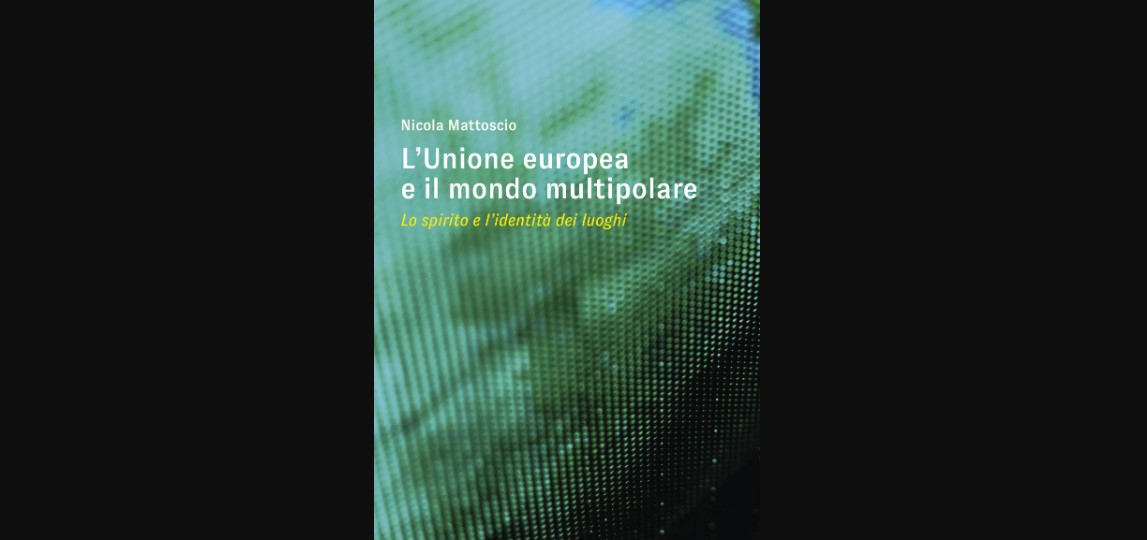L’Unione europea ha superato il suo primo trentennio e si qualifica come “uno dei laboratori più virtuosi mai vissuti nella storia internazionale”, dal cui modus operandi è possibile desumere fatti “davvero esemplari” o “buone pratiche”, un “modello originale di processo decisionale intergovernativo”, tramite i tre soggetti: Parlamento, Consiglio e Commissione. Una valutazione decisamente eurottimista, quella che Nicola Mattoscio dà nel suo L’Unione europea e il mondo multipolare. Lo spirito e l’identità dei luoghi, di recente edito da Rubbettino. Una valutazione, quella dell’autore, esperto di mercati finanziari e monetari, già Ordinario di Economia politica all’Università di Chieti-Pescara e professore straordinario all’Università G. Marconi di Roma, che decisamente contrasta con lo scetticismo diffuso sugli organismi comunitari.
L’UE dopo l’euro è divenuto uno dei presepi sui quali si spara più facilmente e volentieri. Apparato burocratico volto a limitare la libertà degli individui e la sovranità degli Stati, farraginoso meccanismo decisionale incapace di adeguarsi alla volubile celerità delle realtà contemporanee, formazione sovrannazionale che non rappresenta adeguatamente il ruolo e la storia europei nel contesto globale, sono solo alcune delle critiche che più spesso vengono mosse a Strasburgo, Bruxelles e dintorni. La visione di Mattoscio è opposta.
Non trascurando nuovi aspetti di analisi, come il soft power e lo smart power, il volume insiste sui contorni della nuova Guerra Fredda tecnologica e della frammentazione del potere globale, che ormai tende a oltrepassare la divisione tra democrazie liberali a economia di mercato ed autocrazie dispotico-stataliste. Dalla multipolarità, così delineata, si rafforza secondo l’autore la necessità di esprimere visioni per il futuro in cui riprenda vigore il sogno di un’Unione federale. Un obiettivo che pare lineare rispetto al percorso seguito con il Trattato di Maastricht e quello di Lisbona, per i quali la Cittadinanza europea dovrebbe costituire un perfezionamento e un accrescimento, non una limitazione dei diritti delle persone. Così pure non si può – sostiene il saggio – rinunciare all’obiettivo finale di dotare l’UE di una vera Costituzione, così come in economia si è realizzato un vero mercato comune, con processi di progressiva integrazione in capo a diversi settori di attività, portando a compimento avanzato quanto era stato concepito nel lontano 1970.
Perché dunque, dopo il Trattato sull’Unione sottoscritto il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, che conduce alla nascita dell’euro e del Patto di stabilità, i significati generali che rinviano a quelle scelte non sembrano reggere ai profondi cambiamenti che caratterizzano gli scenari planetari? Gli effetti provocati dall’emergenza pandemica da Covid-19 sono in tal senso un vero spartiacque, l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022 e l’attentato di Hamas del 7 ottobre 2023 hanno enormemente complicato le cose e soprattutto depresso la spinta unitarista.
Il volume raccoglie note giornalistiche, pubblicate come focus speciali su problematiche che declinano la prospettiva del nuovo europeismo “pragmatico”, oltre che istituzionale, senza sottovalutare la spinta europeista persino di Albert Einstein o momenti topici quali la redazione del Manifesto di Ventotene del 1941. Nei sette capitoli, si spaziano dal “Secolo belva” alle peculiarità del nuovo europeismo, dagli obiettivi del Recovery Plan all’economia digitale e green per concludere con il nuovo ordine internazionale in corso di ridefinizione in un contesto sempre più multipolare e con scenari incipienti come la nuova “Guerra Fredda tecnologica” USA-Cina e il mercato delle “materie rare”.