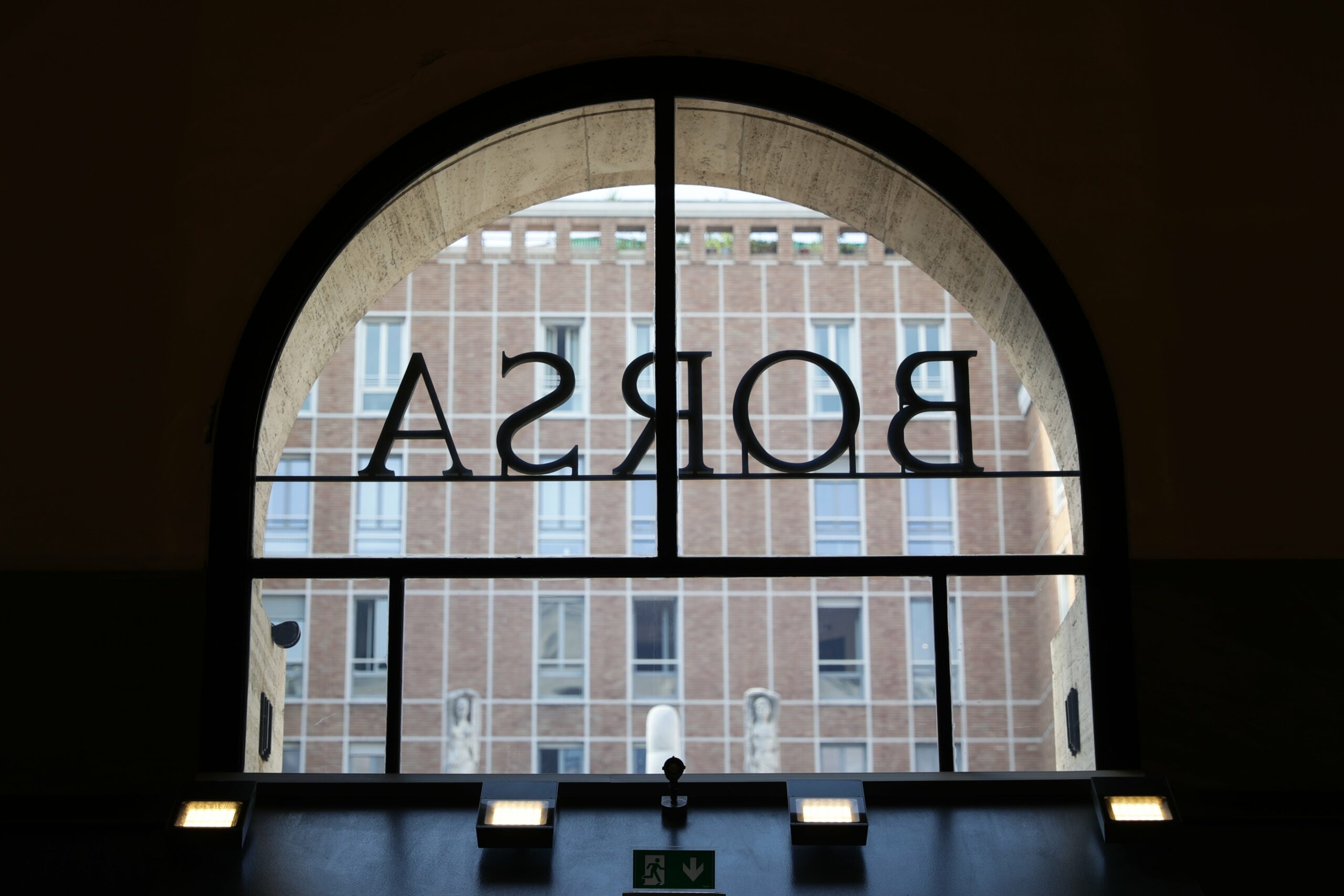Il rimpianto per le dittature e per il mondo bipolare che ha resistito per gran parte della seconda metà del Novecento emerge, sporadicamente e a livello di provocazione, con qualche ragione. Come battuta di spirito, la nostalgia di un ordine internazionale più semplice è comprensibile, anche se non giustificata. Noi europei, i nordamericani, i giapponesi e gli abitanti di alcuni altri paesi vivevamo in democrazia, mentre l’Europa dell’Est, la Russia, la Cina e il Sud America erano consegnati a regimi totalitari, con i quali però venire a patti era possibile, quasi facile. E comunque se ne potevano prendere le misure per regolarsi.
Andando verso la fine del secolo scorso si è profilato uno scenario più complesso, segnato dall’aggravarsi di una preesistente violenza terroristica diffusa. Di un terrorismo e un bellicismo in parte riconducibili al mondo radicale musulmano, peraltro diviso tra diverse sigle: Hamas, Hezbollah, Isis, Al Qaeda, Huthi… Sigle fautrici tutte di politiche aggressive ma con differenti sfumature che, quando il fine del Jihad si mescola con specifiche rivendicazioni territoriali o giuridiche, inducono una parte dell’opinione pubblica del “mondo libero” ad atteggiamenti di tolleranza, se non addirittura di sostegno. Quest’ambiguità porta nazioni come l’Iran a minacciare apertamente e gravemente la pace, un po’ come accade nel caso della Russia, saltando dal Medio Oriente all’Ucraina. C’è inoltre un intero continente, l’Africa, soggetto in gran parte a regimi instabili e/o dittatoriali, che versa in situazioni socio-economiche di grande difficoltà, dilaniato da guerre e persecuzioni feroci, soprattutto contro i cristiani. Il tutto nel silenzio quasi generale del mainstream e delle breaking news, nonostante che queste situazioni geopolitiche producano molte vittime, violenze efferate e che siano per gli europei di diretto interesse.
La confusione e lo sgomento sono insomma plausibili, ancor più se consideriamo le crisi in corso in Corea, dove impera uno degli “stati-canaglia” per eccellenza, e a Taiwan, su cui la Cina tiene puntati gli occhi. Pechino ha già messo anche le mani su Hong Kong senza che il “mondo libero” battesse ciglio, ma stavolta gli Usa potrebbero essere intenzionati a una difesa più netta dell’indipendenza di Taipei, dove si voterà il 13 gennaio.
Ad andare alle elezioni, quest’anno, sarà però una metà circa degli elettori mondiali: tre miliardi di persone in Ue, Usa, Russia, India e Indonesia, solo per dire gli appuntamenti che impegneranno le popolazioni più numerose. Un trionfo del mondo libero, democratico e avanzato? Non proprio. All’aggressività, al terrorismo, alla sopraffazione e alla violenza praticate in tante aree del globo, la sovranità popolare non pare più opporsi come un antidoto, un elemento identitario forte, anzi. Si va alle urne con scetticismo, disillusione e, spesso, contestazione dello stesso metodo elettivo. Le accuse reciproche tra Biden e Trump, soprattutto quelle rivolte dal primo verso il secondo, che tendono a negare la legittimità della candidatura, fanno parte di un processo di “delegittimazione” che inficia più la competizione democratica che l’avversario contro il quale lo si utilizza.
In questa critica al rito elettorale ci sono elementi fondati, il consenso da solo non garantisce un sistema istituzionale e l’attuale selezione delle candidature non basta ad assicurare la capacità e la correttezza di chi potrebbe assumere la guida di uno Stato o di un governo. E nel mezzo mondo dove si andrà alle urne ci sono senz’altro paesi dove sono in gran parte negati libertà, progresso e gli altri valori che le democrazie dovrebbero assicurare. La soluzione non è però la delegittimazione che la sinistra politica e culturale sostiene, per esempio con l’editoriale odierno di Maurizio Molinari su Repubblica, intitolato “Democrazia contro populismo”. La negazione dell’avversario finisce per tagliare il ramo a cui la democrazia è appesa, al di là di qualche ragione che possa addurre, per esempio relativamente alla non candidabilità dell’ex presidente Usa oppure alla manifesta incapacità e senilità del presidente uscente.
Almeno a casa nostra, Dem e Cinque stelle dovrebbero avere capito che questa modalità di attacco politico non paga. Anche qui, talune accuse mirate sulle cattive prestazioni degli esponenti della maggioranza di governo possono avere ragione, ma in termini di consenso questo non fa grande differenza. Sarebbe più utile per tutti, in Italia come negli Stati Uniti, un confronto nel merito politico e non sull’avversario come persona, recuperando il laicismo liberale crociano. È quanto scrive in parte Avvenire, definendo il 2024 come “l’anno nero della democrazia”, ricordano che Mussolini e Hitler hanno preso il potere con il voto. Ma anche il quotidiano della CEI sbaglia nell’accusare di “antidemocrazia” paesi “populisti” o “sovranisti”, come l’Ungheria di Orban e il Brasile di Bolsonaro. Diverso sarebbe definirli “cattive democrazie”, entrando nel merito dell’azione di questi leader, se così si ritiene.