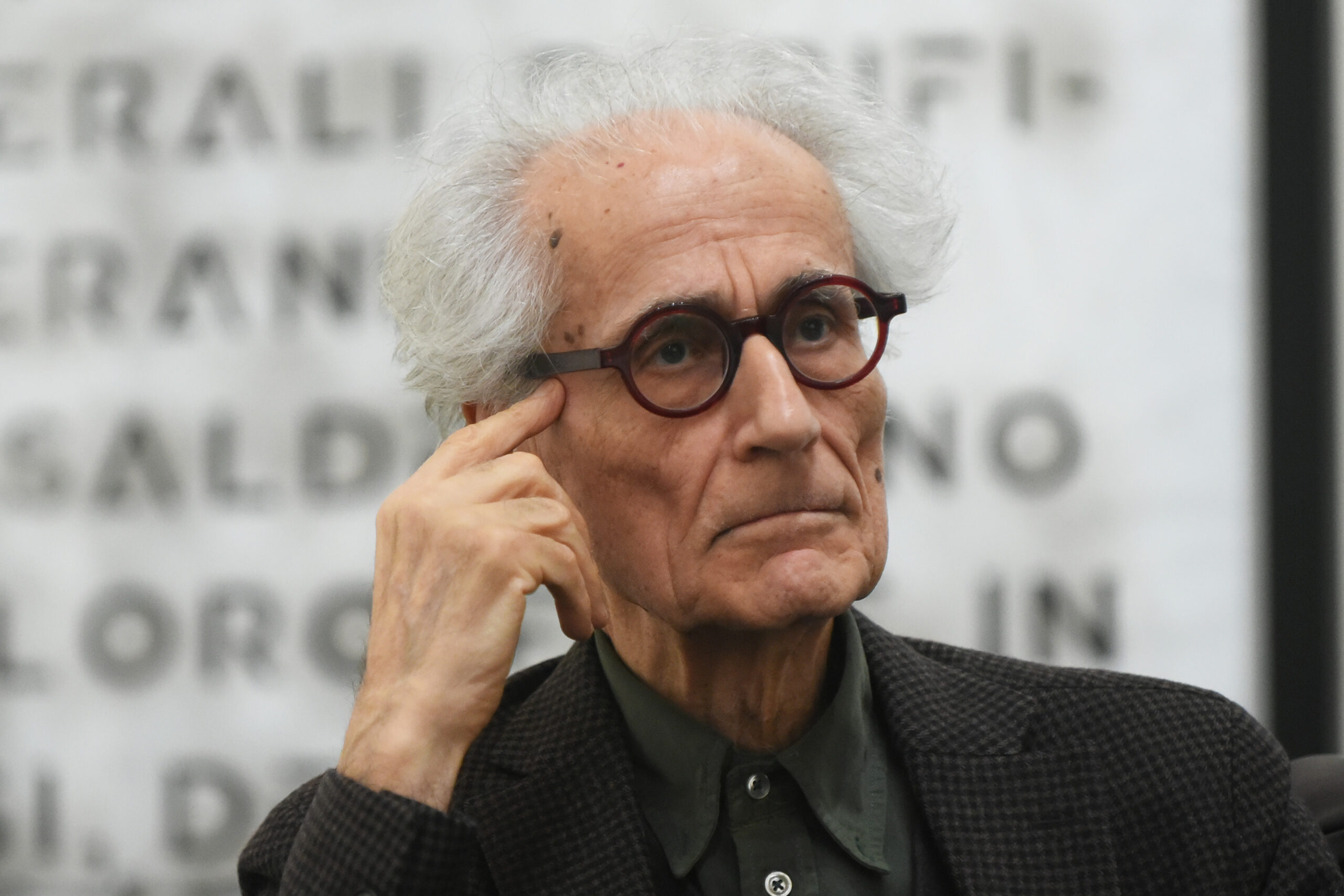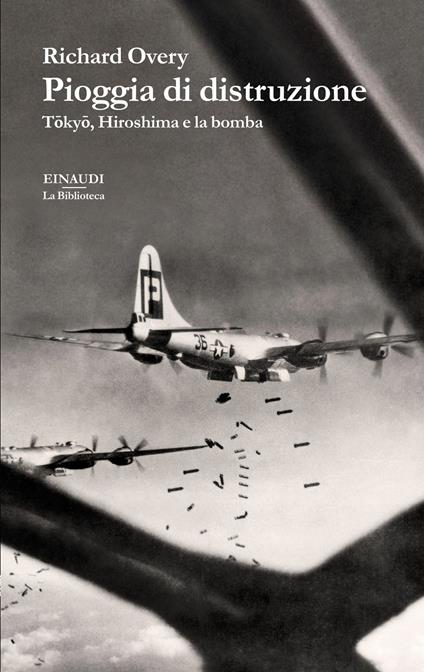A proposito della vicenda che ha condotto all’amministrazione giudiziaria per la prestigiosa azienda di abbigliamento Loro Piana, registriamo con stupore che si sta facendo spazio la leggenda metropolitana della Procura cattiva che colpisce l’azienda buona e senza colpe.
Già qualche giorno fa ci siamo permessi di dissentire, sostenendo l’infondatezza di questa tesi che è appunto una leggenda. Torniamo nuovamente sul tema solo perché su Fortune Italia è stato riproposto lo stesso copione, invero in modo ancor più discutibile. Il problema è che «Le motivazioni illustrate dal Tribunale di Milano, così come per gli altri casi, non convincono del tutto. Non è chiaro come si possa ritenere Loro Piana responsabile delle condizioni di lavoro presenti nelle società appaltatrici e sub-appaltatrici. Le eventuali situazioni di sfruttamento del lavoro nella catena produttiva dovrebbero finire in capo alle aziende che hanno messo in atto la condotta illecita».
La mancanza di “chiarezza” per l’autore è forse attribuibile alla mancanza di conoscenza della genesi e della natura dell’articolo 603-bis del Codice Penale. C’è una montagna di prassi e giurisprudenza, la cui lettura, seppure parziale, avrebbe potuto aiutarlo nella comprensione del ragionamento della Procura milanese. Quella norma cosiddetta anti-capolarato, è stata introdotta nel 2011 in conseguenza del tragico decesso in Puglia di una bracciante agricola, per colpire situazioni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. È stata poi significativamente riformata nel 2016 e la giurisprudenza ne ha esteso l’applicazione anche al di fuori del settore agricolo, per il quale era stata originariamente concepita.
Le pene sono rilevanti (fino a 6 anni di reclusione e sanzioni accessorie fino alla confisca dell’azienda) ma i presupposti (indici di sfruttamento) che devono essere integrati per il reato sono abbastanza specifici. Anche se per il datore di lavoro è sufficiente che ci sia “dolo generico”, cioè la mera consapevolezza dello sfruttamento dei lavoratori. Indubbiamente si tratta di uno strumento molto potente in mano alle Procure, il cui uso disinvolto potrebbe produrre danni irreparabili all’esistenza stesse delle aziende coinvolte. L’esistenza di una (anche lunga) catena di appalti e sub-appalti non costituisce affatto schermo sufficiente per mettere al riparo il committente principale dal commettere il reato. Altrimenti sarebbe fin troppo semplice aggirare la norma, utilizzando a ripetizione schermi societari. È ovviamente massima la libertà dell’imprenditore di organizzarsi decentrando alcune funzioni aziendali in imprese autonome – come quasi sempre accade nel settore dell’abbigliamento – ma ciò non lo solleva dall’obbligo di sorveglianza e diligenza, sia generica che specifica.
Tutte attività per le quali non sono richieste particolari abilità investigative: gli addetti al controllo qualità dei grandi marchi sono costantemente presso i loro fornitori e gli indici di sfruttamento previsti dalla legge sono rilevabili anche a un non addetto ai lavori. Basta guardarsi intorno quando si entra in uno stabilimento di produzione. Leggere che «eventuali situazioni di sfruttamento del lavoro nella catena produttiva dovrebbero finire in capo alle aziende che hanno messo in atto la condotta illecita», significa semplicemente non sapere di cosa si sta parlando.
Per non parlare poi del ribaltamento delle parti con cui termina l’articolo. È colpa della Procura se si verifica una “perdita di valore a causa del rallentamento produttivo e della perdita di clienti”. I “danni reputazionali” e la perdita di competitività del made in Italy nel campo della moda” con “migliaia di posti di lavoro a rischio” e “aziende che potrebbero delocalizzare la produzione in Paesi dove la manodopera costa meno”, sono ascrivibili allo straripante attivismo della Procura. Noi obiettiamo che – se fossero confermate le accuse della Procura e quindi fossero accertati come veri i fatti previsti dal 603-bis – è stata l’azienda committente, nella sfrenata ricerca del profitto e del minor costo di produzione, a danneggiare sé stessa con una condotta improvvida, mettendo essa a rischio la reputazione aziendale e la propria competitività.
Ma poi con quale coraggio e serietà si avanza la tesi della delocalizzazione? Davvero vogliono farci credere che per capi di abbigliamento venduti a peso d’oro con margini immensi, sia rilevante il costo della manodopera, al punto da andare a produrre in Lesotho (un Paese a caso)? Oppure, ancora peggio, ammettendo la rilevanza del costo del lavoro e che quindi si possa decidere di localizzare in Paesi a più basso costo della manodopera, si riconosce il fatto che in Italia sono stati consapevolmente compressi i diritti dei lavoratori per contenere il loro costo, e quindi le ipotesi della Procura sono fondate?
Quando si dice che la pezza è peggio del buco.